Iran, attacco hacker alla tv di Stato: in onda l’appello del principe Reza Pahlavi



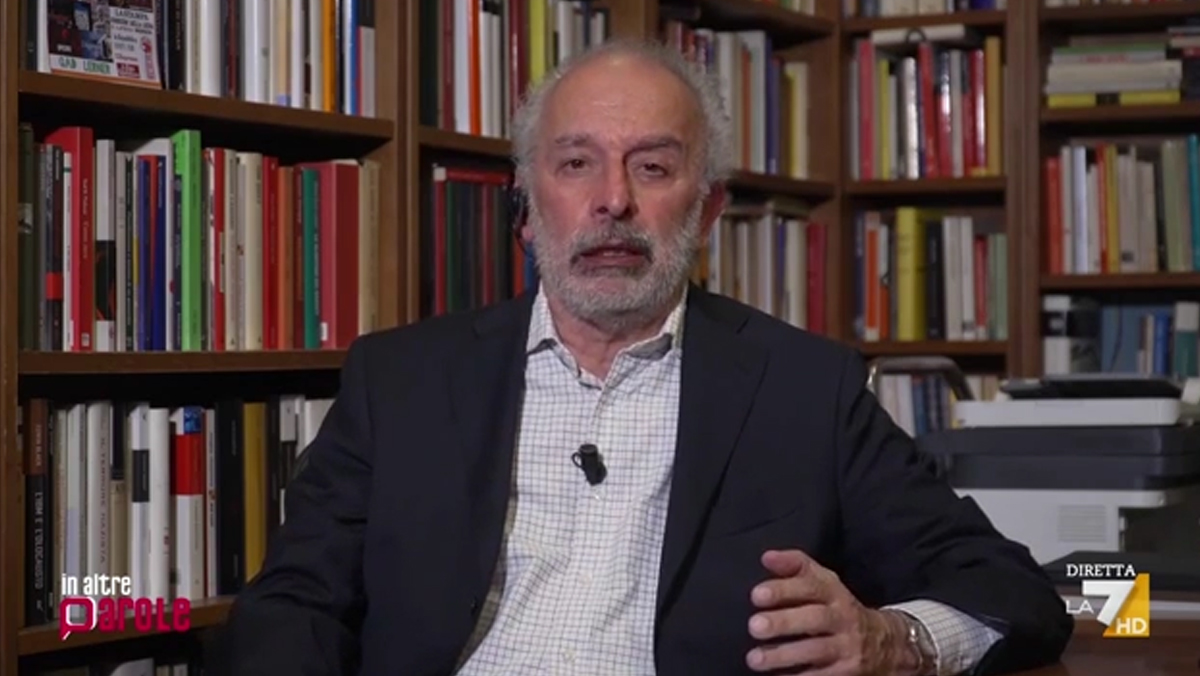

“Colpa di Donald Trump“: così Piers Morgan, scherzando, dopo una caduta. Il conduttore si trova ricoverato in ospedale, come si vede dalla foto postata sul profilo X. Nel post, Morgan racconta una successione degli eventi quasi da ‘fumetto’: “1. Sono inciampato su un piccolo gradino. 2 In un ristorante di un hotel a Londra. 3 Femore fratturato. 4. Così male che ho avuto bisogno di un’anca nuova. 5. Convalescenza in ospedale. 6. Stampelle per 6 settimane. 7. Niente spostamenti lunghi per 3 mesi. 8. Partenza scoppiettante per il nuovo anno”. Ed è qui che arriva il punto 9: “Do la colpa a Donald Trump”. La caduta ha causato a Morgan una frattura all’anca, rendendo necessario un intervento chirurgico e un periodo di recupero.
Piers Morgan è giornalista e conduttore televisivo britannico tra i più noti e controversi del panorama mediatico anglosassone. Sessant’anni, ex direttore di tabloid come Daily Mirror e News of the World, Morgan è oggi volto e ideatore di Piers Morgan Uncensored, talk show di commento politico e culturale seguito soprattutto nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Negli anni è diventato una figura polarizzante anche per il pubblico internazionale per le sue posizioni su temi di attualità, costume e politica.
L'articolo “Sono inciampato in un piccolo gradino. Femore fratturato. Ho avuto bisogno di un’anca nuova… Do la colpa a Donald Trump”: il racconto di Piers Morgan proviene da Il Fatto Quotidiano.
“Ho amato anche più del necessario, ho fatto il dovuto e lo straordinario”. Con queste parole di Ornella Vanoni ieri sera, 18 gennaio, si è concluso l’evento musicale “Ornella Senza Fine“, in onda sul Nove. Ma quello che si è consumato non è stata solo una magnifica serata di musica e parole, ma anche una lezione di vita. Ornella Vanoni ha lasciato una grande eredità con le sue canzoni, ma soprattutto con la sua vita vissuta sulle montagne russe dei sentimenti. L’elemento fondamentale per l’essere umano è e rimane la libertà. Libertà di amare, di sbagliare, di inciampare e di rialzarsi nel momento giusto. Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e il suo team di “Che Tempo Che Fa” hanno fatto un lavoro che va al di là dei tecnicismi televisivi. È raro che una emozione abbatta la quarta parete della televisione ormai diventata asettica. E ieri è accaduto, questo anche grazie a molti dei colleghi ed amici intervenuti per rendere omaggio alla grande artista.
Sulle note di “Senza Fine” è stato Marco Mengoni ad aprire la serata. Un inizio elegante, in salsa jazz con una delle canzoni più belle della storia della musica italiana. L’accoppiata Paolo Fresu-Mengoni strepitosa. La bellezza della musica e di Ornella che commuovono sempre. “Gino questa canzone l’ha composta per me, ma non trovava le parole giuste. Un giorno è venuto da me con le mani piene di foglietti e mi ha detto ‘scegli tu’. Io ho scelto le parole che mi somigliavano di più”. Questa la spiegazione di Ornella sulla celebre canzone, letta dal nipote Matteo.
Loredana Bertè struggente già con l’incipit “è uno di quei giorni che ti prende la malinconia”. La voce potentissima di Annalisa, l’interpretazione minimal e intensa di “Una ragione di più” ad evidenziare ogni parola e l’importanza del testo scritto nel 1970, ma sempre attuale… Con il rosso che Ornella amava molto. Non poteva mancare Virginia Raffaele. Quello tra l’attrice e Ornella Vanoni è stato un intreccio artistico, al di là dell’imitazione. La Raffaele aveva colto la grande ironia e la libertà della grande artista, spingendole ancora più in altro. Da uno dei dischi più belli della storia della musica, l’omaggio di Fiorella Mannoia con Toquinho con “La voglia la pazzia”. Sia la Mannoia che la Vanoni sono accomunati dall’amore per la musica brasiliana e il Brasile “A questo punto Buonanotte all’incertezza”…
“Sant’Allegria” nella versione di Mahmood con la Vanoni è un piccolo gioiello. Ornella Vanoni era pazza di lui: “Questo ragazzo qui lo amo, è come se lo conoscessi da sempre”. Bello il momento in studio con la voce fuori campo della grande interprete. Poi il momento tanto atteso. “Cantante, artista e donna libera“. La città di Milano alla presenza del sindaco Sala e dell’Assessore Sacchi ha dedicato così con una targa l’aiuola che si trova davanti al Piccolo Teatro Strehler.

“Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già…” Paolo Fresu alla tromba ha omaggiato la sua amica Ornella su una delle sue canzoni più iconiche “L’appuntamento”. Lo aveva fatto al suo funerale e questa sera provoca la stessa emozione. Poi la preziosa Elisa ha fatto da cornice a un momento di struggente commozione.
Un addio generoso, ricco d’amore e di dolcezza. “Ti lascio una canzone” è uno dei brani più belli di Gino Paoli che solo lui e Ornella sapevano rendere magica, specie insieme. Gianni Morandi è riuscito a farne un omaggio in punta di piedi pieno di affetto. La letterina di Luciana Littizzetto tutta dedicata ad Ornella nel ricordarla per le sue interminabili telefonate, con ironia e affetto. “E se lassù non riesci a dormire, chiedi pure perché qualcuno che sa rollare, lo trovi sicuro”, ha chiosato l’attrice.
Il Piccolo Teatro Grassi, dove Vanoni ha mosso i primi passi come attrice, apre le porte per un omaggio collettivo tra attori da Lella Costa a Angela Finocchiaro con al piano Paolo Jannacci. Ovviamente la canzone scelta è “Ma Mi“. Un bellissimo gesto simbolico. “Imparare ad amarsi” è la bella canzone firmata con Bungaro e Pacifico, una delle più belle della Vanoni. Interpretazione vibrante di Emma che ne ha sottolineato l’importanza delle parole.
“Rossetto e cioccolato” è una delle canzoni più iconiche del repertorio della Vanoni. Sensuale e ironica: “La gola è soddisfatta e nella stanza il cielo. Si fa così per cominciare il gioco”. Brava Malika Ayane a farla “sua”. Non facile. Il più grande regalo che Ornella Vanoni ha ricevuto, musicalmente parlando, negli ultimi ani è stato “Un sorriso dentro al pianto”, la canzone più bella scritta da Francesco Gabbani. Molto bello il duetto con Noemi, già proposto all’evento “Una Nessuna Centomila”. L’incantevole voce di Arisa su “La musica è finita” “Un minuto è lungo da morire. Se non è vissuto insieme a te” da standing ovation. Toquinho e Sangiorgi su uno dei pezzi iconici dell’album cult “La voglia la pazzia l’incoscienza…”: “Io so che ti amerò”. Il sentimento e il feeling in ogni nota. L’eleganza e la sobrietà di Diodato e della nipote dell’artista Camilla su “Senza Fine” chiudono la carrellata delle esibizioni.
Il canale Nove con “Ornella Senza Fine” per la prima volta ha offerto un evento che nulla ha da invidiare ai diretti competitor. Una serata di alta qualità e davvero emozionante. Su tutti l’arte, la forza e la libertà di Ornella Vanoni che vivrà per sempre.
L'articolo “Ornella Senza Fine” è stato un piccolo miracolo: l’evento televisivo che si trasforma in lezione di vita e d’amore. Mengoni, Mahmood, Emma e Annalisa emozionati proviene da Il Fatto Quotidiano.
“Ho sbagliato a dire i miei giocatori di lasciare il campo. Chiedo scusa al mondo del calcio”. Così Pape Thiaw – allenatore del Senegal – a mente serena dopo la vittoria della sua nazionale in finale di Coppa d’Africa contro il Marocco grazie al gol di Pape Gueye ai supplementari. Perché le scene viste sono obiettivamente inaccettabili: al 92esimo a Mané e compagni viene annullato per un fallo il gol che probabilmente sarebbe valso la vittoria. Una decisione discutibile, penso ci siano pochi dubbi. Poi qualche minuto dopo un rigore assegnato altrettanto discutibile e lì scoppia il caos.
Perché l’arbitro sicuramente qualche errore ha commesso, ma la reazione del Senegal non ha senso. Tutti negli spogliatoi per protesta prima che si calciasse il rigore, un quarto d’ora circa d’interruzione e poi Mané – l’unico a rimanere in campo – a richiamare i compagni e invitarli a rientrare. “Gli errori di un arbitro si devono accettare, ma sul momento non ho riflettuto e li ho fatti rientrare. A volte si può reagire nel modo sbagliato nella foga del momento”, ha dichiarato Thiaw.
Anche perché da quel momento lì chiunque si è quasi sentito in diritto a fare di tutto: disordini sugli spalti, gente che ha cercato l’invasione, risse e discussioni in campo. Insomma, non uno spot bellissimo per il calcio africano. Tutto sotto gli occhi del presidente Fifa Gianni Infantino, che in un primo momento ha minimizzato tutto: ha premiato i vincitori tra mille sorrisi, ha consolato Brahim Diaz, come se non fosse accaduto nulla. A distanza di ore – con una nota – ha poi attaccato il Senegal.
“Purtroppo abbiamo assistito a scene inaccettabili sul campo e sugli spalti: condanniamo fermamente il comportamento di alcuni ‘tifosi’, nonché di alcuni giocatori senegalesi e membri dello staff tecnico. È inaccettabile abbandonare il campo di gioco in questo modo e – allo stesso modo – la violenza non può essere tollerata nel nostro sport, semplicemente non è giusto”, ha dichiarato Infantino.
“Dobbiamo sempre rispettare le decisioni prese dagli arbitri dentro e fuori dal campo di gioco. Le squadre devono competere sul campo e nel rispetto delle regole del gioco, perché qualsiasi comportamento contrario mette a rischio l’essenza stessa del calcio”, ha spiegato Infantino.
È stato un peccato, perché il livello tecnico e agonistico visto in questa Coppa d’Africa è stato altissimo. Rispetto a diversi anni fa le nazionali africane hanno acquisito maggior credibilità a livello internazionale grazie a un lavoro incessante su vari fronti, che ha portato vari paesi ad avere giocatori di caratura internazionale, a esprimere un bel calcio e a dire la sua anche ai Mondiali: “È anche responsabilità delle squadre e dei giocatori agire in modo responsabile e dare il buon esempio ai tifosi negli stadi e ai milioni di spettatori in tutto il mondo – ha concluso Infantino -. Le brutte scene a cui abbiamo assistito oggi devono essere condannate e non devono mai più ripetersi. Ribadisco che non hanno posto nel calcio”.
L'articolo Coppa d’Africa, Infantino prima premia il Senegal e poi lo attacca: “Assistito a scene inaccettabili”. Il teatrino delle scuse dopo la farsa proviene da Il Fatto Quotidiano.
“Ero a bordo e ho sentito un impatto molto forte. Il treno è uscito dai binari e, inclinandosi di lato, tutte le valigie hanno iniziato a caderci addosso, insieme ai vetri, a tutto”. Sono drammatiche le testimonianze dei passeggeri che erano a bordo dei treni Iryo e Alvia, coinvolti in un incidente all’altezza di Cordoba che ha ucciso 39 persone nella sera del 18 gennaio. A raccontare a Cadena Ser cosa è successo è Yuri: “C’era gente gravemente ferita, a una ragazza si è aperta la testa”. La giornalista ha raccontato di essere arrivata con una delle prime ambulanze che dal luogo del disastro sono partite verso l’ospedale Reina Sofia di Cordoba, la struttura che ha ricevuto il maggior numero di feriti. “Sono molto colpita psicologicamente per tutto ciò che ho visto e per quello che ho dovuto passare in quel vagone”, ha detto la ragazza. Alla sua voce si aggiunge quella di María Jiménez che, parlando alla Radio Nacional de España, ha detto: “Sembrava un film dell’orrore”. Era a bordo della carrozza quattro dell’Iryo – e non in quelle successive che sono deragliate – e ha riferito di avere avuto un attacco di panico. “È il tipo di esperienza che pensi di non dover mai provare “.
Juan José e Gerardo sono di Huelva, città dell’Andalusia, dove era diretto il treno di Renfe, colpito dal convoglio Iryo. “Abbiamo sentito una tremenda scossa in frenata – hanno raccontato ad Abc -, siamo corsi fuori e siano riusciti a usare i nostri cellulari. Per i tre vagoni prima di noi è stato terrificante”. Secondo quanto riportato dal giornalista Francisco Poyato, i due sono riusciti a recuperare i loro effetti personali grazie ai cellulari. Il giornalista Chema Rodríguez ha descritto su El Mundo uno scenario spaventoso, con immagini di sedili scaraventati via, feriti che attraversano i binari e persone che escono dai tetti e dai finestrini dei vagoni. “Ci vorrà un po’ prima che io possa salire di nuovo su un treno “, ha dichiarato una donna all’inviato del quotidiano.
“Mia figlia mi ha chiamata alle 19,45 piangendo, sconvolta, dicendo che il treno era deragliato. Al momento non c’era copertura. Io sono venuto qui in stazione, direttamente alla Renfe (l’ente di gestione ferroviario, ndr). “Non sapevano nulla. Hanno chiamato il 112 e avvisato che c’era stato un incidente. Hanno cominciato a chiamare il macchinista del treno, i controllori, nessuno rispondeva. Quello che mi ha lasciato basita è che hanno chiuso l’ufficio e sono corsi via e ci hanno lasciato qui senza notizie. Mi è sembrata una follia”, ha raccontato nella notte la madre di una ragazza che viaggiava nel vagone numero 4 del treno di lunga percorrenza Alvia. In dichiarazioni all’emittente pubblica Tve, la donna ha raccontato i drammatici momenti delle prime notizie ricevute dell’incidente dalla figlia sopravvissuta. “Mia figlia mi ha detto che erano riusciti a uscire dal vagone, ma che c’erano molti morti. I passeggeri erano soli, al buio, non erano ancora arrivati i soccorsi né la polizia. Grazie a Dio lei l’ha potuto raccontare. Ora è al centro di emergenza allestito per il triage ai feriti”.
L'articolo “Soli, al buio e circondati dai morti. Vetri e valigie ci sono caduti addosso”: i racconti dei sopravvissuti all’incidente di Adamuz proviene da Il Fatto Quotidiano.
di Rosamaria Fumarola
Chissà se è un bene la condivisione ad libitum di immagini e filmati girati in autonomia e la loro visione aperta al pubblico come un tempo si faceva solo con le pellicole cinematografiche e i servizi giornalistici. Non v’è dubbio alcuno che spesso da un punto di vista probatorio, nel caso di vicende che abbiano prodotto conseguenze penali, l’utilizzo di questi file possa condurre ad un accertamento più veloce delle responsabilità. Spesso, ma non sempre. Nel caso della morte di Riccardo Magherini avvenuta a Firenze nel 2014 ad esempio, nonostante registrazioni e filmati che narravano i fatti per quelli che erano, la giustizia italiana ha preferito scegliere vie traverse piuttosto che percorrere il sentiero più semplice, quello della verità.
La cultura, la politica e tutte le sovrastrutture di una civiltà antica come la nostra sono oggi ormai lontane dai bisogni concreti che un tempo le hanno generate. Resta comunque al centro l’uomo, più lontano e in ombra, ma la sua esistenza è quella che continua ad animare i giorni e quindi la storia e soprattutto resta la sacralità che la nostra civiltà è stata in grado di tributare ad alcuni momenti della vita umana, a prescindere dal loro inquadramento in una dimensione religiosa. Anche per questo fu oltraggiosa l’incapacità di ascoltare le parole urlate da Riccardo Magherini quella notte del 3 marzo 2014, quando sotto il peso dei carabinieri che seduti su di lui lo immobilizzavano trovava la forza per gridare: “Non respiro, sto morendo, ho un figlio.”
La serata di Riccardo era stata agitata, aveva assunto cocaina e aveva creato problemi agli abitanti di Borgo San Frediano. C’erano state delle segnalazioni, l’intervento della forza pubblica si era reso necessario e si era concluso con l’immobilizzazione di Magherini da parte degli agenti, che lo avevano schiacciato sull’asfalto fino a rendergli impossibile respirare. “Non respiro, sto morendo, ho un figlio” poi il silenzio, quello più lungo, quello della morte. Parole non diverse da quelle pronunciate da George Floyd a Minneapolis, dopo l’intervento della forza pubblica conclusosi allo stesso modo, con la morte di chi doveva essere in primo luogo tutelato, se del caso anche da se stesso.
Di questi uomini restano le richieste di aiuto condivise da migliaia di cellulari, richieste che ci interrogano sul significato di ciò che siamo e che inevitabilmente ci cambiano. Gli accusati della morte di Riccardo Magherini non sono stati ritenuti responsabili della sua morte in tutti e tre i gradi di giudizio previsti dal nostro ordinamento. La sua famiglia vivrà per sempre una insanabile mutilazione.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a cui è stato fatto ricorso si è pronunciata tuttavia condannando lo Stato italiano, valutando all’unanimità che aver tenuto il giovane immobilizzato a terra anche dopo che aveva smesso di reagire era stato assolutamente non necessario.
Il padre di Riccardo ha dichiarato di aver pianto dopo la pronuncia della sentenza. Forse avrà pensato che smetteranno da ora in poi di considerarlo un folle che non comprende che le forze dell’ordine hanno agito nel miglior modo possibile e che non avrebbero potuto salvare Riccardo. Si sarà sentito riabilitato come accade ai familiari morti per mano dello Stato, troppi, sui quali finisce spesso paradossalmente per cadere la responsabilità morale della tragedia perché ritenuti responsabili in solido con i cari persi dell’esito degli eventi.
Tanti di noi avranno visionato quegli ultimi momenti di vita di Riccardo e come me si saranno chiesti cosa avrebbe potuto fare di più se non pronunciare quelle ultime parole, per comunicare che la vita lo stava abbandonando. Tanti come me avranno tentato di frenare il dolore immaginando quell’ultimo pensiero di Riccardo, quel sapere che suo figlio non lo avrebbe mai più rivisto e si saranno interrogati sul significato della vita e forse come me si saranno sentiti soli perché di fianco e dentro avranno cercato senza trovare un senso.
L'articolo La Cedu condanna l’Italia per la morte di Riccardo Magherini: chissà quanti come me si sono sentiti soli proviene da Il Fatto Quotidiano.
Che la soglia dell’attenzione dell’utente medio delle piattaforme in streaming sia bassa, questo si sa. Una pubblicità, una notifica di Whatsapp o una mail urgente alla quale rispondere, creano la visione di un film o una serie tv frammentata. Così ci si ritrova a riprendere il filo della narrazione, una volta esauriti i compiti improvvisi e bypassate le distrazioni, senza ricordarsi cosa stesse accendendo proprio nel punto in cui si è interrotto lo streaming.
Così Netflix è corsa ai ripari e ha chiesto agli sceneggiatori dei suoi film di inserire in alcuni punti un protagonista che faccia da raccordo e ripeta, in qualche modo, la trama principale del film. A rivelarlo è stato Matt Damon, durante la presentazione del film Netflix “The Rip – Soldi sporchi”, che lo vede protagonista con il collega e amico di sempre Ben Affleck.
L’attore in una intervista al programma Joe Rogan Experience, ha tracciato un bilancio del mondo del cinema e di come esso sia cambiato proprio in virtù del proliferare delle piattaforme in streaming.
“Gli spettatori dedicano a un film a casa un livello di attenzione molto diverso rispetto alla sala cinematografica, – ha detto Damon -. Netflix tende a spostare le scene d’azione all’inizio del racconto, per catturare subito il loro interesse. Dietro le quinte, si discute della possibilità di ripetere la trama tre o quattro volte nei dialoghi, tenendo conto del fatto che molti spettatori guardano il film mentre sono al telefono”.
E ancora: “Abbiamo imparato che il modo tradizionale di costruire un film d’azione prevede di solito tre grandi scene: una nel primo atto, una nel secondo e una nel terzo. La maggior parte del budget viene investita in quella del terzo atto, perché è il finale. Ora invece ti chiedono: ‘Possiamo farne una enorme nei primi cinque minuti? Vogliamo che la gente resti incollata’. E non sarebbe male se ripetessi la trama tre o quattro volte nei dialoghi, perché la gente guarda il film mentre è al telefono”.
Poi ci sono le doverose eccezioni. “Non sempre le produzioni Netflix si piegano alle regole del mercato – ha aggiunto Affleck -. Guardi Adolescence e ti accorgi che non fa niente di tutto questo. Ed è fottutamente fantastica. Ed è anche cupa: tragica e intensa. Racconta di un uomo che scopre che suo figlio è accusato di omicidio. Ci sono lunghe inquadrature della nuca dei due personaggi. Salgono in macchina, nessuno dice una parola”.
“The Rip – Soldi Sporchi”, disponibile su Netflix già dal 16 gennaio, mette al centro la fiducia tra una squadra di poliziotti di Miami che inizia a vacillare dopo aver scoperto milioni di dollari in contanti in un deposito abbandonato. Quando forze esterne vengono a conoscenza dell’entità del sequestro, tutto è messo in discussione, incluso di chi potersi fidare.
L'articolo “Netflix vuole che nei film si ripeta la trama 3 o 4 volte, perché la gente sta al telefono mentre guarda” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Claudio Agostino Carlomagno, 45 anni, il marito di Federica Torzullo fermato domenica per omicidio, ha cercato di depistare le indagini con una serie di bugie e versioni inventate, che hanno solo nei primi momenti ingannato gli investigatori. Ma le prove, tra cui i dati del GPS e i riscontri sui suoi spostamenti, hanno insorabilmente e svelato la verità, portando alla scoperta del corpo della 41enne, sepolto in un terreno vicino alla villetta della coppia.
Già la denuncia, formalizzata il 9 gennaio, presentava un’anomalia. L’uomo aveva raccontato che la donna era uscita di casa la mattina presto, senza prendere la macchina, che lui aveva trovato parcheggiata fuori. Una versione che ha sollevato immediatamente dei dubbi, visto che Federica, descritta come una persona precisa e puntuale, non avrebbe mai agito in modo così improvviso e senza lasciare tracce. Carlomagno ha aggiunto altri dettagli inverosimili: “Non abbiamo dormito insieme perché io russo e le impedisco di riposare, quindi lei si trasferisce in camera di nostro figlio”. Tuttavia, i primi accertamenti delle forze dell’ordine hanno subito messo in crisi questa ricostruzione. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato l’ingresso di Federica in casa la sera dell’8 gennaio intorno alle 23 e il suo rientro non è stato seguito da alcuna uscita.
Inoltre, il comportamento di Carlomagno quel giorno ha suscitato ulteriori sospetti. Nonostante la gravità della situazione, il 45enne si è mostrato eccessivamente tranquillo. Alle 8 del mattino, Carlomagno ha preso il telefono della moglie e ha inviato un messaggio Whatsapp alla madre di Federica, cercando di depistare le indagini: “Tutto bene, non preoccuparti”. Poco dopo, mentre il caso della scomparsa di sua moglie stava per diventare di dominio pubblico, Carlomagno ha scherzato con i suoi dipendenti al lavoro, dicendo: “Abbiamo fatto delle misurazioni in giro. Poi ci vediamo lunedì. Sembrava non fosse successo nulla”.
Le indagini hanno preso una piega più chiara quando sono stati esaminati i dati GPS relativi agli spostamenti di Carlomagno. Il 9 gennaio, il 45enne aveva compiuto numerosi spostamenti tra i terreni gestiti dalla sua azienda, senza alcuna giustificazione plausibile. Inoltre, sono state trovate tracce di sangue sia nel camion utilizzato da Carlomagno, sia nella sua abitazione, e un testimone ha riferito di aver visto l’uomo lavare il cassone del mezzo il pomeriggio del 9 gennaio.
Anche la testimonianza di un’amica e collega di Federica ha contribuito a chiarire la situazione. La donna ha dichiarato che Federica era una persona “seria, precisa e ligia al dovere” e che non avrebbe mai abbandonato il lavoro senza avvisare. Inoltre, il 9 gennaio, Federica non si era presentata al lavoro come previsto e non aveva dato alcuna giustificazione. La collega ha anche sottolineato che Federica si teneva sempre in contatto con la madre e che, in quella giornata, la madre non aveva ricevuto alcuna telefonata da parte della figlia, come accadeva di solito.
L'articolo Il messaggio Whatsapp alla madre di Federica Torzullo e le bugie sulla scomparsa, così Claudio Carlomagno ha tentato di depistare le indagini proviene da Il Fatto Quotidiano.
Migliaia di sfollati curdi sti stanno spostando verso Qamishli, principale città curda nel nord-est della Siria, dopo che l’esercito governativo ha conquistato vaste aree del nord del Paese. L’avanzata delle forze di Damasco ha portato alla perdita di territori che per oltre un decennio erano rimasti sotto il controllo delle forze curde, garantendo di fatto un’ampia autonomia. Nella città si sono svolte manifestazioni contro l’estensione del controllo dell’esercito siriano.
L'articolo Siria, l’esercito di Damasco avanza nel nord del Paese: migliaia di sfollati curdi verso la città di Qamishli proviene da Il Fatto Quotidiano.
Clizia Incorvaia è stata ospite a “Verissimo”, ieri 18 gennaio, e ha rivelato a Silvia Toffanin un episodio doloroso della sua vita: “Tre anni fa ho avuto un aborto in treno, mentre stavo accompagnando mia figlia Nina dal padre a Milano. Ebbi questa emorragia perché ero troppo sotto stress“. L’influencer è stata prosciolta dalle accuse di Francesco Sarcina, che l’aveva denunciata, accusandola di aver pubblicato sui social immagini della loro figlia minore per “trarne un profitto economico”.
“Questa sentenza mi ha restituito dignità come madre. – ha detto Incorvaia – Ho sempre protetto mia figlia Nina (avuta dal cantante nel 2015, ndr) , l’ho sempre preservata. Ma questa accusa aveva gettato un alone su di me come genitore. Oggi i nostri rapporti sono freddi, distaccati”.
E ancora: “Non era un rapporto sano. Per tanto tempo ho pensato di potermi accontentare di questo tipo di relazione. Poi, quando è venuto meno il rispetto della mia persona, ho capito che dovevo prendere le distanze (…) Mi bruciò 60 paia di scarpe dopo dei litigi. Non denunciai per proteggere Nina”.
Ha fatto clamore poi il presunto tradimento della Incorvaia con Riccardo Scamarcio, ex amico di Sarcina: “Eravamo separati. Ero una donna separata e potevo fare tutto quello che volevo. Ho una visione troppo bella dell’amore per prendere delle vie sotterranee”
“A marzo saremo di nuovo in udienza, – ha continuato l’ospite – verranno ristabilite delle cose sulla gestione di nostra figlia affinché non ricada tutto su un solo genitori. Oggi provvedo io alla sua scuola privata e anche ai weekend che passa con il papà. Il giudice aveva stabilito che Nina passasse due weekend con il padre su Milano a carico mio e un weekend su Roma a carico del padre perché lui dovrebbe prendere una stanza in hotel per stare con la figlia. Di weekend su Roma ne ha fatto uno in cinque anni. Mi trovo sempre io a portare Nina da lui a Milano“.
L'articolo “Francesco Sarcina mi bruciò 60 paia di scarpe dopo dei litigi. Non denunciai per nostra figlia. Tre anni fa un aborto in treno per troppo stress”: così Clizia Incorvaia proviene da Il Fatto Quotidiano.
Un incidente tragico, costato la vita a 39 persone, e che ne ha lasciate ferite 152 – di cui 48 in ospedale e trenta in gravi condizioni -, avvenuto “inspiegabilmente” – dice il ministro dei Trasporti Oscar Puente – in un rettilineo, su una tratta rinnovata di recente. La Spagna indaga sull’incidente avvenuto la sera del 18 gennaio, alle 19.39, tra due treni sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia all’altezza di Adamuz (Cordova). Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, ci sono stati almeno 21 morti e 22 feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402). Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia (900101020), che si stava dirigendo a Huelva. I vigili sono rimasti tutta la notte con le squadre di emergenza e una quarantina di militari dell’Unità di protezione civile dell’Esercito a lavorare per estrarre i superstiti dalle lamiere. Secondo quanto emerge, per i tecnici spagnoli il deragliamento potrebbe essere legato a un giunto che prima dell’incidente è saltato creando uno spazio tra due sezioni di binario che via via si è allargato al passaggio dei treni. L’ipotesi è che le prime carrozze dell’Iryo siano passate mentre lo spazio si allargava finché, arrivate all’ottava, è avvenuto il deragliamento. L’ottava carrozza avrebbe portato con sé anche la sesta e la settima. A bordo dei due convogli c’erano circa 500 persone, 300 sul treno Iryo Málaga-Madrid e 184 en sull’Alvia Madrid-Huelva. Tra i ricoverati ci sono 11 adulti e un minore in terapia intensiva. Sono invece 74 i feriti che sono già stati dimessi.
Le linea rinnovata e i dubbi del ministro – Puente ha spiegato che i primi due vagoni dell’Alvia, con 63 passeggeri complessivi a bordo, “sono precipitati in un terrapieno” di circa cinque metri. “Tra i due convogli, l’Alvia è quello che ha avuto la peggio” nel deragliamento. Puente non ha dato indicazioni sulle possibili cause, ma ha rilevato che “l’incidente è stato estremamente strano”, in quanto si è verificato “su un tratto retto, su una linea rinnovata di recente” e ha coinvolto un treno di Iryo “praticamente nuovo”. “Lo stato della via ferroviaria era buono”, ha ribadito. “Stiamo parlando di materiali nuovi”, ha aggiunto, ricordando che sulla tratta Andalusia-Madrid sono stati investiti “700 milioni di euro e i lavori di sostituzione dei cambi dell’infrastruttura si sono conclusi a maggio, secondo Adif“, il gestore statale delle ferrovie. “Speriamo che l’inchiesta aiuti a chiarire le case dell’incidente, ha anche detto il titolare dei Trasporti. Quanto ai tempi di ripristino della linea di alta velocità, il ministro ha avvertito che “resterà interrotta almeno domani e probabilmente per un mese”. “Non solo bisogna ritirare il materiale, ma c’è un’inchiesta” aperta sulla sciagura “che richiede di intervenire sul terreno in tutta la sua profondità”, ha segnalato. Puente ha annunciato infine la creazione di una commissione d’inchiesta “completamente indipendente” per “stabilire cosa è successo e fare in modo che non accada mai più”.
La dinamica dell’incidente – La tragedia è avvenuta all’altezza di Adamuz, vicino Cordova, sud dell’Andalusia: un treno Iryo, con 317 passeggeri, diretto da Malaga a Madrid stazione Puerta de Atocha, è deragliato invadendo un altro binario e colpendo un convoglio diretto che circolava in direzione opposta, da Madrid a Huelva, deragliato a sua volta. Complessivamente sono state oltre un centinaio le persone ferite in maniera lieve medicate nell’ospedale da campo che è stato allestito ieri sera dai servizi di emergenza nel Posto Medico Avanzato in un edificio di Adif, nella stazione di Adamuz. Nella zona dell’incidente sono state mobilitate 4 unità del Dispositivo di terapia intensiva, 6 ambulanze con unità di rianimazione, due veicoli di appoggio logistico, cinque ambulanze convenzionali e 2 della Croce Rossa.
L'articolo Treni deragliati in Spagna, 39 morti. “Tra le ipotesi un giunto saltato dei binari”. Ministro dei Trasporti: “Incidente estremamente strano” proviene da Il Fatto Quotidiano.


© RaiNews


© RaiNews
© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews
I diritti di proprietà non sono immutabili ma emergono e si precisano quando il valore delle risorse aumenta. Le norme che li regolano devono però essere giuste, altrimenti diventano strumenti di esclusione e predazione. Vale anche nel caso dell’Artico.
L'articolo La posta in gioco nella contesa sulla Groenlandia proviene da Lavoce.info.
L'agenda internazionale e i suoi risvolti interni piombano sulla missione di Giorgia Meloni in Asia. Da Seul, in Corea del Sud, per la prima volta la premier dice che il presidente degli Stati Uniti sbaglia, offrendo un titolo facile ai giornalisti che la seguono in trasferta. Ma la premier non punta a marcare una distanza con Donald Trump, che ha annunciato dazi ai paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia, semmai il contrario. "Ho sentito sia Donald Trump qualche ora fa, al quale ho detto quello che penso" sia "il segretario generale della Nato che mi conferma un lavoro che" l'Alleanza "sta iniziando a fare", ha detto durante un punto stampa ieri, tratteggiando il lavoro da pontiera che sta cercando di costruire.
Il presupposto è netto: "La previsione di un aumento di dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza della Groenlandia è un errore e non la condivido", ha commentato senza titubanze. Ai giornalisti che hanno provato a indagare sul contenuto del colloquio telefonico con Trump ha risposto che non si può "farvi lo stenografico di quello che dico a un mio collega. Io credo – ha aggiunto – che in questa fase sia molto importante parlarsi" e che il presidente Trump "mi pare fosse interessato ad ascoltare". Tanto basta per ritagliarsi uno spazio e tentare il colpo della mediazione, nell'interesse di tutti. In serata Meloni sentirà anche i principali leader europei e Ursula von der Leyen. A rischiare sono Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno unito, Paesi Bassi e Finlandia. La quota annunciata da Trump è del 10 per cento, che potrebbe salire al 25 per cento fino alla conclusione di un accordo per l'acquisto della Groenlandia.
Così, se da una parte Meloni non indugia nel definire "un errore" la possibilità americana di inasprire la guerra commerciale, dall'altra con Trump parla di incomprensione. C'è stato "un problema di comprensione e comunicazione", ha precisato, perché l'iniziativa dei paesi europei di inviare piccoli contingenti militari nell'Artico – che da parte sua Meloni può dire di aver sempre rifiutato – non va letta in chiave "anti-americana" semmai "contro altri attori" come la Cina e la Russia. Gli stessi che preoccupano gli Stati Uniti. Ora quindi è tempo di "abbassare la tensione e di tornare a dialogare", insiste Meloni, e di "lavorare insieme per rispondere a una preoccupazione che ci coinvolge tutti". Tutti, o quasi. Almeno in Italia.
Il risvolto interno della questione, di cui i giornalisti hanno chiesto conto a Meloni, riguarda infatti l'alleato di governo Matteo Salvini. Secondo il leader della Lega, i paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia sono i "deboli d'Europa" che hanno la "smania" di inviare soldati e raccolgono i loro "frutti amari". "Non c'è un problema politico con la Lega su questo punto", ha detto Meloni ai cronisti che le hanno sottoposto la diversità di vedute, salvo poi abbandonare frettolosamente il punto stampa: "Grazie e arrivederci".


L’ho conosciuto grazie ad Alfred Jarry. Era il 1969. Lui un personaggio noto nel mondo dell’editoria ed io poco informato su quel signore ironico, pronto a fare l’esame a quanti gli si parassero davanti. Non si prevede mai l’esito di un proprio articolo di giornale. Quella volta la recensione all’opera del papà di Ubu ebbe un risultato telefonico inaspettato. «Sono Luciano Foà. Desidero ringraziarla dell’attenzione al nostro libro. Quando viene a Milano passi a trovarmi.» Foà era il «signor Adelphi». L’opera di Jarry di cui avevo scritto era il numero 21 della Biblioteca Adelphi, avviata nel 1965 con L’altra parte di Alfred Kubin. Oggi la collana ha superato abbondantemente i cinquecento titoli.*
Immutata la sofisticata grafica discesa dal Yellow Book di Aubrey Beardsley. Allora l’Adelphi si considerava ancora una «piccola casa editrice», anche se aveva già avviato una formidabile collana di classici – Defoe, Büchner, Adams, Stendhal, Voltaire, Novalis, Butler – e iniziata la monumentale edizione del tutto Nietzsche. La sede stava in un appartamento in via San Pietro all’Orto. E fu là, in una stanza sommersa di libri, che incontrai per la prima volta Luciano Foà. Mai avrei immaginato fosse l’inizio di un’amicizia durata moltissimi anni.
Passando da lui, verso fine mattinata, era sottintesa la colazione in uno di quei ristoranti milanesi con giardino interno, spesso trasformato in serra, dove, lontano dai rumori e avvolti nella polla dei rampicanti, si ha l’illusione di vivere fuori del tempo. A Foà piaceva particolarmente una brasera dalle parti di via Mangili. In un palazzotto poco lontano aveva abitato Carlo Dossi, un autore molto amato dagli adelphiani. Con una lentezza da bradipo, la testa leggermente reclinata, fumando sottili sigarette, a tavola Foà si trasformava in un formidabile affabulatore. Aveva un volto orientale, enigmatico, attraversato da una mimica antica, ironica. Conosceva tutti. Mostrava particolare attenzione a quanti avessero ammirazione per Roberto Bazlen, suo grande amico e mito sconosciuto della cultura italiana del Novecento. Ne parlava come esibisse il proprio doppio. D’altra parte molte scelte dell’Adelphi si dovevano a quell’ostinato, raffinato e rabdomantico Bobi Bazlen che sembrava aver esplorato tutte le letterature del mondo. Il «signor Adelphi» non era da meno. Temevo sempre una sua spiazzante domanda. Penso lo supponesse. Più d’una volta tese trappole.
Impossibile dimenticare la sua sapienza per gli autori rari recanti al loro interno il mistero della vita, quell’impareggiabile forza che nello stile della scrittura fa percepire l’inesprimibile altro da sé. Non c’era traduzione che mancasse di rivedere prima di mandare un nuovo libro in tipografia. La precisione della forma era la sua ostinata vocazione. «Fondai l’Adelphi per rompere la monotonia dell’ideologismo editoriale di sinistra, per scegliere autori che uscissero fuori dai binari codificati da una visione del mondo erosa in senso deteriore.» Pubblicò una serie di libri «unici», scelti secondo un unico criterio: la profondità dell’esperienza da cui nascevano e di cui erano viva testimonianza. Erano libri del passato e della contemporaneità, «luoghi» della realtà e dell’immaginazione, del mondo degli affetti e del pensiero. Si trattava di collane ideali capaci di far scoprire o riscoprire i grandi scrittori della crisi europea, Hesse, Joseph Roth, Walser, Lernet Holenia, la spiritualità orientale, la mitologia classica, la perfezione di Nabokov e Simenon, autori «censurabili» come Jünger, hippies, surrealisti alla Daumal, vagheggiatori del mondo tipo Chatwin.
Foà raccontava che l’idea di una casa editrice come l’Adelphi era molto antica. Bisognava tornare al 1937 quando lui, giovanissimo, aveva conosciuto Bazlen che lo aveva dissuaso dal progetto di fondare una rivista letteraria. «Inoltre avrei avuto problemi per ragioni razziali. E fu Bobi a convincermi affinché mi battezzassi per mettermi al riparo dalle persecuzioni.» Allora Foà lavorava all’Agenzia letteraria internazionale fondata dal padre Augusto che traduceva romanzi stranieri e li vendeva per la pubblicazione a puntate in feuilleton. Nelle lunghe chiacchiere Luciano e Bobi, in quegli anni vagheggiavano la cultura che avrebbe dovuto affermarsi dopo la caduta del fascismo. Era come se quel tempo fosse stato per Foà la preparazione di un mondo ideale. La sorte glielo fece incontrare nel 1941. Aveva ventisei anni.
Adriano Olivetti, nel suo utopico progetto di comunità, lo chiamò a Ivrea per pensare a una casa editrice predisposta a pubblicare tutto quanto le forze dominanti avevano fino ad allora tenuto lontano. Dall’amicizia con Bazlen aveva ereditato un’ostinata curiosità per quanto stava al «di sotto delle carte»: lo interessava il giudizio sulle persone, magari basato sull’intuizione, la fisionomia, i gesti, la grafia e anche i capricci degli astri che con la loro influenza pretendono guidare l’esistenza degli uomini. L’attenzione alle premonizioni astrologiche gli veniva proprio da Bobi che del meccanismo universale e dei pronostici stellari era un cultore.
Foà si abbandonava volentieri a placide evocazioni, sottolineando l’importanza dell’esperienza fatta con Olivetti. Dovevano cercare libri da tutto il mondo. Un programma enorme che recuperasse grandi scrittori. «Ma anche Freud, Jung, Heidegger, la patristica, l’economia, le scienze politiche… Olivetti, che era un visionario illuminato, mi mandava in Svizzera per trovare libri, parlare con editori, incontrare Jung.» Presso un piccolo editore di Lucerna aveva rinvenuto un libretto con una scelta di lettere di grandi scrittori tedeschi, curato da un tale di nome Detlef Holz. «Dopo la guerra scoprii essere niente meno che Walter Benjamin.»
Ma l’incontro che di più amava raccontare era quello avuto in Svizzera durante uno dei viaggi che Olivetti gli organizzava. «Mi mandò a parlare con un misterioso personaggio. Fu una situazione paradossale.» Secondo la rievocazione di Foà, Olivetti voleva informazioni su cosa prevedessero gli Alleati sul destino dell’Italia. Era convinto che, caduto il fascismo, sarebbe stato chiamato a far parte, magari presidente del Consiglio, del primo governo dell’Italia libera. «Pensava di essere come Rathenau, un uomo di vasta cultura e di grandi interessi. Un industriale che avrebbe applicato le sue capacità e i suoi sogni alla politica.»
Il giovane che si intendeva di libri e traduzioni, il giovane colto che Olivetti aveva inviato come proprio messo, doveva descrivere al misterioso personaggio la situazione italiana. «Era un signore enorme» ricordava Foà cercando di imitarne le forme allargando le braccia «una specie di vichingo. Rappresentava gli Stati Uniti per l’Europa occupata e dell’Italia non capiva niente. Voleva soltanto sapere quando sarebbe caduto Mussolini e chi sarebbe andato al suo posto. Visto oggi mi sembra un incontro surreale.» Più tardi scoprì d’aver parlato con Allen Dulles. Da questo episodio Foà avrebbe potuto trarre un formidabile racconto. Che non scrisse mai.
Gli chiesi una volta, al di là delle traduzioni, se avesse mai pensato di dedicarsi a qualcosa di suo. Dopo una pausa confessò «il peccato». «Ho tentato. Avevo cominciato con la descrizione di un funerale. Alla seconda pagina ho smesso… per sempre.» Lui era un editore. Il suo libro il catalogo dell’Adelphi. Nel 1945, pubblicato a puntate sul Politecnico di Vittorini, Foà tradusse For Whom the Bell Tolls – Per chi suona la campana – di Ernest Hemingway. «Cercavamo di preparare la cultura per il nuovo tempo, con un grande desiderio di esistere, di far bene.» Nel 1951 era segretario generale dell’Einaudi, che abbandonò nel ’61. In quegli anni si consumava anche la sua militanza politica. Iscritto al pci ne uscì nel ’56, dopo i fatti d’Ungheria. Un giorno mi disse di non essere rimasto troppo lontano da quelle posizioni, ma di non aver mai condiviso «la filosofia e la metafisica» del partito.
Quando passava da casa mia non rinunciava alla più inveterata delle sue abitudini: il sonnellino dopo pranzo. Senza chiedere alcun permesso, con discreta confidenza, la cerimonia era prevista. Chiudeva le persiane dello studio, accostava la porta e si stendeva sul divano. Incurante di quanto poteva accadere intorno. Dopo mezz’ora riappariva riprendendo la conversazione dal punto esatto in cui l’aveva lasciata. Da Luciano Foà ho imparato a conoscere i libri. Gli devo la ricercata esclusività di molte letture. Non dimenticava mai di inviarmi edizioni fuori commercio, curate personalmente: erano sue raffinate traduzioni e ricordavano privati anniversari, un compleanno…
Nel 1980, per festeggiare il centesimo titolo della Biblioteca Adelphi, in un’edizione in cento copie, aveva scelto Il libro degli amici, di Hugo von Hofmannsthal. Per anni mi aveva dimostrato una cordiale, riservata confidenza. Poi, con mia sorpresa, quasi guardingo, un giorno mi chiese: «Da quanti anni ci conosciamo?». «Forse venticinque» risposi. Scosse la sottile sigaretta nel posacenere. «Potremmo cominciare a darci del tu.»

Tratto da “Ammirabili & freaks”, di Giuseppe Mercenaro, Il Saggiatore, 2026, 19€, 224 pp.
***
Martedì 20 gennaio alle ore 17:30 Ammirabili & freaks verrà presentato a Milano presso la biblioteca Sormani, in Corso di Porta Vittoria 6. In dialogo ci saranno Piero Boragina, Bruno Quaranta e Stefano Salis.
L'articolo L’ostinata vocazione per la precisione della forma di Luciano Foà proviene da Linkiesta.it.

Loci communes si chiamano detti, proverbi, idee, pensieri, estratti da testi a stampa e spesso messi insieme in zibaldoni. Sono materiali raccolti da lettori attenti, quale era, ad es... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Le strade dell’Iran sono rimaste relativamente tranquille negli ultimi giorni, dopo due settimane di proteste su vasta scala che hanno scosso il Paese a causa della grave crisi economica in corso e in seguito alle minacce di intervento da parte di Washington, che ha annunciato possibili attacchi contro siti governativi.
Quando le manifestazioni e i disordini si sono trasformati in vere e proprie rivolte con scontri violenti contro la polizia, causando vittime da entrambe le parti in diverse località, le autorità di Teheran hanno imposto un blackout totale di Internet e dei servizi di messaggistica, convinte che tale misura avrebbe ostacolato o rallentato qualsiasi tentativo straniero di sfruttare le proteste a fini destabilizzanti.
Dopo otto giorni di completa interruzione della rete, l’Iran ha iniziato sabato a allentare gradualmente le restrizioni, ripristinando innanzitutto il servizio di messaggistica breve (SMS) su tutto il territorio nazionale. I media statali hanno descritto un piano progressivo per il ritorno alla normalità di Internet e dei servizi di comunicazione.
Al Jazeera riporta dichiarazioni di autorità statali secondo cui cellule terroristiche e una cospirazione straniera sono state smantellate, e la situazione è ora sotto controllo: citando funzionari, l’emittente qatarina ha riferito che la decisione di allentare il blackout è stata presa dopo la stabilizzazione della sicurezza e l’arresto di figure chiave collegate a «organizzazioni terroristiche» responsabili della violenza durante le proteste contro l’aumento dei prezzi e le difficoltà economiche, scoppiate il 28 dicembre in diverse città iraniane.
Le autorità hanno sostenuto che il blackout di Internet ha «indebolito notevolmente le connessioni interne delle reti di opposizione all’estero» e ha interrotto le operazioni delle «cellule terroristiche».
In questo contesto, anche la Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, è intervenuta, accusando attori legati agli Stati Uniti e a Israele di essere responsabili dell’uccisione di «diverse migliaia» di persone durante le proteste antigovernative.
Aiuta Renovatio 21
«Coloro che sono legati a Israele e agli Stati Uniti hanno causato danni ingenti e ucciso diverse migliaia di persone», ha dichiarato sabato. Gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali hanno respinto ripetutamente le accuse iraniane di «complotto straniero». Alcuni di loro sono stati uccisi «in modo brutale e disumano», ha aggiunto Khamenei senza fornire ulteriori dettagli, durante un incontro pubblico trasmesso dalla televisione di Stato.
Si tratta della prima volta che un’alta autorità iraniana parla esplicitamente di vittime in termini di «migliaia». In precedenza, alcuni gruppi di monitoraggio con sede negli Stati Uniti e certi media americani avevano avanzato stime di 12.000 morti, una cifra ritenuta enorme e che ha suscitato scetticismo.
Riguardo all’ipotesi di un complotto straniero, il Financial Times sembra essere il primo organo di informazione mainstream a riportare testimonianze su gruppi ben organizzati e vestiti di nero che hanno alimentato caos e violenza contro la polizia durante le proteste…
«C’erano gruppi di uomini vestiti di nero, agili e veloci. Davano fuoco a un bidone della spazzatura e poi si spostavano rapidamente verso il bersaglio successivo». «Sembravano dei commando». «Erano sicuramente organizzati, ma non so chi ci fosse dietro di loro».
L’Iran ha affermato che centinaia di poliziotti e membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi o feriti, e ha diffuso video che mostrerebbero presunti «manifestanti» armati intenti a fomentare un’insurrezione contro le posizioni governative. Non sorprende che servizi di intelligence israeliani o occidentali possano tentare di infiltrare e deviare le proteste verso obiettivi di destabilizzazione del regime.
Tuttavia, dimostrare tale scenario resta estremamente difficile nel mezzo della nebbia della guerra e dell’intensa propaganda diffusa da tutte le parti coinvolte.
Come riportato da Renovatio 21, la settimana scorsa il Khamenei ha dichiarato che l’«arrogante» Trump sarà «rovesciato».
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di Khamenei.ir via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 4.0 International
L'articolo Khamenei dell’Iran afferma che Stati Uniti e Israele sono collegati alla violenza mortale delle proteste: «Migliaia di morti» proviene da RENOVATIO 21.
Sabato 10 gennaio 2026, papa Leone XIV ha inaugurato ufficialmente un Anno Giubilare speciale per celebrare l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Questa commemorazione, che si estenderà fino al 10 gennaio 2027, è proposta dalla Santa Sede come tempo di grazia e rinnovamento spirituale per la Chiesa universale.
Con decreto della Penitenzieria Apostolica, il Santo Padre ha concesso l’indulgenza plenaria ai fedeli che soddisfano le consuete condizioni, allo scopo di presentare la figura del «Poverello» come modello di santità e rifugio di pace in un contesto internazionale segnato da violenza e incertezza.
L’apertura di questo periodo giubilare consente ai fedeli di ottenere la remissione della pena temporale dovuta ai peccati secondo le disposizioni canoniche: i fedeli devono recarsi in pellegrinaggio a qualsiasi chiesa conventuale francescana o a un luogo di culto dedicato al santo di Assisi; e devono partecipare ai riti giubilari prescritti o dedicarsi alla preghiera e alla meditazione.
Le condizioni richieste per ottenere questa grazia sono quelle consuete: la confessione sacramentale, la Santa Comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Coloro che, per motivi di salute, età avanzata o altre gravi cause, non possono uscire di casa, possono unirsi spiritualmente alle celebrazioni offrendo a Dio le proprie sofferenze e preghiere per partecipare ai frutti spirituali del Giubileo.
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Nell’ambito di queste celebrazioni, papa Leone XIV ha indirizzato una lettera ai Ministri Generali della Conferenza della Famiglia Francescana. In questo documento, datato 7 gennaio 2026, il Santo Padre sottolinea che la pace non è semplicemente il frutto di sforzi umani o accordi tecnici, ma un dono divino che deve essere accolto con umiltà.
La lettera evidenzia il tradizionale saluto francescano, «La pace sia con voi», come cuore di una grazia divina che assume oggi particolare importanza.
La lettera sottolinea l’eredità di San Francesco d’Assisi e ci ricorda che la pace comprende tre dimensioni inscindibili: la pace con Dio, la pace tra le persone e la pace con il creato. Questa visione è fondamentale in un’epoca segnata da quelle che il papa definisce «guerre apparentemente infinite» e da divisioni sociali che generano sfiducia.
A questo proposito, la Santa Sede ha annunciato che, dal 22 febbraio al 22 marzo 2026, il corpo di San Francesco sarà eccezionalmente traslato dalla sua cripta per facilitarne la venerazione dei fedeli durante questo centenario.
L’apertura ufficiale delle celebrazioni ha avuto luogo nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, alla Porziuncola, luogo in cui il santo morì nell’autunno del 1226. La cerimonia è stata presieduta da Fra’ Francesco Piloni, Ministro Provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, accompagnato dai sei Ministri Generali dei diversi rami dell’Ordine:
Massimo Fusarelli (Frati Minori), Fra’ Carlos Alberto Trovarelli (Frati Minori Conventuali), Fra’ Roberto Genuin (Frati Minori Cappuccini), Tibor Kauser (Ordine Francescano Secolare), Fra’ Amando Trujillo Cano (Terzo Ordine Regolare) e Suor Daisy Kalamparamban (Conferenza Francescana Internazionale).
Al termine delle cerimonie inaugurali, il papa ha recitato una preghiera dedicata a San Francesco d’Assisi, invocandolo come intercessore affinché i cristiani diventino «artigiani di pace» e «testimoni disarmati».
La preghiera invoca il coraggio di costruire ponti laddove il mondo erige confini e ci ricorda che la vera riconciliazione è quella che abbatte tutti i muri. Attraverso questa iniziativa, la Chiesa auspica che l’ottavo centenario della morte del santo non sia solo un evento storico, ma un catalizzatore di concordia e rispetto della dignità umana nella società contemporanea.
È auspicabile che la vita del santo di Assisi, profondamente trasformata dal Cristo crocifisso e manifestata nelle stimmate, non venga dimenticata, né che venga dimenticato lo zelo apostolico e missionario della Regola francescana, in netto contrasto con il «dialogo» proposto oggi dai suoi seguaci.
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine: Cimabue (1240–1302), Frammento, Vergine in Maestà, con Bambino, quattro angeli e san Francesco (XIII secolo), Basilica inferiore di San Francesco, Assisi.
Immagine di pubblico dominio CC0 via Wikimedia
L'articolo Papa Leone XIV inaugura l’Anno Giubilare per l’800° anniversario della morte di San Francesco proviene da RENOVATIO 21.
Gli ambasciatori dei 27 Stati membri dell’Unione Europea si riuniranno domenica per una riunione di emergenza, in seguito all’annuncio del presidente Donald Trump di imporre un’ondata di dazi crescenti su otto Paesi europei della NATO che si oppongono a un «acquisto totale e completo» della Groenlandia da parte degli Stati Uniti.
I colloqui straordinari seguono una ferma dichiarazione di solidarietà con la Danimarca da parte dei principali leader del blocco, i quali hanno avvertito che i dazi minacciati da Trump «minerebbero le relazioni transatlantiche e rischierebbero di innescare una pericolosa spirale discendente».
In post identici pubblicati sui social media, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno respinto qualsiasi contestazione della sovranità danese sulla Groenlandia.
«L’integrità territoriale e la sovranità sono principi fondamentali del diritto internazionale», hanno dichiarato. «L’UE esprime piena solidarietà alla Danimarca e al popolo della Groenlandia».
Aiuta Renovatio 21
I dazi, annunciati da Trump sabato, colpiscono Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia, Paesi che hanno recentemente inviato piccoli contingenti militari in Groenlandia. I leader europei hanno precisato che l’esercitazione guidata dalla Danimarca è stata coordinata in anticipo e «non rappresenta una minaccia per nessuno».
«Abbiamo costantemente sottolineato il nostro comune interesse transatlantico per la pace e la sicurezza nell’Artico, anche attraverso la NATO», hanno aggiunto.
L’Alta rappresentante per la politica estera dell’UE, Kaja Kallas, ha dichiarato che «se la sicurezza della Groenlandia è a rischio, possiamo affrontare la questione all’interno della NATO». Ha poi osservato ironicamente che «Cina e Russia devono divertirsi», poiché traggono vantaggio dalle divisioni interne all’alleanza. Il Segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha invece scelto di non commentare la controversia in corso.
Nelle scorse settimane, Trump ha rilanciato e intensificato i suoi sforzi per annettere o acquisire la Groenlandia, un obiettivo che persegue sin dal suo primo mandato. Sostiene che tale acquisizione sia essenziale per la sicurezza nazionale statunitense, al fine di contrastare l’influenza cinese e russa nell’Artico – un’asserzione respinta sia da Pechino che da Mosca.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di © European Union, 2026 via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 4.0 International
L'articolo Groenlandia, Bruxelles teme una «pericolosa spirale discendente» proviene da RENOVATIO 21.
La missione iniziale di 15 soldati tedeschi in Groenlandia si è conclusa, ha annunciato il portavoce delle Forze Armate tedesche, il Tenente Colonnello Peter Milevchuk, in un’intervista al gruppo mediatico Funke. Milevchuk ha sottolineato che la collaborazione con i colleghi danesi è stata «positiva e costruttiva».
Mercoledì la Danimarca ha reso nota l’organizzazione di un’esercitazione militare sull’isola. Diversi paesi europei – tra cui Germania, Francia, Svezia, Norvegia e Regno Unito – hanno confermato la loro partecipazione, inviando ciascuno un contingente compreso tra uno e 15 militari. L’iniziativa arriva dopo i recenti colloqui tra Danimarca, Groenlandia e Stati Uniti, conclusisi con quello che le autorità hanno definito un «disaccordo fondamentale» tra l’amministrazione Trump e i partner europei riguardo al territorio autonomo.
«I risultati della ricognizione saranno esaminati nei prossimi giorni», ha precisato Milevchuk, confermando che la squadra tedesca ha portato a termine la propria missione.
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Nelle ultime settimane il presidente statunitense Donald Trump ha rilanciato con forza il progetto di riportare la Groenlandia sotto il controllo di Washington, un obiettivo che persegue fin dal suo primo mandato. Trump considera l’acquisizione dell’isola essenziale per la sicurezza nazionale americana, al fine di contrastare l’espansione dell’influenza cinese e russa nell’Artico – una tesi respinta con decisione sia da Pechino sia da Mosca.
Il presidente americano ha più volte deriso la presenza militare danese in Groenlandia, definendola insufficiente per la difesa della più grande isola del pianeta e ironizzando sul fatto che l’isola sarebbe protetta solo da «due slitte trainate da cani». Le tensioni sono ulteriormente aumentate all’inizio di questa settimana, quando Trump ha minacciato nuovi dazi sui partner commerciali degli Stati Uniti che non appoggeranno il suo tentativo di acquisire la Groenlandia.
La decisione ha provocato dure reazioni in Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha giudicato «inaccettabili» le minacce tariffarie e ha annunciato una risposta «unita e coordinata» da parte dell’Europa. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avvertito che tali minacce rischierebbero di compromettere i rapporti transatlantici, riaffermando al contempo la piena solidarietà dell’Unione Europea con Danimarca e Groenlandia. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito i dazi «completamente sbagliati», sostenendo che indeboliscono la NATO e annunciando colloqui diretti con Washington per affrontare la questione.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
L'articolo I soldati tedeschi lasciano la Groenlandia proviene da RENOVATIO 21.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che applicherà dazi doganali a otto Paesi europei membri della NATO che si oppongono ai suoi progetti di acquisizione della Groenlandia. Le sanzioni resteranno in vigore fino a quando non si concretizzerà un «acquisto completo e totale» del territorio autonomo danese, ha precisato.
Nelle scorse settimane, Trump ha più volte sostenuto che gli Stati Uniti devono annettere la Groenlandia per ragioni di «sicurezza nazionale» e per contrastare una presunta minaccia proveniente da Cina e Russia. Il presidente ha manifestato una determinazione sempre maggiore a ottenere il controllo dell’isola con ogni mezzo necessario, senza escludere l’uso della forza.
Sabato, Trump ha dato seguito alle sue minacce annunciando l’imposizione di dazi su otto nazioni europee della NATO, inclusa la Danimarca. Una tariffa del 10% scatterà il 1° febbraio e salirà al 25% a partire da giugno, rimanendo attiva finché non verrà raggiunto un «acquisto completo e totale» della Groenlandia.
Aiuta Renovatio 21
L’annuncio è stato pubblicato dal presidente sulla sua piattaforma Truth Social, dove ha rinnovato le accuse secondo cui Pechino o Mosca starebbero per impadronirsi dell’isola. Sia Russia che Cina hanno smentito categoricamente tali affermazioni, che sono state contestate anche dalle autorità locali.
«Nessuno metterà le mani su questo sacro pezzo di terra, soprattutto perché è in ballo la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e del mondo intero. Oltre a tutto il resto, Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia si sono presentati in Groenlandia per scopi misteriosi», ha scritto Trump. Tutti i Paesi citati saranno colpiti dai dazi, che resteranno «dovuti e pagabili» fino alla conclusione di un accordo.
Sebbene la maggior parte degli Stati europei della NATO abbia evitato finora uno scontro pubblico diretto con Washington sulle intenzioni di Trump, le nazioni coinvolte hanno comunque inviato un contingente militare limitato in Groenlandia come gesto di sostegno alla Danimarca.
Sia le autorità danesi sia quelle groenlandesi hanno respinto fermamente l’ipotesi di cedere l’isola agli Stati Uniti, ribadendo che il futuro del territorio spetta esclusivamente alla sua popolazione. Nel 2008 i residenti hanno votato per conservare lo status di autonomia all’interno del Regno di Danimarca.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di pubblico dominio CC0 via Flickr
L'articolo Trump impone dazi sui Paesi della NATO per la Groenlandia proviene da RENOVATIO 21.
Louise Leguistin, 25 anni, è una delle sopravvissute de devastante rogo del Constellation di Crans-Montana. Una serata che, per lei, segna il confine fra un prima e un dopo, un prima fatto di spensieratezza e sogni, e un dopo di trauma, rimpianti e una vita che non sarà mai più la stessa. Ma è soprattutto una testimone che ha già smentito alcune dichiarazioni dei Moretti, i due coniugi francesi indagati per la mattanza della notte di Capodanno con i suoi 40 morti e gli oltre 100 feriti, per esempio sulla controversa questioni dei caschi e dei travestimenti.
Seduta davanti agli inquirenti la 25enne, come riporta il Corriere della Sera, mette in fila gli eventi dovendo fare slalom sulle emozioni di rivivere un evento così spaventoso. “Ero completamente disorientata, sola, sopraffatta dalla portata di quello che vedevo accadere. Ho avuto l’impressione che i pompieri ci abbiano messo una vita ad arrivare… Ero nel panico… Quando ho visto tutte quelle fiamme, mi sono sentita impotente. Sentivo tutti urlare…Da quella notte ho grandi difficoltà a dormire. Vedo costantemente i volti dei morti, delle persone che ho assistito, che ho riconosciuto fuori, bruciati. L’odore mi è rimasto nel naso” spiega sottolineando che i due tagli riportati durante l’incendio non vuole non può considerarli ferite.
“Sono triste, angosciata, scioccata… Da quella sera le cose non sono andate molto bene. Mi sono incolpata molto per essere uscita illesa. Sono felice di essere viva. Ma ho dei rimpianti. Mi chiedo cosa avremmo potuto fare diversamente… Non avevo mai lavorato a Crans o per la famiglia Moretti. Avevo fatto il colloquio con Jessica una settimana e mezza prima, per telefono. Avevo fatto domanda. Volevo fare esperienza in Svizzera e mettere via un po’ di soldi, come tutti”. Era entusiasta, aveva legato subito con i colleghi, come il capobarman Gaëtan, il dj Mateo e la cameriera Cyane Panine, che sarebbe diventata una figura emblematica di quella notte tragica e che è una delle 40 vittime.
La ragazza con il casco e le candele sulle bottiglie di champagne sui cui i Moretti in qualche modo hanno cercato di scaricare la responsabilità. “Durante i festeggiamenti, quando è scoppiato l’incendio, Jessica era con noi, stava filmando quello che stava succedendo. L’ho vista salire le scale e andarsene in fretta, poi non l’ho più vista” racconta. Quando le viene chiesto dei suoi rapporti con i Moretti, risponde: “Nessuno”.
Una delle domande cruciali riguarda la formazione ricevuta in caso di emergenza: “Non mi è stato insegnato nulla su come gestire un incendio. Mi è stato semplicemente spiegato come funzionava il reparto. Tutto qui”. E quando gli inquirenti chiedono se ci fosse un estintore, la sua risposta è incerta: “Credo ce ne sia uno“. Una sensazione di inadeguatezza che sembra pervadere tutto quanto è accaduto quella notte, anche in relazione alle uscite di emergenza: “C’era un cartello, ma non è molto visibile. I clienti del locale non avevano mai notato quella porta”. Porta tra l’altro bloccata con un mobiletto come accertato dagli investigatori svizzeri.
L'articolo “Gli estintori? Credo ce ne sia uno. Vedo costantemente i volti dei morti”, la testimonianza della cameriera sopravvissuta proviene da Il Fatto Quotidiano.
Scontro tra due treni dell’Alta velocità in Spagna, nel sud dell’Andalusia. I morti accertati sono 39 morti e 75 i feriti – alcuni in gravissime condizioni – ma si teme una strage di dimensioni ancora maggiori. Almeno tre vagoni, infatti, sono precipitati in un terrapieno e il numero di vittime è indefinito. La tragedia è avvenuta all’altezza di Adamuz, vicino Cordova, sud dell’Andalusia: un treno Iryo diretto a Madrid, stazione Puerta de Atocha, è deragliato, invadendo un altro binario e colpendo un convoglio diretto a Huelva deragliato a sua volta.
L'articolo Treno deragliato in Spagna, le prime immagini del disastro: i passeggeri cercano di uscire dai vagoni proviene da Il Fatto Quotidiano.
Il Senegal ha vinto la seconda Coppa d’Africa della sua storia con una spettacolare botta all’incrocio del centrocampista Pape Gueye, che al 4’ del primo tempo supplementare ha regalato una notte di dolore al Marocco intero, ma di questa finale si ricorderà ben altro: il rigore discutibile concesso ai padroni di casa al 98’ per una caduta in area di Brahim Diaz dopo una sbracciata di Diouf, l’annullamento altrettanto discutibile al 92’ del gol firmato da Sarr per un presunto fallo di Seck su Hakimi, i sedici minuti di interruzione del match con il plateale rientro negli spogliatoi dei futuri campioni su ordine dell’allenatore Pape Thiaw, il ritorno in campo grazie all’intervento di Sadio Mané – l’ex Liverpool ha evitato l’esclusione disciplinare dal prossimo mondiale – e, a completare il romanzone, il rigore assurdo di Brahim Diaz, che dopo tutta questa sarabanda ha avuto la bella pensata di fare il cucchiaio e ha invece consegnato il pallone al portiere Mendy.
Tutto questo nel caos totale, con una serie di minirisse, un centinaio di persone nelle due aree tecniche a spintonarsi e urlare, la confusione generale e l’arbitro della Repubblica Democratica del Congo, Jean Jacques Ngambo Ndala, che girava comicamente per il campo alla ricerca di un giocatore da ammonire. Una farsa che non ha fatto bene al calcio africano ed è un peccato, perché il livello tecnico negli ultimi vent’anni è decisamente migliorato, ma quando entra in scena il torneo continentale esce fuori il peggio.
La gazzarra si è consumata sotto gli occhi del presidente Fifa Gianni Infantino. Impegnatissimo negli ultimi mesi a fare da sponda al presidente Trump, con tanto di premio per la pace a un signore che sta mettendo a soqquadro il mondo, Infantino ha perso di vista la sua vera ragione di essere: il governo, possibilmente senza ombre, del calcio mondiale. Un certo imbarazzo da parte di Infantino è trapelato all’inizio della premiazione, perché questa finale, seguitissima da oltre tre miliardi di persone – collegati Cina, Brasile e Giappone, buona parte dell’Europa, l’Africa intera e un pezzo consistente di Asia –, non è stata in quei sedici minuti di follia uno spot edificante, ma poi è tornato Infantino: abbracci e una buona parola per tutti, “volemose bene” e arrivederci alla prossima. In fondo l’Africa è un serbatoio di 54 voti, un quarto dell’universo Fifa.
Oltre il caos, ha vinto la squadra migliore. Il Marocco ha pagato quanto si temeva alla vigilia: la pressione asfissiante di una nazione di 38 milioni di persone, l’ossessione per un successo che manca dal 1976, la responsabilità di dare un senso a investimenti economici imponenti che hanno sottratto risorse ad altri settori vitali. Il Senegal, vincitore dell’edizione 2021, ha tenuto bene il campo. Il copione dei Leoni della Teranga è collaudato: 4-3-3, grande prestanza atletica, uomini importanti in ogni reparto, dal portiere Mendy ai due Gueye – Idrissa e Pape – a centrocampo, il trio Mané, Jackson e Ndiaye in attacco. Il Marocco non ha mai dato l’idea di poter imporre il suo gioco. Il Senegal è stato più lineare e più agile. Ha avuto tre occasioni importanti prima del gol annullato a Sarr e del caos generale.
Il rigore fallito da Diaz, uscito al 98esimo per la disperazione dal campo e fischiato al momento delle premiazioni – lui capocannoniere con cinque gol, il connazionale Bounou miglior portiere e Mané miglior giocatore del torneo -, ha dato la svolta al match. Nel primo tempo supplementare, trovato il gol di Pape Gueye su azione avviata da un pallone perso dal romanista El Ayanoui – con la fasciatura in testa dopo uno scontro aereo che gli aveva fatto perdere molto sangue -, il Senegal ha sfiorato il bis con un’azione spettacolare del diciassettenne Mbaye, ma ancora più clamoroso è stato il 2-0 mancato da Cherif Ndiaye, complice un miracolo del portiere Bounou.
Il Marocco ha sfiorato il pareggio colpendo la traversa con una capocciata di Aguerd, ma lentamente la squadra di casa si è spenta. Gli ultimi minuti sono scivolati attorno alla bandierina del calcio d’angolo, con i senegalesi abilissimi a ottenere sempre la rimessa laterale, fino al triplice fischio che ha consegnato ai Leoni della Teranga il titolo di campioni d’Africa. Dal 2013 il torneo non veniva assegnato dal dischetto ed è un ulteriore punto a favore del Senegal, ma di questa serata si ricorderanno quei sedici minuti di follia e il rigore più lungo della storia del calcio, in cui hanno perso tutti, anche i vincitori.
L'articolo Senegal campione nella finale farsa contro il Marocco: con il rigore più lungo della storia ha perso tutto il calcio africano proviene da Il Fatto Quotidiano.
Svolta storica nel nord-est della Siria, dove le fazioni agli ordini del leader siriano Ahmad Sharaa, sostenuto da Stati Uniti e Turchia, mettono la parola fine alla decennale esperienza semi-autonomista curda del cosiddetto “Rojava“, strappando senza quasi combattere alle forze curdo-siriane il controllo dei territori a est dell’Eufrate, ricchi di petrolio, acqua e grano e centrali per l’equilibrio regionale. L’offensiva delle forze di Damasco, avviata nei giorni scorsi contro le roccaforti curde di Aleppo, si è conclusa con la presa delle due principali città sull’Eufrate, Raqqa e Deir ez-Zor, nodi chiave per il controllo dei pozzi petroliferi e delle risorse idriche.
Dopo la sconfitta ad Aleppo nei primi giorni di gennaio, le forze curde non avevano opposto particolare resistenza all’avanzata verso est. Sotto forti pressioni statunitensi e dopo aver ottenuto da Damasco il riconoscimento dei diritti civili dei curdi siriani (non accadeva dal 1962 in questi termini), l’azione militare si è limitata a fare da cornice alla firma, in serata, di un accordo da più parti definito storico. Come richiesto da tempo da Washington, il governo di Sharaa assume così il controllo dell’intero nord-est: risorse naturali, istituzioni, confini e valichi, oltre alle prigioni dove sono detenuti circa 20mila sospetti dell’Isis e ai campi che ospitano da anni donne e minori di decine di nazionalità diverse considerati legati allo Stato islamico. La “lotta al terrorismo” quindi prosegue secondo la narrativa Usa, ma cambia il partner locale: non più le forze curdo-siriane che liberarono Raqqa e resistettero a Kobane dieci anni fa, bensì i nuovi governativi agli ordini di Sharaa, fino all’estate scorsa considerato un “terrorista” dal Dipartimento di Stato per i suoi trascorsi qaedisti.
L’accordo è stato siglato a Damasco da Sharaa, dal capo delle forze curdo-siriane Mazlum Abdi e dal mediatore Usa Thomas Barrack, che ha definito l’intesa “un punto di svolta cruciale”. Restano da chiarire numerose questioni, a partire da come avverrà l’annunciata integrazione delle forze curde nell’esercito governativo: su base individuale, senza “battaglioni curdi”. Il testo non affronta il destino delle migliaia di combattenti donne curde, che saranno probabilmente escluse da un esercito dominato dalla componente araba e culturalmente maschilista. Invariata la divisione amministrativa del nord-est, ma dopo oltre dieci anni cambiano le bandiere: via i manifesti di Ocalan e spazio ai vessilli della “Siria liberata” filo-turca. Damasco prende il pieno controllo di Raqqa e Deir ez-Zor, mentre ai curdi potrebbe restare la gestione civile del governatorato di Hasake, incastonato tra Turchia e Iraq.
L'articolo Siria, Al Sharaa si prende l’intero nord est: i curdi si arrendono e firmano l’accordo, finisce l’esperienza del Rojava proviene da Il Fatto Quotidiano.


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews

Loci communes si chiamano detti, proverbi, idee, pensieri, estratti da testi a stampa e spesso messi insieme in zibaldoni. Sono materiali raccolti da lettori attenti, quale era, ad es... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti



Alle 19.39 di domenica 18 gennaio, all'altezza di Adamuz, vicino a Cordova, in Spagna, due treni ad alta velocità si sono scontrati. I morti sono almeno 39, 170 sono i feriti lievi, 24 quelli gravi, cinque di loro in condizioni critiche.
Secondo le prime ricostruzioni, a causare la strage sarebbe stato il deragliamento del treno Iryo 6189, partito da Malaga alle 18:40 in direzione Madrid-Puerta de Atocha, agli scambi di ingresso del binario 1 della stazione di Adamuz. Il deragliamento ha portato l'Iryo 6168 sui binari della direzione, lì dove pochi istanti dopo è sopraggiunto un altro treno ad alta velocità a lunga percorrenza, l'Alvia 2384 della Renfe, che viaggiava verso sud da Puerta de Atocha a Huelva. L'impatto è stato violentissimo. La motrice dell'Alvia 2384 ha colpito le carrozze 6 e 7, sfondandole. Il macchinista di questo treno Alvia è tra le vittime dell'incidente, hanno confermato fonti di Renfe a EFE.
La velocità a cui viaggiavano entrambi i treni non è nota, ma, secondo gli inquirenti, quasi certamente viaggiavano a velocità medio bassa. Se l'Alvia 2384 fosse andato alla massima velocità, hanno fatto sapere, sarebbe stata una catastrofe con conseguenze di gran lunga peggiori, dato che almeno 317 persone viaggiavano sul treno Iryo.
L'ipotesi fatta dagli inquirenti è che l'incidente sia stato causato dalla rottura di un giunto che ha creato uno spazio tra due sezioni di binario che via via si è allargato al passaggio dei treni.
Il responsabile delle infrastrutture ferroviarie spagnole, il ministro dei Trasporti e della Mobilità sostenibile, Óscar Puente, si è recato sui luoghi della strage. Dopo mezzanotte, ha tenuto una conferenza stampa alla stazione di Atocha, dove ha confermato che l'incidente è avvenuto su un tratto rettilineo dei binari, ristrutturato a maggio. "Un incidente molto strano", ha dichiarato il ministro, basandosi sui resoconti degli esperti e dei tecnici di Adif con cui si era incontrato.
Il primo ministro Pedro Sánchez ha dichiarato che l'esecutivo sta collaborando con le autorità competenti e per aumentare i servizi di emergenza per assistere i passeggeri dei due treni deragliati.

Le elezioni presidenziali in Portogallo hanno dato ragione ai pronostici che assegnavano al candidato di Chega André Ventura e a quello socialista Antònio José Seguro i primi due posti e, di conseguenza, il ballottaggio dell’8 febbraio, ma il verdetto delle urne ha invertito le posizioni. Seguro ha infatti vinto con il 31,14%, incassando 1.752.325 voti, mentre Ventura, che secondo i sondaggi avrebbe dovuto stracciare la concorrenza, si è fermato al 23,48%, raccogliendo 1.321.387 preferenze. Staccati Joao Cotrim Figueiredo (Iniciativa Liberal) con il 15,99% e l’indipendente Gouveia e Melo, l’ammiraglio al quale fu affidata la gestione della vaccinazione del Covid, con il 12,34%. Umiliante la sconfitta del socialdemocratico Marques Mendes, sostenuto dal premier Luìs Montenegro, quinto con il 12,09%.
E’ stata la notte della riscossa dei socialisti, usciti con le ossa rotte dalle elezioni del 2025. Il voto delle presidenziali non ha lo stesso valore pratico di quelle legislative, ma il significato di questo voto indica che, dopo aver toccato il fondo, il PS ha rialzato la testa. Seguro ha superato la soglia del 30% ed è un risultato rilevante, considerato che la rincorsa partiva da lontano. I socialisti nel 2025 erano sprofondati al terzo posto nelle politiche, sorpassati non solo dai socialdemocratici, ma anche dall’estrema destra populista di Chega. Seguro è un socialista pragmatico, che guarda al centro, senza però dimenticare gli elementi cardine della sinistra. Ha impostato la sua campagna elettorale parlando dei problemi del paese, su tutti quelli di un servizio sanitario in grave difficoltà e di un costo della vita che sta erodendo le tasche delle persone. Ventura ha puntato invece sulla questione immigrazione, copiando dalla destra italiana uno slogan di sicuro effetto: prima i portoghesi.
Ventura, scottato da un secondo posto che lo vede ora rincorrere Seguro, ha già alzato la voce: “Questo voto è una sveglia per la destra. Dobbiamo unirci per impedire che il nuovo Presidente della Repubblica sia un socialista. Il paese mi ha dato la leadership della destra”. Dai socialdemocratici arrivano però segnali contrastanti. Ci sono spaccature. Il candidato socialista ha invitato “democratici, progressisti e umanisti a unirsi alla mia candidatura per sconfiggere l’estremismo e coloro che seminano odio e divisione. Siamo un solo popolo, una sola nazione, un solo Portogallo plurale e inclusivo, rispettoso delle libertà di tutti. Se sarò eletto, sarò il Presidente di tutto il paese, fedele alla Costituzione. Lavorerò ogni giorno affinché il popolo portoghese abbia accesso a un’assistenza sanitaria tempestiva. Mi batterò contro le disuguaglianze e contro la carenza degli alloggi”.
Il segretario generale del Partito Comunista Paulo Raimundo e il Blocco di Sinistra hanno annunciato il sostegno a Seguro. Per farcela, il candidato socialista dovrà però pescare tra i moderati che non approvano la destra reazionaria di Ventura. Il premier Montenegro ha scelto pilatescamente di non decidere: “Il partito socialdemocratico non appoggerà nessuno dei due candidati. Non daremo alcuna direttiva. Ricordo che il mio partito è stato scelto per guidare il paese e che governiamo la maggior parte dei consigli comunali. Accetto il verdetto dei portoghesi sulla nostra candidatura di Marques Mendes. Mi assumo la responsabilità di questo risultato”.
Sono parole a caldo, dopo lo spoglio dei voti e dopo le prime analisi. La battaglia vera inizia ora. Durerà tre settimane e spaccherà in due un Portogallo sballottato tra il populismo reazionario e la difesa dei valori democratici, figli del 25 aprile 1974. La partita si gioca qui, su questo terreno.
L'articolo Portogallo, il socialista Seguro domina il primo turno delle presidenziali: andrà al ballottaggio con il populista Ventura proviene da Il Fatto Quotidiano.
Una carriera che per 15 anni lo ha visto ai vertici dello sci di fondo, tanto da diventare l’italiano più vincente di sempre in Coppa del Mondo, con 17 successi. A cui aggiunge un oro e un totale di sette medaglie mondiali e due argenti olimpici. Federico Pellegrino si prepara a dire addio allo sci di fondo nella sua Saint-Barthelemy, dove il 28 marzo saluterà tutti con una grande festa. Prima, però, ha ancora un obiettivo davanti a sé: le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il valdostano ci arriva come uno dei quattro portabandiera dell’Italia e sfilerà con il tricolore nella cerimonia d’apertura di Milano. Ma anche con la consapevolezza di aver lasciato un segno indelebile ed essere stato il faro del movimento per 15 anni, in uno sport che nella sua storia olimpica ci ha regalato 36 medaglie.
Federico, sarà il primo portabandiera valdostano della storia tra Olimpiadi estive e invernali, cosa significa questo per lei?
Si sarò il primo nato in Valle d’Aosta, ma ci tengo a dire che saremo in due insieme a Federica Brignone, con cui ho vissuto tante esperienze. È stata un punto di riferimento nei miei primi anni e lo è ancora adesso, mi fa molto piacere condividere con lei questo traguardo. Essere stato scelto vuol dire che qualcosa nella mia carriera ho combinato, sia dal punto di vista sportivo, ma anche fuori dai campi di gara. Ho debuttato in Coppa del mondo nella prima gara dopo Vancouver 2010 e chiudere il cerchio così è bello. Dà sicuramente tanta energia, anche mentale, per provare ancora a fare qualcosa di grande nell’appuntamento più importante.
Al Tour de ski ha mostrato un’ulteriore crescita nelle distance e, paradossalmente, un passo indietro nelle sprint. Ha cercato questa cosa?
Fino a Pechino 2022 avevo obiettivi che passavano quasi esclusivamente dalle sprint. Ottenere una medaglia a Pyeongchang 2018 nella sprint in tecnica classica, piuttosto che il percorso durato otto anni, da Sochi 2014 a Pechino 2022, per cercare di vincerla in tecnica libera era il mio focus. Vivevo in funzione della prestazione, proprio per massimizzare il risultato. E sposarmi con Greta Laurent, che faceva lo stesso lavoro, è stato fondamentale. Dopo Pechino, però, ho fatto un cambio drastico di vita. In questi quattro anni ho imparato a conoscermi sotto altri punti di vista, grazie al mio allenatore Markus Kramer, e ho iniziato a credere in me anche nelle gare lunghe. Al Mondiale 2025 ho espresso il miglior Pellegrino complessivamente della mia carriera. Dieci anni fa era fantascienza essere a una manciata di centimetri da una medaglia nelle distance. Non è stata una trasformazione, ma la fiducia nel lavoro svolto e in me stesso. Ora mi sento più sicuro di fare un bel risultato nelle distance rispetto alle sprint.
Quindi crede di avere chance di medaglia nello skiathlon o magari nella 50km ai Giochi?
La 50Km arriverà dopo le gare a squadre, dove sono convinto che l’Italia possa puntare al podio, non voglio pensarci troppo. Nello skiathlon, invece, non posso nascondermi. In Val di Fiemme l’anno scorso ho fatto secondo, erano condizioni diverse e non era due giorni dopo l’emozione potentissima del portare la bandiera nell’Olimpiade in casa, però voglio esprimermi al meglio in quella gara. Anche la sprint è una bella opportunità. Con un certo tipo di neve in classico posso essere avvantaggiato, soprattutto in quel tipo di pista, però basta un niente per far saltare tutto, quindi non mi monto la testa. Ma se capiterà l’occasione dovrò coglierla, perché lasciar passare i treni senza salirci è la cosa che più mi dà fastidio.
Dal 2013 a oggi ha ottenuto almeno un podio in ogni stagione, qual è il segreto di questa costanza ad alto livello?
Non credo ci siano chissà che segreti. Conoscermi, programmare, fissare degli obiettivi ambiziosi sì, ma umili abbastanza per essere raggiunti. Questo penso sia stata la chiave, perché spesso agli atleti capita di sopravvalutarsi o sottovalutarsi e poi non raccogliere ciò che il loro potenziale offre. È tanto una questione psicologica, soprattutto rimanere ad alto livello in un tempo che dura 12-13 anni.
Johannes Klaebo è il rivale che spesso lo ha costretto ad accontentarsi del secondo posto. Come vive la sfida con una leggenda dello sci di fondo?
È uno stimolo, perché ogni gara non parto mai battuto. Cerco sempre di immaginarmi un modo per provarci, soprattutto nella sprint, dove hai tempo per cogliere segnali dall’esterno e dall’interno, per capire se oggi ci posso provare o no. D’altra parte, ogni sconfitta avvalora di più le vittorie. Sono uno dei pochi che è riuscito a batterlo. L’ultima volta nel dicembre 2022, due giorni prima che nascesse mio figlio Alexis. Era da cinque anni che nelle sprint nessuno lo batteva e l’ultimo ero stato io nella prima gara dopo Pyeongchang 2018. Quindi sì, è tosta, ma non mi sono mai messo a fare il conto delle medaglie o delle vittorie che avrei potuto ottenere senza di lui.
A proposito di Norvegia, crede che sarà possibile contrastare il loro dominio a Milano Cortina?
No, è proprio impossibile perché essere norvegese ti mette in una condizione di vantaggio nei confronti di tutti a livello di infrastrutture e preparazione. Gli unici che possono auto sabotarsi sono loro, se dovessero soffrire la pressione di dover vincere. I russi sono gli unici che nell’ultimo decennio li hanno contrastati. Quindi non credo che avranno problemi a continuare a dimostrare il valore del loro sistema. Quando ci sono così tanti atleti straordinari, probabilmente non sono tutti lo sono, è il loro sistema che è straordinario nello sci di fondo.
Ha citato la Russia, la loro assenza ormai si protrae da quasi quattro anni. Cosa pensa della loro esclusione?
Lo sport dovrebbe unire e sta alle Federazioni internazionali garantire il regolare svolgimento delle competizioni e la sicurezza degli atleti coinvolti. La FIS non si è assunta questa responsabilità e quindi non gli ha dato la possibilità di competere. Altre federazioni come il tennis, invece sì. Capisco che sia collegato alla politica e possa avere una funzione propagandistica, però penso che per il bene del mondo lo sport debba unire i popoli e non dividerli.
Come vede il futuro dello sci di fondo italiano dopo il suo ritiro e cosa manca per rivedere lo squadrone di qualche decennio fa?
Tanto dipenderà da come andranno queste Olimpiadi. Se centriamo l’obiettivo di un podio a squadre qualcuno continuerà a gareggiare con una medaglia olimpica in bacheca, che dà fiducia nei propri mezzi. Lo sci di fondo è cambiato, ci sono nuovi format, nuove distanze e nuove modalità di competere. Secondo me, c’è stata l’era pre-Northug e l’era post-Northug. Con lui hanno iniziato ad avere valore i cambi di ritmo, perché sia i materiali sia le prestazioni si sono alzate. In passato l’Italia ha fatto grandi risultati solo nei grandi eventi. In Coppa del Mondo, dopo di me il secondo che ha vinto più gare ne ha cinque. Questo fa già capire che l’approccio era diverso. Oggi bisogna essere capaci di fare tante gare ad alto livello.
In passato ha detto che Dorothea Wierer è un’ispirazione. Si sarebbe visto bene come biathleta?
Mi è stato detto di sì, quindi non lo dico io. Mi è stato anche proposto di farlo, di provarci, perché le mie caratteristiche fisiche e mentali sarebbero state giuste per quel tipo di disciplina. Ma ho sparato solo una volta e con una condizione molto particolare. Sicuramente mi sarebbe piaciuto, però a ora non ho la possibilità di riscontro.
L'articolo Federico Pellegrino: “Io portabandiera, vuol dire che qualcosa ho combinato. I russi esclusi? Penso che per il bene del mondo lo sport debba unire” proviene da Il Fatto Quotidiano.
A ridosso della scadenza della tessera sanitaria, generalmente, ne arriva una nuova all’indirizzo di residenza dell’interessato. Può capitare, però, che debba essere lo stesso contribuente ad attivarsi per riceverla: è necessario farlo quando, benché quella vecchia sia scaduta da un po’ di tempo, quella sostitutiva non è stata recapitata. In quel caso occorre recarsi all’Asl competente e accertarsi del motivo.
Documento indispensabile per accedere ai servizi messi a disposizione dal servizio sanitario nazionale, la tessera sanitaria serve anche per acquistare i farmaci da portare in detrazione e deve essere impiegata per accedere alle cure e alle prestazioni mediche che si ricevono all’estero.
La tessera sanitaria scade generalmente dopo sei anni dalla sua emissione, anche se ci sono casi particolari: chi, per esempio, cambia il medico di base scegliendone uno in una regione diversa da quella di residenza avrà un documento con una scadenza annuale. In una situazione simile si trovano i cittadini extracomunitari, la cui tessera sanitaria ha la stessa validità del loro permesso di soggiorno.
Ad ogni modo anche in caso di scadenza non si perde il diritto ad accedere alle prestazioni del servizio sanitario nazionale: chi deve recarsi all’estero ne deve deve chiedere una nuova o può farsi rilasciare un certificato sostitutivo della Team (Tessera Europea Assicurazione Malattia).
Per rinnovare la tessera sanitaria è necessario recarsi all’Asl territorialmente competente o in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederanno a rilasciare un certificato sostitutivo da utilizzare fino a quando non viene recapitato un documento in corso di validità.
Sarà direttamente l’Asl a comunicare al sistema Tessera Sanitaria la richiesta di rinnovo: quella nuova verrà recapitata all’indirizzo associato al codice fiscale.
Chi avesse la necessità di verificare lo stato della richiesta può accedere al portale del Sistema Tessera Sanitaria dove, inserendo il proprio codice fiscale, l’esito della ricerca darà i seguenti risultati: “Non sono presenti Tessere Sanitarie”, “In corso di emissione” o “Spedita”. Se appare la prima o l’ultima voce (ma non è arrivato nulla) è necessario rivolgersi all’Asl per capire cosa stia accadendo. Se, invece, è in corso di emissione si deve attendere che arrivi.
Perché la tessera sanitaria risulta spedita, ma non è mai arrivata a casa? Il disguido potrebbe essere determinato da un errore nella comunicazione del codice fiscale, situazione che rende impossibile all’Agenzia delle Entrate individuare in modo preciso e corretto il contribuente e quindi a rinnovare tempestivamente il documento.
Altro motivo che potrebbe portare al blocco della sua emissione è la mancata iscrizione all’Asl: questo può accadere nel momento in cui nel corso dell’anno precedente sia stato modificato il medico di base per motivi di studio o lavoro. Qualche cosa nella pratica si è inceppato: per sciogliere il problema è necessario rivolgersi all’Asl.
A complicare l’invio potrebbe essersi messo di mezzo un cambio di residenza proprio a ridosso della scadenza della tessera sanitaria: il nuovo indirizzo non è stato comunicato nei tempi utili per il suo invio.
Situazione estrema e particolarmente rara è quella nella quale si trova chi non ha mai ricevuto una tessera sanitaria: anche in questo caso siamo davanti ad un’evidenza anomalia, che può essere determinata da un errore nella comunicazione dei dati o di iscrizione all’Asl.
Perché la tessera sanitaria venga emessa e inviata, infatti, si devono verificare due condizioni: il cittadino deve avere un codice fiscale corretto attribuito dall’AdE e deve essere iscritto all’Asl. Quando ci dovessero essere degli errori in una di queste voci tutto il sistema si blocca: è opportuno, quindi, controllare che tutto sia corretto per poter ricevere il documento.
L'articolo Tessera sanitaria scaduta, cosa fare se non si riceve a casa quella nuova proviene da Il Fatto Quotidiano.
Un “vecchio” farmaco potrebbe aiutare ad affrontare un problema sempre più diffuso e spesso sottovalutato, specialmente tra i più giovani, e cioè il disturbo da uso di cannabis (CUD). La vareniclina, un farmaco che da anni aiuta milioni di persone a dire addio alle sigarette, sembrerebbe in grado di ridurre anche la dipendenza da cannabis. Ma solo negli uomini, molto poco o nulla nelle donne. A metterla alla prova con successo è stato un gruppo di ricercatori della Medical University of South Carolina, in uno studio pubblicato sulla rivista Addiction.
In Italia, la dipendenza da cannabis è un fenomeno reale, con circa il 42% degli utilizzatori cronici che sperimenta sintomi di astinenza (irritabilità, ansia, insonnia) alla sospensione. Il disturbo da uso di cannabis non è solo fumare troppi spinelli: è quando il consumo interferisce con il lavoro, la vita sociale o la salute mentale, provocando ansia, psicosi o disturbi del sonno. Fino ad oggi, i medici si trovavano con le armi spuntate: non esisteva infatti alcun farmaco approvato specificamente per trattare questa dipendenza.
Per questo i ricercatori hanno deciso di testare una “vecchia” conoscenza, la vareniclina, coinvolgendo 174 partecipanti che utilizzavano cannabis almeno tre giorni a settimana. L’idea di base è semplice: se il farmaco funziona bloccando i recettori della nicotina nel cervello, riducendo il piacere di fumare e i sintomi dell’astinenza, potrebbe avere un effetto simile anche sui circuiti cerebrali legati alla cannabis. I risultati hanno dato ragione agli scienziati, ma con un “effetto sorpresa” di genere.
Qui la scienza si fa intrigante. Lo studio ha rivelato che la vareniclina è stata estremamente efficace per gli uomini. I partecipanti maschi che hanno assunto il farmaco hanno ridotto drasticamente le loro sessioni settimanali di consumo (passando da oltre 12 a circa 6-8), mostrandosi molto più capaci di resistere alla tentazione rispetto a chi assumeva un semplice placebo.
Per le donne, invece, la storia è stata diversa. Non solo il farmaco non ha ridotto il consumo, ma le donne nel gruppo vareniclina hanno riportato livelli più alti di ansia, desiderio (craving) e sintomi di astinenza. Questo ha portato a una minore costanza nell’assunzione della terapia, rendendo il trattamento inefficace.
Il perché un farmaco che aiuta entrambi i sessi a smettere con il tabacco si comporti in modo così selettivo con la cannabis non è ancora chiaro. Aimee McRae-Clark, che ha guidato lo studio, ammette che questo è il prossimo grande mistero da risolvere. Tra le ipotesi c’è quella secondo cui il sistema di “ricompensa” del cervello femminile risponda in modo diverso alla combinazione tra vareniclina e cannabinoidi, e anche quella che i fattori ormonali giochino un ruolo decisivo nella gestione dell’astinenza.
“Il disturbo da uso di cannabis è in rapida crescita negli Stati Uniti”, commenta McRae-Clark. “Le attuali opzioni di trattamento farmacologico sono molto limitate, e quindi anche la nostra capacità di aiutare le persone a ridurre il consumo di cannabis è limitata. Il nostro studio – prosegue – ha scoperto che la vareniclina, un farmaco che aiuta le persone a ridurre o smettere di fumare, può essere efficace anche nel ridurre il consumo di cannabis, ma solo per gli uomini. Il nostro prossimo passo è esplorare ulteriormente la vareniclina per il disturbo da uso di cannabis, utilizzando un campione più ampio di donne, per comprendere meglio questa differenza di genere nell’esito del trattamento. Nel frattempo, siamo incoraggiati dal fatto che la vareniclina mostri un potenziale promettente nel trattamento di questo problema in rapida crescita”.
L'articolo Dipendenza da cannabis, un vecchio farmaco anti sigarette funziona. Ma solo negli uomini proviene da Il Fatto Quotidiano.
Parte da Verona un appello alle amministrazioni comunali italiane per chiedere la messa al bando dei Pfas, le sostanze perfluoroalchiliche tristemente note come gli “inquinanti eterni”. Accade nel Veneto devastato dagli effetti della produzione della Miteni di Trissino, che ha contaminato la falda, interessando tre province (Vicenza, Verona e Padova), con 350 mila utenti degli acquedotti. Decine di associazioni, comitati e gruppi organizzati di attivisti (tra cui le Mamme No Pfas, Legambiente, ISDE, Italia Nostra), si sono riunite nel coordinamento Rete Zero Pfas Veneto, avviando mesi fa una campagna mirata ad ottenere dal Parlamento italiano una legge che vieti la produzione, la commercializzazione e l’utilizzo dei Pfas.
“Abbiamo visto che a Bruxelles la Commissione intima al Parlamento europeo di non porre limiti ai Pfas perché ciò comporterebbe ‘rischi per la competitività globale dell’Europa’, in particolare nei settori della produzione di armi, aerospaziale e nella produzione di semiconduttori, ignorando al contempo i gravi effetti sulla salute dei cittadini esposti a queste sostanze” spiegano Luisa Aprili e Marco Corbellari, rispettivamente presidente e segretario dell’associazione “Il mondo di Irene” che ha già coinvolto la quasi totalità dei consigli comunali della provincia veronese. “Contro la protezione industriale dei Pfas ad agire sono i cittadini, a partire da coloro che sono più esposti all’inquinamento. Vogliamo rivoltare il paradigma, mettendo la salute delle persone e la tutela dell’ambiente davanti agli interessi economici”.
La raccolta di adesione formale a livello amministrativo, si è attuata con il testo di una mozione inviata ai comuni del Veneto. È cominciata nel febbraio 2024 e dopo due anni sono 129 le assemblee comunali che hanno approvato il documento. Di queste, 95 si trovano nella provincia di Verona, che è stata coperta quasi totalmente (ne mancano solo 3), grazie all’impegno dell’associazione “Il mondo di Irene” che ha contattato personalmente i sindaci e gli amministratori. La stessa mozione è stata approvata anche dai consigli regionali del Veneto, del Piemonte e dell’Umbria, nonché dai consigli provinciali di Verona e Vicenza. L’adesione è venuta da alcuni comuni in Lombardia, Piemonte e Liguria, ma l’iniziativa punta ora ad allargare la copertura a tutta Italia.
“L’esperienza fatta in provincia di Verona, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni alle sedute dei consigli comunali in occasione dell’approvazione della mozione, ha permesso di creare una rete con gli amministratori e il progetto di un evento divulgativo rivolto a sindaci, amministratori e cittadini che verrà organizzato in collaborazione con la Provincia di Verona nelle prossime settimane” aggiungono Aprili e Corbellari. “Entriamo in una nuova fase, a livello nazionale, per identificare un comune in ogni regione d’Italia dove portare in approvazione la mozione che chiede lo sto dei Pfas. Sarebbe un gesto simbolico di unione nazionale su un problema che erroneamente viene considerato limitato ad alcune aree del paese, mentre riguarda tutti e tutte le realtà, vista la diffusione capillare di queste sostanze nell’ambiente in sul territorio nazionale”.
L'articolo “Pfas indispensabili per le armi? Gravi effetti sulla salute: mettiamoli al bando”: dal Veneto l’appello dei cittadini proviene da Il Fatto Quotidiano.
Dal rientro in classe dopo le vacanze di Natale, in diverse scuole superiori di Roma si fa lezione al freddo. Termosifoni non funzionanti, infiltrazioni d’acqua e aule in parte inagibili hanno spinto studenti e studentesse a scioperare. Una mobilitazione partita il 7 gennaio e che, giorno dopo giorno, sta coinvolgendo sempre più istituti della Capitale. Complice il maltempo, in molti edifici scolastici sono emerse criticità strutturali che vanno dagli allagamenti ai problemi agli impianti di riscaldamento. Ma anche ora che la pioggia si è fermata, i disagi restano. E in sempre più scuole studenti e studentesse hanno deciso di passare all’azione.
È il caso del liceo scientifico Newton, dove la protesta si è concentrata soprattutto sulla succursale di via dell’Olmata 4. Il collettivo Assange ha denunciato “termosifoni non funzionanti in diverse aule, con studenti e docenti costretti a fare lezione al gelo”, e infiltrazioni d’acqua: “Nel corridoio che porta all’aula 105 piove direttamente dal soffitto”. A ilfattoquotidiano.it uno studente racconta una situazione diventata rapidamente insostenibile: “Il freddo era pesante, a tratti insostenibile. C’era gente che stava ferma in aula con il giubbotto. Non era solo un problema di termosifoni: girando per la scuola ci siamo accorti che l’acqua cadeva dal tetto, entrava anche dalle finestre”. Una delle aule, spiega, è stata chiusa. “Ci sono due secchi che raccolgono l’acqua che gocciola, finestre rotte coperte con pezzi di cartone. Durante le vacanze di Natale i termosifoni non sono stati controllati. Ci hanno raccontato che già dal 3 gennaio, giorno di riapertura del plesso, il freddo era insopportabile: alcuni bidelli si sono chiusi tutti in una stanza con il termosifone e il condizionatore accesi, perché si stavano gelando”.






A innescare ulteriori tensioni è stata anche la cancellazione di un murale realizzato all’interno dell’istituto, intitolato “Nous accusons”, dedicato alla denuncia del massacro dello Stato di Israele contro la popolazione palestinese. “Si è trovato il tempo di cancellare il murale – accusano gli studenti – ma non quello di verificare il funzionamento dei termosifoni o di eliminare le infiltrazioni”. Martedì 13 gennaio il collettivo ha organizzato uno sciopero con picchetto alla succursale, chiedendo “un intervento immediato delle istituzioni competenti, trasparenza e responsabilità da parte della dirigenza e, soprattutto, il rispetto delle nostre opinioni”.
Ma il Newton non è un caso isolato. Al liceo classico Pilo Albertelli e all’Enzo Rossi le proteste si sono concentrate su problemi strutturali e sul malfunzionamento degli impianti di riscaldamento. Al liceo scientifico Francesco d’Assisi il collettivo studentesco denuncia dall’8 gennaio “termosifoni non funzionanti nella sede di viale della Primavera”. “Da oltre cinque giorni cinque classi segnalano il problema”, spiega il collettivo, “ricevendo come risposta che saranno sistemati il giorno dopo. Nelle classi si gela e la situazione non è cambiata”. Alcune classi sono state spostate, “ma non c’è posto per tutte”, mentre “studenti e docenti fanno lezione al freddo”. Le criticità riguardano anche le palestre, “fredde e in parte chiuse per lavori mai conclusi”, e il cortile, giudicato inagibile. “Se non avremo risposte ce le prenderemo” avvertono.
Dopo il Newton, la protesta ha iniziato a dilagare. Dal Pilo Albertelli al Malpighi, passando per l’Enzo Rossi, fino al Pacinotti-Archimede e al liceo Primo Levi, dove studenti e studentesse hanno scelto di non entrare in classe per denunciare termosifoni spenti e aule impraticabili. E l’elenco continua ad allungarsi: segnalazioni arrivano anche dal Virgilio, dal Machiavelli e dal Plinio Seniore. Archiviata la stagione delle occupazioni, lo scontro si sposta ora sulle condizioni materiali degli edifici scolastici: aule gelide, infiltrazioni, lavori mai conclusi. Problemi strutturali che il maltempo di gennaio ha reso impossibili da ignorare e che oggi riportano gli studenti davanti ai cancelli delle scuole. Con l’avvertimento che, senza risposte concrete, la stagione delle occupazioni potrebbe non essere affatto chiusa.
L'articolo “A scuola piove dal soffitto. I termosifoni sono rotti e si fa lezione al freddo”: la protesta degli studenti dei licei di Roma proviene da Il Fatto Quotidiano.
L’ipotesi di nuovi dazi statunitensi contro i Paesi europei che sostengono la Groenlandia apre un fronte delicato soprattutto per l’industria automobilistica, uno dei settori più esposti nei rapporti commerciali tra Europa e Stati Uniti. A lanciare l’allarme è l’associazione tedesca dell’auto, la VDA, che parla di costi “enormi” per i costruttori europei, a partire dalla Germania.
Il mercato americano è infatti strategico per i grandi gruppi tedeschi. Marchi come Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz esportano ogni anno centinaia di migliaia di veicoli negli Stati Uniti, dove realizzano una quota rilevante dei loro ricavi. L’introduzione di dazi del 10%, con la minaccia di un aumento fino al 25%, inciderebbe direttamente sui prezzi finali delle auto europee, riducendone la competitività rispetto ai modelli prodotti localmente o provenienti da Paesi non colpiti dalle tariffe.
Per i costruttori tedeschi il problema non riguarda solo le vetture finite. I dazi colpirebbero anche componenti e semilavorati, con effetti a catena su tutta la filiera: fornitori, logistica e stabilimenti produttivi. In un settore già sotto pressione per la transizione verso l’elettrico e per l’aumento dei costi energetici, un ulteriore aggravio tariffario rischia di comprimere i margini e rallentare gli investimenti.
Le conseguenze si estenderebbero rapidamente oltre i confini tedeschi. L’industria automobilistica europea è fortemente integrata: molte auto esportate dalla Germania contengono componenti prodotti in altri Paesi dell’UE. Un calo delle vendite negli Stati Uniti potrebbe quindi tradursi in minori volumi produttivi anche in Francia, Italia, Europa orientale e nei Paesi nordici.
Secondo la VDA, una risposta frammentata sarebbe inefficace. Serve invece una strategia comune dell’Unione Europea (ra le possibili opzioni lo Strumento anti-coercizione evocato dal presidente francese Macron), capace di tutelare un settore che rappresenta uno dei pilastri dell’economia continentale in termini di occupazione, innovazione ed export. Ne va della tenuta dell’industria dell’auto continentale e del futuro delle relazioni commerciali transatlantiche.
L'articolo Groenlandia, l’auto europea nel mirino. Dalla Germania la VDA lancia l’allarme sui dazi USA proviene da Il Fatto Quotidiano.
L’idea del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di predisporre metal detector nelle scuole dove venga fatta richiesta non passa al vaglio dei dirigenti scolastici. A classificare come una “boutade” le parole dell’inquilino di viale Trastevere sono i capi d’istituto delle secondarie che si trovano nei quartieri più difficili del Paese. Una risposta, quella del professore leghista, che viene definita “sbagliata”, “irrealizzabile”, “fallimentare”. La stretta sui coltelli, annunciata dal governo, viene recepita come “misura repressiva” senza che sia accompagnata da altri progetti educativi. Il richiamo “alla responsabilità” e “alla maturità” fatto dal ministro leghista passa in secondo piano rispetto alla misura avanzata dei controlli agli ingressi: “Non metal detector generalizzati ovunque ma solo dove venga fatta espressa richiesta”, ha detto Valditara. A detta dei capi d’istituto nessun preside penserebbe a questa misura.
“Intanto va chiarito che non è praticabile. Sarebbe un delirio perché ogni mattina al suono della campanella ci sarebbero ragazzi che devono tirar fuori dalle tasche le chiavi, gli accendini, gli occhiali”, spiega Ludovico Arte, dirigente dell’istituto professionale “Marco Polo” di Firenze che si trova nel quartiere dell’“Isolotto”. Per il professore fiorentino il caso di La Spezia va ridimensionato e analizzato puntando gli occhi alla dimensione educativo affettiva: “Da parte di una percentuale ancora rilevante di maschi permane un atteggiamento morboso, possessivo che talvolta trova anche un certo compiacimento nelle ragazze. Dobbiamo ragionare su questo”.
Per Arte, i metal detector assolverebbero la scuola ma non la società perché quel fatto sarebbe comunque accaduto. La pensa così anche Angelo Cavallaro, dirigente dell’Istituto comprensivo “Catalfamo”, nella difficile zona di “Santa Lucia” a Messina: “Se un accoltellamento, un’aggressione non avviene nelle aule grazie ai controlli può succedere nel cortile, davanti all’ingresso. Il metal detector assolve il preside ma non la società”.
A puntare il dito contro la proposta del ministro è anche Giusto Catania che da anni guida l’istituto comprensivo “Giuliana Saladino” di via Filippo Parlatore al Cep di Palermo: “Di fronte ai vandalismi abbiamo messo le grate alle finestre ma non sono servite a nulla. La logica non può essere quella repressiva. Se un giovane pugnala un compagno per ragioni di gelosia bisogna lavorare sull’educazione affettiva. La scuola deve fare quel che sa fare: educazione. Nella mia scuola agiamo in un contesto difficile, in un’area periferica di Palermo con un alto tasso di criminalità: è capitato che si registrassero atti di violenza ma li abbiamo arginati, compresi, limitati, risolti con l’agire educativo”.
A essere delusa dalle parole di Valditara è anche Maria Rosaria Autiero, la dirigente del liceo “Amaldi” a Tor Bella Monaca, Roma: “Se arriviamo a mettere i metal detector a scuola, la società è fallita. Dobbiamo farci qualche domanda: Quali sono i modelli educativi degli adulti? Penso alla serie televisive dove la violenza è spesso l’unica soluzione delle relazioni”.
Ad intervenire sulla vicenda è anche l’Unione degli studenti: “Di fronte al moltiplicarsi di episodi di violenza legati alla presenza di armi nelle scuole, il ministro propone l’introduzione di metal detector negli istituti considerati “più problematici”, rilanciando una visione securitaria e repressiva della scuola pubblica. La violenza non si combatte trasformando le scuole in caserme – di Federica Corcione, membro dell’esecutivo nazionale dell’Unione degli Studenti –. La militarizzazione degli spazi educativi è una scelta fallimentare e pericolosa, che scarica sugli studenti le responsabilità di un sistema che non funziona”.
L'articolo “Metal detector a scuola? Irrealizzabile”. Dal tempo per i controlli alle zone scoperte, la testimonianza dei presidi di quartieri a rischio proviene da Il Fatto Quotidiano.


© RaiNews
© RaiNews


© RaiNews

Mario Draghi ha ricevuto il Premio internazionale Carlo Magno, uno dei riconoscimenti europei più prestigiosi, e ha colto l’occasione per lanciare l’ennesimo avvertimento all’Unione europea. In un videomessaggio, l’ex presidente della Banca centrale europea ed ex presidente del Consiglio italiano ha parlato di un’Europa mai così esposta a rischi e tensioni. «In questo momento l’Europa ha molti nemici, forse più che mai, sia interni che esterni», ha detto Draghi, sottolineando la necessità di una risposta comune più solida.
Secondo Draghi, per preservare il futuro dell’Unione, gli europei devono essere «più uniti che mai» e superare quelle che ha definito «le nostre debolezze autoinflitte». La ricetta è netta e ricalca le conclusioni del suo Rapporto sulla competitività europea, presentato nel 2024 su mandato della Commissione guidata da Ursula von der Leyen: «Dobbiamo diventare più forti: militarmente, economicamente e politicamente». Un messaggio che torna in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina, dalla competizione strategica con la Cina, dalle tensioni con gli Stati Uniti e dalla crescita delle forze euroscettiche all’interno dell’Unione.
La Fondazione internazionale Premio Carlo Magno ha motivato l’assegnazione del riconoscimento richiamando alcuni passaggi centrali della carriera di Draghi: dal ruolo decisivo avuto durante la crisi dell’euro, con il celebre «whatever it takes» del 2012, fino all’impegno più recente per rilanciare la competitività europea. Il Rapporto Draghi viene definito «un’opera eccezionale al servizio dell’Unione europea», e la sua attuazione viene indicata come urgente in una fase definita «drammatica», in cui l’Europa rischia «di diventare un giocattolo nelle mani di altre potenze».
A distanza di oltre un anno dalla presentazione del Rapporto, molte delle sue raccomandazioni – dalla difesa comune al completamento del mercato unico, dagli investimenti tecnologici alla transizione energetica – restano però in larga parte inattuate. Draghi continua a indicare una strada precisa: più integrazione, più capacità decisionale, più Europa. Anche a costo di una nuova cessione di sovranità.
Il premio, assegnato dal 1950 a figure che hanno contribuito in modo significativo all’integrazione europea, colloca Draghi in una lista che include personalità come Alcide De Gasperi, Winston Churchill, Jean Monnet, Angela Merkel, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky, premiato insieme al popolo ucraino. Draghi è il quinto italiano a riceverlo.
L'articolo L’Europa ha più nemici che mai, dice Mario Draghi proviene da Linkiesta.it.

Alla Casa Bianca è stato chiarito dai vertici di Central Intelligence Agency e Pentagono che un intervento militare di vasta portata contro l’Iran difficilmente produrrebbe l’effetto di disarticolare il sistema di potere della Repubblica islamica. Al contrario, un’azione armata su larga scala rischierebbe di innescare una spirale di instabilità regionale, con conseguenze difficilmente controllabili. È proprio questo scenario, condiviso dagli altri apparati di sicurezza statunitensi e partner mediorientali, ad aver rallentato le decisioni di Donald Trump, frenato dal timore che un’operazione diretta possa precipitare l’Iran in un caos ancora più profondo.
Secondo le valutazioni presentate al presidente, una offensiva estesa richiederebbe un significativo rafforzamento del dispositivo militare americano in Medio Oriente, sia per sostenere le operazioni sia per proteggere le forze statunitensi e gli alleati, Israele in testa, da possibili ritorsioni iraniane. Gli stessi dossier avrebbero però messo in evidenza come nemmeno una campagna bellica massiccia garantirebbe la caduta del regime, aumentando invece il rischio di un conflitto allargato. L’Iran dispone di uno dei più grandi apparati militari del Medio Oriente, fondato su numeri elevati e su una forte componente ideologica. L’esercito regolare, l’Artesh, conta circa 350.000 militari attivi e 350.000 riservisti, distribuiti tra forze terrestri, marina, aeronautica e difesa aerea, con compiti di protezione del territorio e delle infrastrutture strategiche. Il centro del potere armato resta però nelle mani del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Pasdaran), che schierano circa 190.000 effettivi. Al loro interno operano la componente aerospaziale, responsabile di missili balistici e droni, e la Forza Quds, impegnata all’estero con 5.000-15.000 uomini. Sul piano interno il regime può inoltre contare sulla Basij, una milizia paramilitare con 1-2 milioni di membri registrati, di cui 300.000.600.000 realmente mobilitabili in tempi rapidi. Nel complesso, l’Iran dispone di circa 540.000 militari attivi e può superare 1,2-1,5 milioni di uomini in caso di mobilitazione, su una popolazione di circa 89 milioni. Un peso numerico enorme, compensazione a limiti tecnologici e addestrativi attraverso repressione interna e guerra asimmetrica.
Opzioni militari più limitate, basate su azioni circoscritte e mirate, potrebbero offrire un sostegno simbolico ai manifestanti iraniani, rafforzandone temporaneamente la determinazione. Tuttavia, secondo i consiglieri della Casa Bianca, simili iniziative non sarebbero in grado di scalfire l’apparato repressivo di Teheran né di modificarne in modo strutturale il comportamento. In questo contesto, Trump non ha ancora assunto una decisione definitiva su quale strada intraprendere. Ha però chiesto che le risorse militari necessarie siano pronte qualora optasse per un’operazione di maggiore intensità. L’amministrazione ha fatto sapere di aver trasmesso messaggi diretti al regime iraniano, avvertendo che la prosecuzione delle uccisioni dei manifestanti comporterebbe conseguenze severe. Allo stesso tempo, è stato ribadito che solo il presidente, affiancato da un ristrettissimo gruppo di consiglieri, sta valutando le opzioni sul tavolo tuttavia, dal punto di vista della comunicazione quanto accaduto fin qui è un disastro completo tra annunci roboanti e altrettante retromarcie.
Washington ha inoltre riferito di essere venuta a conoscenza di un presunto piano iraniano che prevedeva l’esecuzione di centinaia di persone, un’ipotesi che alla fine non si sarebbe concretizzata. È stata confermata anche una recente conversazione tra Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo fonti informate, Israele avrebbe espresso forti riserve sull’efficacia di un’azione militare diretta, temendo che non porti a un rapido collasso del regime. Nel frattempo, all’interno dell’apparato di sicurezza statunitense sarebbero circolati materiali sensibili, inclusi video riservati che documenterebbero la morte di manifestanti iraniani durante la repressione. Queste immagini sarebbero state esaminate mentre il presidente e i vertici della Casa Bianca valutavano le diverse opzioni operative. Anche se isolata Teheran ha intensificato i contatti con diversi Paesi della regione – tra cui Turchia, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Oman – per avvertire che qualsiasi iniziativa militare contro l’Iran provocherebbe una risposta diretta contro obiettivi statunitensi. Tra i bersagli più sensibili figura la base aerea di Al Udeid, in Qatar, principale snodo militare degli Stati Uniti nel Golfo. Secondo fonti informate, proprio il rischio di una rappresaglia iraniana contro Al Udeid avrebbe spinto Washington ad adottare misure precauzionali, inclusa la temporanea ridislocazione di parte del personale militare. Nel frattempo, diversi alleati regionali degli Stati Uniti hanno intensificato gli sforzi diplomatici per dissuadere Trump dal ricorso alla forza. Ankara, Doha e Riad hanno espresso con forza la loro contrarietà a un’escalation armata, temendo ripercussioni destabilizzanti sull’intera area.
Nonostante queste pressioni, il Pentagono starebbe predisponendo il trasferimento di una portaerei statunitense dal Pacifico al Medio Oriente, segnale che indica come l’opzione militare resti comunque aperta. I tempi tecnici suggeriscono che un’eventuale offensiva richiederebbe diversi giorni di preparazione. Le discussioni interne alla Casa Bianca mostrano tutta la complessità di tradurre la linea dura annunciata da Trump in una strategia efficace. È proprio il timore che un intervento contro l’Iran finisca per aggravare il disordine interno e incendiare l’intero Medio Oriente ad aver imposto una pausa alle decisioni della Casa Bianca, congelando per ora le scelte più drastiche.
L'articolo Trump teme caos ed escalation in Iran, per questo esita proviene da Linkiesta.it.

Per anni il Venezuela ha investito massicciamente in hardware militare di fabbricazione cinese, etichettando con orgoglio le proprie difese come le più moderne del Sud America. Il cuore del progetto di difesa aerea costruito in Cina e poi venduto al regime di Nicolás Maduro era imperniato sui cosiddetti radar anti-stealth, progettati per localizzare e contrastare i cacciabombardieri stealth (invisibili) statunitensi. Era stato immaginato fin dall’inizio come un efficace «scudo cinese» in grado di proteggere il regime di Maduro da un attacco aereo statunitense. Quando, però, all’inizio dell’anno, gli Stati Uniti hanno lanciato l’operazione Absolute Resolve, con la clamorosa cattura del dittatore, la linea difensiva venezuelana è crollata in pochi minuti.
L’azione militare statunitense ha messo in luce la clamorosa discrepanza esistente fra la narrazione cinese sull’efficacia dei propri sistemi di armamento e la realtà sul terreno. Il Venezuela aveva acquisito il sistema radar a lungo raggio JY-27 Wide Mat, di fabbricazione cinese, per proteggersi esattamente da operazioni offensive come quella di inizio gennaio. E sono proprio i radar cinesi i primi asset della difesa venezuelana a essere stati neutralizzati nelle fasi iniziali dell’operazione militare.
Da tempo i media cinese esaltavano i radar JY-27, come veri e propri «cacciatori di velivoli invisibili» in grado di rilevare in anticipo gli spostamenti degli F-22 e degli F-35 a distanze di centinaia di chilometri. La propaganda cinese, accompagnata dalle massicce azioni di disinformazione nei confronti di governi e opinione pubblica occidentale, ha raccontato di traguardi tecnologici inesistenti nel settore militare: il millantato «aggancio» da parte dei radar cinesi dei caccia americani, verso cui poter poi guidare i missili terra-aria, si è rivelato essere una grande illusione.
I velivoli da guerra elettronica EA-18G Growler hanno saturato l’etere fin dai primi muniti dell’azione militare, accecando i sensori di produzione cinese e nel giro di poche ore. I missili antiradar statunitensi hanno individuato e distrutto tutti i siti radar in territorio venezuelano.La difesa «cinese» non è stata in grado di rilevare neppure un singolo velivolo statunitense. L’accecamento dei sensori venezuelani ha lasciato paralizzata l’intera rete di comando della difesa aerea fornita dalla Cina nella fase iniziale dell’operazione. Un vasto blackout elettrico ha ulteriormente aggravato il caos, interrompendo nodi di comando e controllo e collegamenti dati in tutto il Paese. Il Venezuela disponeva anche dei sistemi missilistici terra-aria forniti dalla Russia (batterie S-300V e Buk-M2), che avrebbero dovuto operare in tandem con i radar cinesi, formando una difesa aerea stratificata. La «formidabile» difesa russo-cinese è stata messa fuori combattimento in pochi minuti determinando così la superiorità aerea statunitense che ha permesso a quasi 150 velivoli di operare indisturbati nel cielo venezuelano. Secondo fonti dell’opposizione venezuelana, oltre il 60% dei siti radar di Caracas erano già fuori servizio a causa della carenza di pezzi di ricambio e di un supporto tecnico «minimo» fornito dalla Repubblica popolare cinese.
Una volta stabilita la superiorità aerea statunitense, le forze terrestri venezuelane equipaggiate con mezzi cinesi non hanno avuto miglior sorte: prive di copertura aerea e di sorveglianza in tempo reale, sono diventate bersagli facili. Molte delle attrezzature militari fornite da Pechino al regime di Maduro si sono rivelate inefficaci: i carri leggeri anfibi VN-16 e i veicoli da combattimento per la fanteria VN-18 della cinese Norinco; i sistemi lanciarazzi multipli SR-5, molto pubblicizzati in Cina; i missili antinave cinesi C-802A non hanno retto l’impatto tecnologico dell’offensiva statunitense e sono stati neutralizzati in poche ore.
Ma accanto al flop delle forniture belliche cinesi che hanno reso sempre meno credibile la capacità di Pechino di proporsi come fornitore di armamenti «alternativo» all’Occidente, la breve azione militare statunitense e la cattura di Maduro hanno rappresentato un duro colpo geopolitico e militare all’intero asse delle autocrazie. Il Venezuela di Hugo Chávez e Maduro da oltre vent’anni rappresentava il vero pilastro latino-americano del sempre più assertivo network delle dittature. Una delegazione di alto livello cinese era a Caracas per incontrare Maduro nella notte del blitz americano e la Repubblica popolar cinese, accanto alle forniture belliche, importava oltre l’80% del greggio venezuelano con l’acquisizione di 764.000 dei 921.000 barili di petrolio che ogni giorno venivano prodotti nel Paese. Il meccanismo cinese, fissato fin dai tempi di Chávez, era quello dei loans for oil: ingenti prestiti, valutati in oltre 60 miliardi di dollari fra il 2010 e il 2025, garantiti dalle future esportazioni di petrolio.
L’accordo con la Russia era il secondo pilastro della politica estera della repubblica boliviana del Venezuela: nel maggio del 2025 il patto strategico fra i due paesi era stato rinnovato con un rafforzamento della cooperazione in settori chiave come energia, difesa, tecnologia, commercio e sicurezza. Mosca ha spesso usato Caracas per le sue spericolate operazioni diplomatiche, come accaduto dopo la breve guerra Georgia del 2008, quando l’azione militare russa fece nascere dal territorio georgiano le due auto proclamate repubbliche dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud, prontamente (e unicamente) riconosciute da Caracas.
Infine, l’Iran per il quale Caracas rappresentava un luogo sicuro per una molteplicità di attività covert dal riciclaggio, al narcotraffico, al commercio di armamenti, alle forniture di petrolio, alla condivisione di intelligence. Senza dimenticare la pluralità di rapporti fra il Venezuela e la rete dei proxy di Teheran, a cominciare da Hezbollah, fortemente radicato nel Paese con campi di addestramento e numerose azioni di fund-raising illegale.
L'articolo Il mito cinese, e la disfatta venezuelana dell’asse delle autocrazie proviene da Linkiesta.it.

«C’erano molte parole che non sopportavo di sentire e alla fine solo i nomi e i luoghi avevano dignità». Il regista ucraino Mstyslav Chernov affida a quest’epigrafe firmata da Ernest Hemingway nel 1929 il senso del suo ultimo lavoro documentaristico sul conflitto in corso in Ucraina, “2000 metri ad Andriivka”.
Già vincitore dell’Oscar per miglior documentario con “20 Days in Mariupol”, Chernov spinge ancor più in là le leve della ripresa in diretta, con questa sua potente e straziante testimonianza dalla prima linea del fronte, durante la controffensiva ucraina dell’estate del 2023. Il documentario, tra i candidati all’Oscar di quest’anno, e trasmesso dalla PBS in Usa, ora esce anche da noi, in sala per pochi giorni, dal oggi (19 gennaio, ndr) – merito della distribuzione indipendente Wanted.
Fedele allo stile asciutto della prosa di Hemingway, il suo racconto della battaglia infinita per liberare il villaggio occupato di Andriivka, preciso e senza retorica, procede grazie a una troupe che filma all’interno di una piccola squadra d’assalto. Anche quando Chernov ritaglia alcuni momenti di sparute conversazioni con i militari, il tono rimane pacato, le poche domande rivolte negli angusti spazi di buchi scavati nel terreno per ripararsi dai cecchini russi, sono dirette, essenziali, nessun giro di parole.
Il comando militare affida dunque a una piccola squadra l’ennesimo tentativo di attraversare un lembo di terra che porta ad Andriivka, per liberarla e issarvi la bandiera ucraina. Il lembo di terra consiste in una foresta ormai incenerita e distrutta che taglia in due i campi minati, unica via per arrivare al villaggio. I militari, tutti giovani volontari, ne parlano come di una foresta maledetta, perché troppi uomini sono caduti tra quei rovi spolpati dal fuoco delle munizioni. «È come arrivare in un altro pianeta, dove tutto vuole ucciderti», e Chernov: «Ma non è un altro pianeta, siamo nel cuore dell’Europa». Durante i preparativi della spedizione, si rimane impressi da una frase del regista: «Indossare il gilet blu da giornalisti non è più un’opzione, rende bersagli prioritari». Sono 2.000 metri quelli della striscia da percorrere, «35 secondi per il volo di un proiettile di mortaio, due minuti di macchina, dieci minuti di corsa. Ma qui il tempo non conta, conta la distanza e si misura dalle pause tra le esplosioni». Gli raccontano che per tre volte hanno tentato di attraversarla, la foresta maledetta, e a metà strada venivano falciati dai russi. I blindati non possono passare, si può solo andare a piedi. Tre mesi – giugno, luglio, agosto –, un villaggio. Questa volta, se la troupe è fortunata, potrà filmare il momento in cui Fedya, nome in codice del capo squadra che attende in postazione avanzata, isserà la bandiera ucraina ad Andriivka. «Sono arrivate le matite», così viene accolta la troupe di Chernov al posto di comando, nel caso i russi siano in ascolto con i loro sistemi di comunicazione. Una guerra ibrida, metà nel fango e l’altra metà davanti a schermi e tastiere che manovrano e guidano i movimenti sul campo, occhi e orecchie che hanno il suono fastidioso e persistente dei droni.
Il documentario restituisce tutto questo, anche quando fa vedere che anche la più avanzata tecnologia non riesce a salvare gli uomini nel fango. Insieme alla squadra d’assalto la troupe procede e filma i primi feriti, gli ucraini urlano ai russi di uscire dalle loro buche, qualcuno viene trascinato fuori, «Cosa siete venuti a fare qui?», la rabbia per una guerra imposta dall’aggressore russo. Ma c’è qualche minuto di pausa in cui Chernov ci presenta il militare di collegamento con Fedya. Il suo nome in codice è Freak, 22 anni, ex studente del Politecnico, arruolato volontario, rimarrà ferito in una battaglia cinque mesi dopo, il suo corpo mai ritrovato. A metà strada, a mille metri dalla meta, un’altra pausa e uno scambio di battute in un buco della foresta, Chernov: «Sono ritornato nei luoghi della Kharkiv liberata, ma sono tutti spariti, si cammina su rovine e tombe. Sembra che stiano liberando casa ma sono solo rovine. Quindi stanno liberando i nomi dei luoghi, e issano la bandiera affinché tutto il Paese sappia che questo nome è stato liberato». Fedya accoglie la troupe con un esuberante «Benvenuti a Ground Zero!». Perché combattere per dei luoghi dove non c’è più nulla? «Perché tutto verrà ricostruito, si ricomincia da zero, senza l’influenza dei russi». Lo scetticismo dolente di Chernov è palpabile davanti a tanta fiducia.
Il cinema americano ci ha abituati ai film di guerra, ma anche i più realistici, quelli girati con le tecniche più sofisticate, e attori memorabili, non arrivano alla forza di un documentario come questo: nessuna concessione spettacolare, nessun esercizio di stile, solo quello che è, una guerra in diretta, subita e combattuta nonostante tutto. E tremendamente vicina a noi.
Andriivka, un cumulo di macerie, vede di nuovo la bandiera ucraina, issata su un rudere, il 16 settembre 2023, dopo mesi di tentativi e una scia di vite umane perdute. «E se questa guerra durasse tutta la vita?», si chiede Sheva, 46 anni, preoccupato per la moglie e il figlio piccolo, ma anche per un pozzo da riparare che ormai non dà più acqua pulita. L’obiettivo della troupe è compiuto. Ma il villaggio della foresta maledetta e altri territori conquistati durante la controffensiva del 2023 passeranno di nuovo nelle mani dei russi.
L'articolo Tra rovine e speranza, la controffensiva ucraina raccontata da Chernov proviene da Linkiesta.it.

Davanti agli ennesimi dazi usati come minaccia-ricatto da Donald Trump, questa volta ai Paesi alleati che hanno deciso di inviare truppe per difendere la Groenlandia dalle mire dello stesso presidente degli Stati Uniti, l’Unione europea sta valutando diverse risposte. La palla è nel campo di Bruxelles, perché la competenza in materia è esclusiva della Commissione europea, che può avviare contenziosi, imporre controdazi o attivare strumenti di difesa commerciale e anti-coercizione, con misure valide per l’intero mercato unico. E se una reazione ci sarà, sarà con ogni probabilità coordinata con il Regno Unito, uno dei Paesi colpiti dai dazi al 10% dal 1° febbraio (e al 25% dal 1° giugno).
I due principali partiti al Parlamento europeo hanno chiesto la sospensione dall’accordo di Turnberry siglato a luglio dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal presidente Trump dopo che questi aveva finito una partita nel suo golf club scozzese. Manfred Weber e Iratxe García Pérez, presidenti rispettivamente di popolari e social-democratici, hanno fatto la prima mossa. E sono stati seguiti a stretto giro da Valérie Hayer, presidente del centrista Renew, quarto partito al Parlamento europeo (con un seggio in meno dei conservatori).
In ballo c’è, oltre alla sospensione dell’intesa, anche l’utilizzo dello strumento anticoercizione, ovvero il regolamento europeo che l’Unione europea ha adottato per reagire a misure di coercizione economica da parte di Paesi terzi, nato anche dopo le restrizioni cinesi contro la Lituania. La coercizione è definita come misure commerciali volte «a impedire o ottenere la cessazione, la modifica o l’adozione di un determinato atto da parte dell’Unione o di uno Stato membro», interferendo nelle scelte sovrane.
La Commissione può avviare la procedura d’ufficio o su richiesta di uno Stato membro e deve agire «con sollecitudine». Se la valutazione legale conferma la coercizione, la proposta viene inviata agli Stati membri e l’attivazione richiede una maggioranza qualificata; anche gli Stati devono agire rapidamente. Lo strumento, soprannominato trade bazooka, autorizza misure di ritorsione come dazi, controlli alle esportazioni e restrizioni su accesso al mercato, investimenti, servizi e appalti pubblici.
Finora non è mai stato usato: la sua efficacia e rapidità sono quindi incerte. Finora è servito soprattutto da deterrente, ma la mancanza di attivazioni (anche contro i dazi di Trump e le restrizioni cinesi sulle terre rare) ha fatto discutere sulla volontà dell’Union europea di applicarlo concretamente. Inoltre, pur non essendoci veti individuali, serve forte sostegno politico: riserve di Paesi come Germania e Italia hanno già indebolito la posizione della Commissione.
Ma il contesto attuale sembra diversa: se l’uso dei dazi del 10% fosse ritenuto volto a interferire nella sovranità della Danimarca o di altri Stati per le truppe inviate a difesa della Groenlandia, lo strumento offrirebbe una via legale per reagire. Ma la decisione finale dipenderebbe dalla coesione politica e dalla disponibilità a sostenere eventuali costi economici.
Intanto, ieri i 27 ambasciatori di Paesi dell’Unione europea hanno discusso anche altre misure ritorsive elaborate per dare ai leader un peso negli incontri cruciali con il presidente degli Stati Uniti al World Economic Forum di Davos questa settimana. A rivelarlo è stato il Financial Times: le capitali europee starebbero valutando un pacchetto di 93 miliardi di euro di dazi come rappresaglia agli annunci arrivati dagli Stati Uniti o della possibilità di escludere le aziende americane dal mercato dell’Unione. L’elenco dei dazi, si spiega, era stato preparato lo scorso anno, ma sospeso fino al 6 febbraio per evitare una guerra commerciale a tutto campo.
L'articolo Che cos’è il bazooka commerciale che l’Ue può usare contro Trump proviene da Linkiesta.it.

Volevo scriverlo da tempo, e in qualche modo devo averlo fatto di sicuro, ma per fornire una compiuta elaborazione della mia teoria aspettavo l’occasione giusta, che si è presentata sabato, con il seguente post sul profilo X della Lega (tra i numerosi crimini per cui spero un giorno Elon Musk venga processato dovrebbe esserci anche l’averci costretti a questa interminabile perifrasi, laddove fino a ieri bastava dire «tweet»): «Altri dazi di Trump? La smania di annunciare l’invio di truppe di qua e di là raccoglie i suoi amari frutti. Bene per l’Italia essersi chiamati fuori da questo bellicismo, parolaio e dannoso, dei deboli d’Europa». Ci sarebbero molte cose da osservare su una simile dichiarazione: dalla scarsa padronanza delle concordanze e della lingua italiana in genere al disprezzo riservato ai «deboli d’Europa» (lo sentite anche voi, vero, l’inconfondibile retrogusto anni Trenta?), ma non è su questo che volevo concentrarmi, bensì sull’uso, in tale contesto, ma anche in qualsiasi altro contesto, della parola «bellicista». Infallibile indicatore, non voglio dire di malafede o stupidità – sebbene la statistica non scoraggi certo questa interpretazione – ma di una precisa forma di manipolazione, consistente nel rovesciamento del nesso causale, della realtà e delle responsabilità. Che si tratti della guerra in Ucraina, dove «bellicista» non è mai riferito ai russi che l’hanno invasa, ma sempre agli europei che vogliono aiutarla a difendersi, o appunto della Groenlandia minacciata d’invasione da Trump, come nell’esemplare post appena citato, il giochetto è sempre lo stesso.
Ora però la questione non riguarda più qualcun altro. Ora tocca a ciascuno di noi far sentire la propria voce e dire da che parte vogliamo vedere schierato il nostro paese. Giorgia Meloni continua infatti a recitare la parte della grande mediatrice, un ruolo che per troppo tempo e con troppa facilità in tanti le hanno riconosciuto, incoraggiandola e legittimandola, da Ursula von der Leyen al fior fiore della politica e della stampa europea. Una furbizia che si è ritorta contro di loro e presto si ritorcerà anche contro di noi, a mano a mano che i leader europei decideranno di averne abbastanza dei giochi di parole e dei doppiogiochismi italiani, come quando ieri Meloni è arrivata a spiegare la tensione con un «problema di comprensione e comunicazione» tra Unione europea e Stati Uniti.
Come scrive Carmelo Palma su Linkiesta, «nella geopolitica della malafede, Meloni ha dovuto, per l’ennesima volta, mostrare di credere a qualcosa che non esiste, cioè alle presunte preoccupazioni di sicurezza americane, per eludere l’unico problema che è sul tavolo e che è costituito dall’ordine di Trump che gli si consegni, senza tante storie, l’isola più grande del mondo». Naturalmente le parole di Meloni si possono anche interpretare in modo più benevolo, come un estremo tentativo di offrire a tutti i contendenti un modo di salvare la faccia e trovare un punto d’intesa, così da evitare il peggio. Ma il punto è proprio questo: ormai è evidente che continuare sulla linea della cosiddetta mediazione è la via più breve verso la fine dell’Unione europea e la totale sottomissione dei suoi membri alla legge del più forte. Nell’ultimo anno i leader dell’Ue, nota Gideon Rachman sul Financial Times, «hanno provato con l’appeasement e l’adulazione. Ed è qui che questa strategia li ha portati. Devono cambiare rotta immediatamente». Una replica del penoso spettacolo di volontario asservimento e inconsapevole autolesionismo andato in scena nella trattativa sui dazi, anche grazie all’impegno della nostra grande mediatrice, sarebbe il colpo di grazia, per l’Alleanza Atlantica e per la stessa Unione europea.
Leggi anche l’editoriale di Christian Rocca su questo tema.
Questo è un estratto di “La Linea” la newsletter de Linkiesta curata da Francesco Cundari per orientarsi nel gran guazzabuglio della politica e della vita, tutte le mattine – dal lunedì al venerdì – alle sette. Più o meno. Qui per iscriversi.
L'articolo «Bellicista», infallibile indicatore di manipolazione della realtà proviene da Linkiesta.it.

I fiancheggiatori della mafia e i consumati uomini di mondo a rimorchio o contratto del potere mafioso irridono gli sfigati che fanno i fenomeni e rifiutano di pagare il pizzo agli esattori del capo mandamento. E se poi succede loro qualcosa di brutto, non si può dire che non se la siano cercata. Allo stesso modo, la destra politico-giornalistica, in Italia, di fronte alla notizia dei nuovi dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump contro i Paesi contrari all’annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, censura la «stupida provocazione» (Mario Sechi, direttore di Libero) dell’Europa, quando non festeggia direttamente (Claudio Borghi, senatore della Lega) la punizione inflitta ai Paesi disobbedienti e i vantaggi immaginari che le barriere tariffarie contro Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Finlandia e la recalcitrante Danimarca procurerebbero all’economia italiana.
Come c’era da aspettarsi, i più moderati e prudenti e i meno fessi della compagnia ora propongono la linea della responsabilità, che nella neolingua sovranista e para-sovranista significa cercare di aggiustare le cose e minimizzare le conseguenze di breve periodo dell’ira americana, senza metterne minimamente in questione la legittimità e la direzione e senza preoccuparsi delle conseguenze di medio e lungo periodo della progressiva e accelerata distruzione dell’ordine politico occidentale.
Fanno penosamente testo le parole con cui Giorgia Meloni ha dichiarato di non condividere la scelta americana, ma di addebitarne la causa a un equivoco – «un problema di comprensione e di comunicazione» – circa le vere intenzioni dei Paesi Ue che avevano annunciato di volere rafforzare la propria presenza militare in Groenlandia. Non di opporsi all’annessione americana – non sia mai, garantisce Meloni – ma di collaborare con gli Stati Uniti alla difesa dell’Artico.
Nella geopolitica della malafede, Meloni ha dovuto, per l’ennesima volta, mostrare di credere a qualcosa che non esiste, cioè alle presunte preoccupazioni di sicurezza americane, per eludere l’unico problema che è sul tavolo e che è costituito dall’ordine di Trump che gli si consegni, senza tante storie, l’isola più grande del mondo.
C’è una ragione per cui la destra italiana deve continuare a fingere che Trump abbia molte ragioni per pretendere un’estensione della sovranità americana sulla Groenlandia e comunque non abbia tutti i torti nell’addebitare agli alleati europei la sottovalutazione dei rischi della penetrazione russa e cinese tra i ghiacci del Polo.
Non c’entra niente la realtà. La sovranità sull’isola non avrebbe alcun effetto sull’operatività militare americana, che già oggi non è subordinata ad alcun limite, se non a quelli derivanti dalla comune appartenenza di Stati Uniti e Danimarca all’Alleanza Atlantica. La chiusura di molte installazioni americane e la riduzione da molte migliaia ad alcune centinaia di unità dei contingenti presenti in Groenlandia dopo la fine della Guerra Fredda sono state decise dagli Usa in modo libero e sovrano e non sono state loro imposte da nessuno. Le stesse minacce militari russe e cinesi sono molto meno incombenti di come siano rappresentate (si veda, sul punto, l’analisi di Giorgio Orio Stirpe).
La ragione per cui nello schieramento governativo bisogna in ogni caso dare tutta o molta ragione a Trump e fingere di credere che le sue reazioni dipendano da qualche increscioso e risolvibile equivoco è che la destra italiana è in parte persuasa e in parte assuefatta all’idea che il trumpismo, con tutto quello che porta con sé, sia il nuovo reale e il nuovo razionale della Storia e l’inevitabile contrappasso della pretesa di imprigionare gli stati nazione nella gabbia delle regole multilaterali, che hanno guidato negli ultimi decenni tutti i processi di integrazione economica e politica, a partire da quello europea.
Per la destra italiana – tutta, senza eccezioni – Trump è il messia di cui aveva invocato la venuta o la Nemesi che attendeva si sarebbe abbattuta sulla hybris dell’Occidente. L’amore e il timore per il capo dei capi del mondo è una paranoia escatologica, proprio come la mafioseria di quella Sicilia, a cui il potere dei mammasantissima continua ad apparire giusto o comunque inappellabile destino e in cui l’unico auspicio legittimo è che la violenza sia benevola e non faccia troppe vittime.
L'articolo L’amore-timore della destra italiana per Trump è una mafioseria escatologica proviene da Linkiesta.it.
Guerre, tensioni commerciali e crisi climatica non li hanno sfiorati. Il 2025 è stato un anno di bonanza per i miliardari globali, che hanno superato per la prima volta quota 3mila e tra novembre 2024 e novembre 2025 hanno visto esplodere la propria ricchezza netta di 2.500 miliardi di dollari, a un totale di 18.300: fa +16,2%, un tasso tre volte superiore alla crescita media registrata tra 2020 e 2024. I primi 12 nella classifica delle fortune globali, da Elon Musk a Bernard Arnault passando per Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, possiedono oggi quanto la metà più povera dell’umanità. E l’aumento della concentrazione della ricchezza, scrive Oxfam nel suo annuale rapporto sulla disuguaglianza globale, non fa che alimentare un circolo vizioso ben noto: la “cattura” della politica da parte dei super ricchi. Il risultato? Regole che rafforzano i privilegi e allargano ulteriormente i divari, a esclusivo beneficio di una nuova élite oligarchica nelle cui mani si concentra il potere economico.
“Progressivo deterioramento dei principi democratici”, traduce il report Nel baratro della disuguaglianza – Come uscirne e prendersi cura della democrazia, pubblicato come sempre in occasione del forum di Davos che riunisce in Svizzera l’élite politica e finanziaria globale. Perché a ogni enorme patrimonio si associa una probabilità enormemente superiore di ottenere cariche politiche: un miliardario ha 4mila volte più probabilità di ricoprire un ruolo elettivo rispetto a un comune cittadino. Ma questo, insieme alle “porte girevoli” tra posizioni apicali nel settore privato e incarichi pubblici, non è che il canale di influenza più visibile. La politica si può anche comprare con lauti finanziamenti, lobbying e controllo dei media, fino a sovvertire il principio fondamentale del suffragio universale sostituendolo con il più prosaico “un dollaro, un voto”.

Il panorama dei media globali conferma plasticamente la tesi: sette delle maggiori corporation del settore hanno proprietari miliardari e una manciata di ultra-ricchi controlla testate storiche (vedi il Washington Post, acquistato da Bezos) e social network (X di Musk) centrali per il dibattito pubblico. Ogni giorno 11,8 miliardi di ore vengono trascorse sui social fondati o posseduti da miliardari, con quel che ne deriva per la loro capacità di influenzare ciò che le persone vedono e credono. L’ascesa dell’intelligenza artificiale generativa moltiplica i rischi, perché facilita la diffusione di notizie false e la manipolazione su larga scala. Per Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia, “siamo letteralmente di fronte alla legge del più ricco che sta portando al fallimento della democrazia”.
Sul fronte opposto, la riduzione della povertà globale si è fermata. Dopo decenni di lento miglioramento, i livelli sono oggi fermi ai valori pre-pandemia e in Africa quella estrema è di nuovo in aumento. Nel 2022, secondo i dati aggiornati della Banca Mondiale citati nel rapporto, 3,83 miliardi di persone (il 48% della popolazione mondiale) vivevano in condizioni di indigenza: 258 milioni in più rispetto alle stime precedenti. Non aiutano il taglio degli aiuti da parte dei paesi ricchi e le politiche di austerità ancora imposte dalle istituzioni internazionali o rese necessarie dall’esplosione del debito pubblico: secondo l’Onu, 3,4 miliardi di persone vivono in Stati che spendono più per il servizio del debito che per sanità e istruzione. Mentre la copertura sanitaria universale è in una fase di stallo.
L’inflazione ha fatto la sua parte: dopo il Covid la stagnazione dei salari, mentre i prezzi del cibo si impennavano, ha peggiorato l’insicurezza alimentare, che nel 2024 riguardava 2,3 miliardi di persone: 335 milioni in più rispetto al 2019. Inevitabile, dunque, che le disparità siano peggiorate o al massimo si siano cristallizzate: oggi l’1% più ricco possiede il 43,8% della ricchezza globale, mentre la metà più povera si ferma allo 0,52% e oltre il 77% della popolazione mondiale vive in Stati dove la distanza di ricchezza tra l’1% più ricco e il 50% più povero è rimasta invariata o è aumentata tra 2022 e 2023.
Le conseguenze sulle istituzioni che sulla carta potrebbero intervenire per favorire la redistribuzione sono evidenti. I Paesi ad alta disuguaglianza sono fino a sette volte più esposti al rischio di erosione democratica rispetto a quelli più egualitari. E uno studio su 136 Stati ha mostrato che l’aumento della disparità nella distribuzione delle risorse va a braccetto con quello del potere politico e tende a sfociare in una riduzione delle libertà civili dei più poveri. Questo può spiegare, argomenta il rapporto, perché non vengano adottate misure che sarebbero accolte con favore da gran parte della popolazione. Tra queste le imposte sui grandi patrimoni, la cui introduzione stando ai sondaggi ha ampio sostegno. Eppure oggi solo il 4% delle entrate fiscali globali proviene da tasse sulla ricchezza, mentre l’80% del gettito grava su lavoratori e consumatori: è l’esito di decenni durante i quali, ricorda il report, le élite economiche hanno sfruttato la propria influenza politica per bloccare riforme fiscali progressiste. L’ultimo caso è la campagna martellante di Bernard Arnault, uomo più ricco di Francia e patron del polo del lusso LVMH, contro la proposta di tassazione minima a carico dei molto abbienti teorizzata dall’economista Gabriel Zucman e fatta propria dal Partito socialista francese.
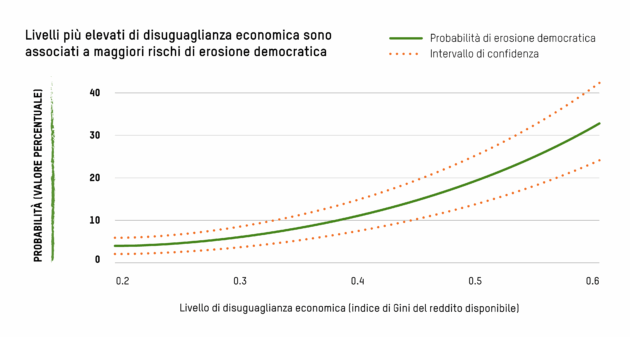 Ma “la libertà politica e l’estrema disuguaglianza non possono coesistere a lungo”, tira le somme il rapporto, evocando Joseph Stiglitz. La povertà politica – scarsa partecipazione e quindi possibilità di esercitare influenza – che tende ad andare di pari passo con quella economica sfocia in proteste sociali: oltre 142 quelle registrate negli ultimi dodici mesi. In prima linea, spesso, la Gen Z. La risposta della politica? “Le ricette che hanno fin qui generato disuguaglianze insostenibili necessitano sempre più spesso di strumenti coercitivi e autoritari per mantenere lo status quo”, spiega Mikhail Maslennikov policy advisor sulla giustizia economica di Oxfam. E “il conto che presentano” comprende non solo “l’erosione di istituzione democratiche e la compressione delle libertà” ma anche la criminalizzazione del dissenso e un’ipertrofia repressiva. Non bisogna cadere nell’inganno: le forze politiche populiste ed estremiste che guidano la deriva autoritaria fanno leva sul disagio delle persone e sulla perdita di opportunità e di riconoscimento in luoghi a lungo trascurati da classi dirigenti indifferenti. Ma le proposte di cambiamento che portano sono illusorie. Continuano a favorire gruppi sociali e territori già avvantaggiati”.
Ma “la libertà politica e l’estrema disuguaglianza non possono coesistere a lungo”, tira le somme il rapporto, evocando Joseph Stiglitz. La povertà politica – scarsa partecipazione e quindi possibilità di esercitare influenza – che tende ad andare di pari passo con quella economica sfocia in proteste sociali: oltre 142 quelle registrate negli ultimi dodici mesi. In prima linea, spesso, la Gen Z. La risposta della politica? “Le ricette che hanno fin qui generato disuguaglianze insostenibili necessitano sempre più spesso di strumenti coercitivi e autoritari per mantenere lo status quo”, spiega Mikhail Maslennikov policy advisor sulla giustizia economica di Oxfam. E “il conto che presentano” comprende non solo “l’erosione di istituzione democratiche e la compressione delle libertà” ma anche la criminalizzazione del dissenso e un’ipertrofia repressiva. Non bisogna cadere nell’inganno: le forze politiche populiste ed estremiste che guidano la deriva autoritaria fanno leva sul disagio delle persone e sulla perdita di opportunità e di riconoscimento in luoghi a lungo trascurati da classi dirigenti indifferenti. Ma le proposte di cambiamento che portano sono illusorie. Continuano a favorire gruppi sociali e territori già avvantaggiati”.
Gli Usa sono insieme motore e caso paradigmatico di queste dinamiche. Nell’anno del ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump i miliardari statunitensi hanno sperimentato la crescita di ricchezza più marcata al mondo (quella dei 10 più ricchi è aumentata di 698 miliardi di dollari). In parallelo il Congresso ha approvato misure che produrranno la più grande redistribuzione alla rovescia degli ultimi decenni, accompagnata da tagli alla protezione sociale e restrizioni dei diritti dei lavoratori. Milioni di persone hanno reagito scendendo in piazza sotto lo slogan “no kings” contestando le politiche autoritarie del presidente e le misure a favore degli ultra ricchi. Migliaia stanno protestando a Minneapolis contro le violenze dell’agenzia per il controllo dell’immigrazione. Le elezioni di midterm diranno se la voglia di cambiamento avrà la meglio sulle ricette populiste nel 2024 hanno convinto la maggior parte degli americani.
L'articolo 2025 da record per i miliardari. “Nuovi oligarchi che manipolano democrazia e regole dell’economia per avvantaggiare i propri interessi” proviene da Il Fatto Quotidiano.
di Rosamaria Fumarola
La damnatio memoriae era il progressivo processo di cancellazione di un imperatore, delle sue gesta, di tutti i segni tangibili che aveva lasciato e della creazione di una narrazione propagandistica dei fatti che riguardavano anche il potere subentrante. La damnatio memoriae neroniana ad esempio ci ha restituito un princeps folle ed egoista, che aveva ucciso sua madre Agrippina e sua moglie e che aveva distrutto Roma con un incendio, per acquisire i territori necessari alla costruzione della sfarzosa oltre ogni limite Domus Aurea.
Certo il matricidio ora come allora appare a chiunque un delitto che la morale e l’istinto avvertono come inaccettabile e Nerone è provato che di questo delitto si sia macchiato, ma è altrettanto provato che non fu il responsabile dell’incendio di Roma e che anzi offrì rifugio a migliaia di romani che cercavano riparo dalle fiamme.
La ricostruzione della città fu fatta poi rispettando una serie di misure che l’avrebbero resa da allora in poi meno vulnerabile agli incendi, seguendo appunto le direttive dello stesso Nerone. Le riforme da lui promosse non andavano incontro ai desiderata dell’aristocrazia senatoria, ma sembravano animate da una spiccata sensibilità verso i ceti inferiori e, last but not least, Nerone non amava le campagne militari e non fu attivo nel promuovere le conquiste di nuovi territori.
Si ritiene che queste ragioni abbiano portato alla necessità di sostituirlo con una figura diversa, che incontrasse gli interessi degli altri centri di potere della romanità. Nerone andava spazzato via da Roma e dalla sua storia. Tutte le volte in cui questo accade è dunque un esercizio non fuori luogo quello di domandarsi quali siano davvero le ragioni che sottostanno ad una narrazione tanto radicale.
Fare in modo che di qualcosa o qualcuno non si parli più è infatti anch’esso una sottrazione di potere ed è quanto di recente sta accadendo con il fenomeno Sumud Flotilla. Piaccia o meno la Flotilla ha catalizzato il dissenso mondiale riguardo il genocidio dei gazawi, dimostrando che la tolleranza del sopruso può trovare un limite anche nelle masse meno radicali. Il potere ha dovuto fare i conti con una reazione imprevedibile e perciò pericolosa e ha fatto un passo indietro.
Si obietterà che la farsa della pace voluta da Trump ha solo spento i riflettori su un massacro che continua lontano dal clamore dei media. Le parole del presidente americano alla Knesset in sostegno di Netanyahu e il racconto di come gli avesse procurato tutte le armi più avanzate per sterminare i palestinesi nemmeno si sforzavano infatti di fingere equilibrio tra le parti in causa.
Ciò che ha portato ad evitare un’ulteriore escalation nella carneficina a Gaza è stato il movimento che ha visto nella Sumud Flotilla la possibilità di una differenza, del recupero di un interesse verso le sorti di chi non può che subire, disumanizzato e ridotto a cosa nel rispetto pedissequo di un protocollo di sterminio nazista.
Un attimo dopo l’avvio delle trattative di pace a Gaza della Flotilla però non si è più parlato: non doveva raccontarsi la storia di poche centinaia di uomini e donne che hanno osato sfidare il potere nella sua più cinica e abietta bestialità. Non doveva diffondersi l’idea che dire no è sempre possibile e che in questi tempi svuotati di ciò che in un essere umano vale davvero, la differenza non la fanno i social o gli influencer, tutti genuflessi al monocorde mercato che insegue se stesso.
La propaganda che vuole spegnere il pericoloso fuoco acceso dalla Flotilla, in questi giorni, dileggia i suoi sostenitori e provocatoriamente li invita a protestare per quanto accade in Iran. È un modo per screditare tutti coloro che hanno agito in risposta ad un moto interiore impossibile da trattenere, per lasciar credere che si sia trattato solo di un’armata Brancaleone destinata all’oblio e forse al ridicolo. La Flotilla sarà invece ricordata come la sola stella luminosa che ha voluto brillare in questi anni neri.
L'articolo Nonostante la cancellazione mediatica, la Flotilla sarà ricordata come la sola stella che ha brillato in questi anni neri proviene da Il Fatto Quotidiano.
Quando i cittadini di un paese sono costretti a scegliere fra curarsi o mangiare, significa che il sistema paese ha fallito e a questo punto ci sono solo due soluzioni:
1 – Chi lo governa questo paese deve creare un piano strutturale per aiutare le persone in difficoltà.
2 – Se chi ci governa non è in grado, o non vuole per scelte politiche o personali di cambiare l’importanza delle priorità di questo paese deve riconoscere il proprio fallimento e lasciare spazio ad altri.
Come ho già detto più volte nei miei articoli, far politica significa mettersi al servizio dei cittadini: non è certo facendo pagare gli ausili alle famiglie delle persone disabili o dando 400 € al mese alle persone che assistono un proprio caro che si supporta e si tutela chi è in difficoltà, o mi sbaglio? Non è assolutamente vero che non ci sono i soldi e che non si poteva fare di più, perché se l’interesse a investire in un determinato settore, porta dei vantaggi politici ed economici le coperture economiche si trovano.
Da molti anni mi occupo di tematiche sociali e sinceramente non ho mai capito perché il settore del welfare è uno degli ambiti più penalizzati a livello di copertura economica. Investire nel sociale può avere due vantaggi:
– Il popolo vive meglio E se sta meglio, produce di più;
– Se chi governa fa realmente star bene il popolo ne guadagna a livello di voti e di consensi.
Anni fa mi confrontavo molto spesso con gli uffici che collaborano con il ministero dell’Economia e Finanza perché ritenevo che 256 € al mese di invalidità civile fossero una cosa scandalosa. Quando il Comitato 16 novembre organizzava proteste sotto il ministero dell’Economia e Finanza, da Bassano del Grappa via telefono, tenevo i rapporti con i manifestanti che erano fuori al freddo e intubati e contemporaneamente dialogavo con gli uffici del ministero affinché i rappresentanti del Comitato fossero ricevuti e soprattutto ascoltati. Grazie anche alla sensibilità dei funzionari del Ministero che ci hanno aiutato a far sentire la nostra voce, siamo riusciti ad avere qualche piccolo aumento nella pensione di invalidità, il ministro dell’epoca se non sbaglio era Giulio Tremonti.
Speravo il governo Meloni riuscisse a dare una svolta epocale a questo paese, come effettivamente aveva annunciato, ma purtroppo non è così, anzi, mi sembra stia facendo come li icneumone che paralizza la propria preda senza ucciderla, ha lasciato il popolo con misure rivolte al sostegno per chi è in difficoltà ridotte al minimo.
Io continuerò sempre a dare voce al popolo e ai bisogni reali del paese, vi invito a non arrendervi mai.
Per segnalarmi le vostre storie scrivete a: raccontalatuastoria@lucafaccio.it e redazioneweb@ilfattoquotidiano.it
L'articolo Speravo che Meloni si mettesse al servizio dei cittadini: non è così per i disabili proviene da Il Fatto Quotidiano.
Dal 2024 è in corso in Kuwait una campagna di revoca della cittadinanza di dimensioni mai viste nella storia del paese. In un anno e mezzo, secondo l’organizzazione Women Journalist Without Chains (Giornaliste senza catene), oltre 50.000 persone sono state arbitrariamente private della cittadinanza: si tratta di oltre il tre per cento della popolazione totale.
Questa campagna va inserita nel contesto di una serie di sviluppi politici che hanno interessato la monarchia del Golfo, tra i quali il 10 maggio 2024 lo smantellamento dell’Assemblea nazionale e, di fatto, la sospensione della Costituzione.
Tali misure hanno consentito al governo di emendare la Legge sulla cittadinanza senza un dibattito parlamentare e all’oscuro dell’opinione pubblica. Sono stati ampliati i poteri del ministero dell’Interno e del Comitato supremo per la cittadinanza.
La privazione della cittadinanza, sui cui motivi storici abbiamo già scritto in questo blog, ha riguardato interi gruppi e famiglie, andando a penalizzare figli e nipoti ma anche, in maniera retroattiva, generazioni precedenti. Di questa sorta di “morte civile” stanno pagando il prezzo anche persone dissidenti e attiviste.
Le conseguenze? Perdita dei documenti, licenziamenti, congelamento dei conti bancari ed esclusione dai servizi pubblici fondamentali come ad esempio le cure mediche, isolamento sociale.
A essere colpite, a seguito dell’abolizione dell’articolo 8 della Legge sulla cittadinanza, sono state soprattutto le donne che avevano acquisito la cittadinanza kuwaitiana tramite matrimonio e, naturalmente, i loro figli, con conseguenze gravi per l’accesso all’istruzione: non si contano le espulsioni dalle scuole pubbliche.
Nel 2025 è stato istituito un comitato per i reclami ma si tratta di un organismo meramente amministrativo privo di indipendenza. L’accesso ai rimedi giudiziari è dunque praticamente nullo.
L'articolo In Kuwait è in corso una campagna di revoca della cittadinanza: una ‘morte civile’ proviene da Il Fatto Quotidiano.
A Caracas e a Mosca hanno scoperto che la libertà, oggi, ha la forma di un gettone digitale. Si chiama Tether, vale un dollaro, e serve a fingere che il dollaro non serva più. Una beffa da episodio di Black Mirror: per sfuggire all’impero americano, basta usare la sua moneta travestita da criptovaluta. In Venezuela l’idea è partita da Nicolás Maduro, ora in una cella di Brooklyn. La sua economia, affondata come il bolívar, galleggia grazie a Tether, usato per vendere petrolio e aggirare le sanzioni. La compagnia statale PDVSA incassa token invece di dollari e li rigira in valute “amiche”. Il risultato? Caracas sopravvive, e Washington, gabbato lo santo con il rapimento stile Hollywood del leader, tollera i chavisti ancora al potere.
In Russia la musica è la stessa, solo più sinfonica. Vladimir Putin, con un patrimonio occulto che secondo Bill Browder tocca i 200 miliardi di dollari, ha copiato la lezione venezuelana: criptovalute per respirare sotto la cappa delle sanzioni USA-UE (siamo al 19° “pacchetto”). Nel 2024 ha persino legalizzato l’uso di asset digitali per i pagamenti esteri delle sue grandi aziende. Così le società di Stato russe possono commerciare petrolio e microchip con Cina, India, Turchia o Emirati, usando un token che riproduce il valore del dollaro, per poi cambiarlo in yuan, rupie, dirham.
Al centro di questa rete parallela del denaro, c’è un italiano: Giancarlo Devasini, ex chirurgo plastico torinese, oggi terzo uomo più ricco d’Italia e padrone del 47% di Tether. Un genio, sinceramente. Ha offerto oltre un miliardo per comprare la Juventus, ma il suo vero stadio è il mercato globale delle criptovalute, ne ha una fetta più che maggioritaria. Con il socio Paolo Ardoino, CEO e miliardario anche lui (n. 5 secondo Forbes), guida questa sorta di “banca centrale ombra” che vale 186 miliardi di dollari.
Le autorità americane fingono di non vedere. Ogni tanto una multa: 18,5 milioni nel 2021 dopo l’inchiesta della procuratrice di New York Letitia James (riserve “garantite” e invece prestiti e incastri con Bitfinex: odore di frodi bancarie e dichiarazioni false), poi altri 41 milioni dalla Cftc per versioni creative delle riserve. Fine della tragedia, inizio dell’oblio. Da allora Tether collabora persino con l’Ofac, cioè l’ufficio del Tesoro Usa che gestisce le sanzioni e decide chi è “legittimo”, congelando i wallet “sospetti”.
Secondo l’Onu, la blockchain è la moneta preferita per traffici e riciclaggio nel Sud-est asiatico. Ma finché serve a tenere in piedi Caracas e Mosca, nessuno a Washington sembra particolarmente turbato. Men che meno Donald Trump, che fa sequestrare Maduro da Marina, Aviazione e Delta Force con la balla del narcotraffico ma puntando al greggio, mentre guadagna milioni con la piattaforma cripto di famiglia, World Liberty Financial. Se volesse davvero fermare il flusso di Tether e bloccare il suo amico-nemico Putin, dovrebbe bombardare il suo stesso portafoglio.
E così, tra i sermoni sulla libertà e gli affari di famiglia, l’America lascia correre, ma il suo declino accelera. La Russia compra pezzi di tecnologia militare, il Venezuela paga i suoi debiti in token, e Devasini diventa sempre più ricco. Tutti fingono di odiare il dollaro, ma in realtà lo venerano in formato digitale. La guerra, quella vera, si combatte a colpi di bit. Politica e geopolitica, ai tempi di Trump, sono propaganda, per i gonzi che guardano la tv. Il capitalismo dell’ipocrisia.
L'articolo Tether, la cripto-arma segreta di Putin e Venezuela per aggirare le sanzioni Usa proviene da Il Fatto Quotidiano.
© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews
© RaiNews



© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews
Uno dei miei primi ricordi politici è legato all’Iran. Mia madre e mio padre, all’epoca militanti di sinistra, avevano appoggiato con forza la rivolta iraniana contro il regime dello Scià, che all’... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti




© RaiNews


© RaiNews
Nel campionato di serie A di basket c’è una squadra che ha giocato le sue ultime due partite in meno di cinque minuti ciascuna, finendo con un solo giocatore in campo, ed è stata eliminata dalla co... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti



Una formazione specializzata e di alto livello è una dote preziosa per il mercato del lavoro. Vale soprattutto in una fase storica in cui i numeri sull’occupazione non sono del tutto incoraggianti, e ancora di più per le persone che hanno trascorso una parte della propria vita in carcere. Un passaggio non semplice da superare, che lascia tracce oltre che sulla fedina penale anche e soprattutto sulla capacità e possibilità, una volta concluso il periodo di detenzione, di recuperare una quotidianità fatta di casa, lavoro, socialità.
Si parla spesso, ma evidentemente non abbastanza, di come le condizioni di detenzione nelle carceri del nostro Paese siano degradanti. Il tasso di affollamento è del 122 per cento secondo l’ultimo dato del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), 138,5 per cento a fine novembre 2025 secondo l’Associazione Antigone, mentre la media europea a fine 2024 era del 94,9 per cento. E secondo i dati del Cnel sei condannati su dieci sono già stati in carcere almeno una volta, ma sempre il Cnel stima che il tasso di recidiva possa calare fino al due per cento per i detenuti che hanno avuto la possibilità di una collocazione professionale.
Dunque lavoro e formazione sono un potente strumento di reinserimento sociale e rendono la detenzione ciò che deve essere secondo l’articolo 27 della nostra Costituzione: un periodo di limitazione della libertà personale che non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che deve tendere alla rieducazione del condannato.
Di nuovo però i numeri diffusi dal Cnel non sono incoraggianti: 7,2 per cento è la quota (comunque in crescita) di detenuti che nel 2024 ha preso parte a forme di formazione professionale (con “cucina e ristorazione” in testa tra le tipologie di corsi frequentati, 24,3 per cento degli iscritti sul totale) e solo il 34,3 per cento dei detenuti è stato impegnato in attività lavorative.
Per questo meritano attenzione e sostegno tutti quei progetti, voluti sia dagli istituiti penitenziari che da associazioni e fondazioni esterne, che si occupano di realizzare possibilità concrete di studio, preparazione e pratica che un domani possano tradursi in un lavoro. Ne abbiamo descritti molti, su queste pagine (InGalera a Bollate, Idee in fuga e Pausa Café ad Alessandria, la Brigata del Pratello nel carcere minorile di Bologna, Giotto a Padova, 300Mila a Lecce), ovviamente tutti focalizzati sul mondo della ristorazione e della gastronomia, ma anche il settore enologico presenta opportunità e iniziative interessanti ed efficaci.
Gorgona, come vi abbiamo raccontato in questo approfondimento, ospita ad esempio una colonia penale ma anche le vigne di Frescobaldi, che accolgono i detenuti e si lasciano curare e vendemmiare per produrre vini e possibilità lavorative che matureranno una volta lasciata l’isola toscana.
Sempre in Toscana, ma ancora più professionalizzante, è il nuovo progetto “Vite Libera” realizzato dall’Associazione Italiana Sommelier (Ais) Toscana con il supporto di Ais Italia e dalla casa circondariale “Santo Spirito” di Siena, diretta da Graziano Pujia. Per la prima volta, sei detenuti potranno seguire il corso d’alta formazione da sommelier, fino al conseguimento del titolo professionale. Venticinque lezioni intensive, la prima prevista lunedì 19 gennaio, copriranno tutti e tre i livelli della didattica Ais; i partecipanti studieranno materie come viticoltura, enologia e tecniche di servizio, con il supporto di dispense e materiale audiovisivo così come di esercitazioni pratiche, come avviene per i frequentanti esterni, e il 24 giugno sosterranno la prova finale, scritta e orale, il cui superamento garantirà il rilascio del diploma di sommelier Ais.
In occasione della presentazione ufficiale del progetto, tenuta il 13 gennaio al Palazzo Berlinghieri di Siena, il delegato Ais Siena Marcello Vagini, che ne è stato ideatore assieme al direttore di Santo Spirito Graziano Pujia, ha espresso grande soddisfazione: «Andremo a offrire un vero percorso educativo; oltre l’aspetto tecnico, subentrano valori come la dignità e la voglia di riscatto che arricchiranno tutta la nostra associazione». Il presidente nazionale Ais Sandro Camilli ha a sua volta posto l’accento sulla capacità del percorso di stimolare anche il senso di responsabilità delle persone coinvolte e l’attenzione al rispetto e al lavoro di squadra: «Vogliamo rendere il mondo del vino sempre più inclusivo e volto al sociale e questo progetto sarà uno strumento di crescita personale e di consapevolezza», mentre il presidente di Ais Toscana Cristiano Cini ha evidenziato l’orgoglio di essere la prima regione a organizzare un progetto di questo tipo: «Offrire a un detenuto la possibilità di diventare sommelier non è solo un atto formativo: è un atto di fiducia nella possibilità di rinascita, nel potere educativo del sapere, e nel valore sociale del vino come cultura e mestiere».
Cini ha infine dichiarato la disponibilità di Ais a collaborare con enoteche regionali, consorzi di tutela, fondazioni e sponsor del settore vitivinicolo, enti pubblici e con il ministero della Giustizia per eventuali estensioni di “Vite Libera”, «certi che questo progetto per i detenuti racchiude in sé la speranza di un futuro migliore».
L'articolo Nella casa circondariale di Siena si può diventare sommelier proviene da Linkiesta.it.


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews
Grave incidente ferroviario lungo la linea dell’alta velocità che collega Madrid e la regione meridionale dell’Andalusia, in Spagna. Due treni si sono scontrati nei pressi della stazione di Adamuz, vicino Cordoba, provocando 39 morti e 112 feriti, di cui 24 gravi e cinque minorenni.
Secondo una prima ricostruzione fornita da Adif, le infrastrutture ferroviarie spagnole, l’incidente si è verificato alle 19:39, quando un treno della compagnia Iryo in servizio tra Malaga e Madrid Puerta de Atocha, con 317 persone a bordo, è deragliato nei deviatoi di ingresso alla via 1 della stazione di Adamuz. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da ilfattoquotidiano.it, tutto è successo in corrispondenza di uno scambio che potrebbe non aver funzionato correttamente. Al momento, fanno sapere, è solo un’ipotesi. L’ottavo vagone del treno Iryo è uscito dai binari e avrebbe fatto deragliare anche il sesto e il settimo. Proprio in quel momento passava un treno dell’alta velocità della statale Alvia (Renfe) nell’altra direzione – proveniente da Madrid e diretto a Huelva – che ha travolto il convoglio Etr 1000 di fabbricazione italiana (era entrato in servizio appena due anni fa) e gestito dalla società Iryo. Iryo è il marchio dei treni operati da Ilsa, consorzio composto da Ferrovie dello Stato International (51%), Air Nostrum e Globalvia. Come scrive El Pais, l’operatore Iryo è il secondo per quota di mercato in Spagna e dispone di 20 treni di ultima generazione ETR-1000 prodotti da Hitachi.
La circolazione ferroviaria fra Madrid e la regione Andalusia è stata immediatamente sospesa, con pesanti disagi per migliaia di utenti per il rientro domenicale, mentre le autorità della regione, che hanno attivato il livello 1 di emergenza di Protezione Civile, parlano di un bilancio “molto grave” e ancora provvisorio. “L’impatto è stato terribile provocando quindi il deragliamento dei due primi vagoni del treno (Alvia) di Renfe”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, in un messaggio su X. “Il numero di vittime non può essere confermato in questo momento”, ha detto.
Intorno alle 23 del 18 gennaio, il responsabile dei vigili del fuoco di Adamuz ha detto all’emittente pubblica Tve: “Stiamo dando priorità alle persone vive, lavoriamo nei vagoni cercando superstiti sotto un ammasso di poltrone, lamiere e bagagli”. A raccontare le scene di panico e caos numerosi testimoni, tra cui il giornalista di Radio Nacional de Espana (Rne), Salvador Jimenez, che viaggiava sul treno partito da Malaga e ha testimoniato in diretta l’accaduto. “Siamo partiti da Malaga alle 18:40 in orario. Alle 19:45 c’è stato un impatto, è sembrato un terremoto che ha scosso tutti i vagoni. Io ero nel primo”, ha raccontato Jimenez. Il personale ha utilizzato martelli di emergenza per rompere i finestrini, per cercare di far evacuare i passeggeri.
L'articolo Spagna, incidente tra due treni in Andalusia: 39 morti. A deragliare il convoglio Iryo, operatore partecipato dall’italiana Fs proviene da Il Fatto Quotidiano.


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews
In un’epoca in cui la retorica dell’archivio inizia risultare stantia e tutto sembra pericolosamente già detto, il weekend della Milano Fashion Week maschile ha agito da sismografo. Tra un calendario rarefatto e una marea di presentazioni, la distanza tra l’identità reale e la mera sovrastruttura comunicativa non è mai stata così netta. La sfida oggi non è più inventare l’inedito, ma capire come rendere rilevante il “già visto” senza scadere nel nostalgico. Se Zegna ha affrontato il dilemma attingendo all’armadio del fondatore Ermenegildo, lavorando su un sapore retrò sapientemente attualizzato, è Prada a consegnarci, come sempre, la griglia di lettura definitiva del nostro tempo. Miuccia Prada e Raf Simons sono andati dritti al punto, manipolando i capispalla iconici del brand per dimostrare che ciò che conosciamo può essere rassicurante e desiderabile proprio perché “scomodamente” trasformato.
Dall’altra parte della barricata, c’è chi ha cercato di infiocchettare il vuoto con narrazioni scricchiolanti: è il caso di Dolce & Gabbana, dove il manifesto contro gli stereotipi è affogato in una passerella che di quegli stessi stereotipi ha fatto un catalogo, per giunta poco inclusivo. Anche Lessico Familiare ha tentato di alzare la voce, finendo però per rifugiarsi in un “famolo strano” che rischia di confondere la ricerca stilistica con l’eccesso fine a se stesso. È sul crinale anche Dsquared2, che come sempre ha puntato tutto sugli effetti scenici che fanno dire wow e rendono virali sui social, facendo per un attimo dimenticare lo stato di crisi in cui versa il brand. Ecco allora che, mentre attendiamo con il fiato sospeso la prima vera sfilata di Giorgio Armani senza re Giorgio, abbiamo provato a stilare il bilancio dei top & flop di questo fashion week(end), tra chi abita la moda e chi prova solo a impacchettarla.
La domanda che attraversa l’uomo Prada per l’autunno/inverno 2026 è essenziale: è ancora possibile costruire qualcosa di nuovo partendo da ciò che esiste già? La risposta di Miuccia Prada e Raf Simons non è nostalgica né provocatoria, ma profondamente razionale. La sfilata al Deposito della Fondazione Prada, trasformato in un cantiere di un palazzo storico svuotato e in attesa di ricostruzione, rende fisica l’idea di un presente in cui nulla può essere cancellato, ma tutto deve essere rielaborato. Miuccia Prada lo dice chiaramente: questo è un tempo “scomodo”, in cui l’incertezza impone chiarezza, precisione, rispetto per il passato senza rinunciare al cambiamento. Gli abiti traducono questo pensiero: trench e cappotti sottili, camicie abbottonate sul dorso, polsini allungati e doppi, giacche strette, pantaloni asciutti, cappelli compressi e quasi inglobati nei capispalla. Tutto è riconoscibile, ma nulla produce déjà-vu. Raf Simons insiste sul valore del metodo Prada: non distruggere i paradigmi, ma ribaltarli dall’interno. È così che elementi storici del marchio tornano “nuovi” proprio perché inseriti in un sistema coerente, che rifiuta l’effetto sorpresa fine a sé stesso. È la metafora perfetta di una cultura che preserva per modificare, che rincorre la sicurezza nel passato per non affogare in un futuro imprevedibile. Cosa dice del mercato? Che oggi il lusso non deve stupire, ma orientare. Che la riconoscibilità è un valore solo se accompagnata da pensiero. E che il cliente cerca solidità culturale prima ancora che novità estetica.

Se Prada rappresenta il pensiero, Montecore rappresenta l’applicazione concreta di quel pensiero al prodotto e al mercato. Fabio Peroni lavora con un metodo quasi ingegneristico: pochi modelli di base, sartoriali e codificati, pensati per tipologie precise di uomo professionista. Non è un caso che Montecore sia scelto da figure istituzionali come Sergio Mattarella o Antonio Conte. La collezione si costruisce per categorie chiare: capospalla imbottiti, piumini, outerwear tecnici, cappotti lunghi, modelli a camicia o bomber. Su questa struttura stabile, stagione dopo stagione, Peroni lavora su tessuti, filati, linee, comfort ed efficacia. Il risultato è un prodotto che evolve senza tradire il cliente, mantenendo un equilibrio rigoroso tra qualità e prezzo: il capo più costoso resta sotto i 2.000 euro. Ma il vero punto distintivo è il rapporto con il consumatore: Montecore offre una sorta di garanzia a vita, con servizi di riparazione e rimessa in forma dei capi. Un modello che restituisce senso alla parola “durata” e che trasforma l’acquisto in una relazione continuativa. La lezione? Che oggi il valore sta nel servizio, nella fiducia e nella coerenza. Che il cliente non vuole essere sorpreso, ma rispettato. E che il lusso contemporaneo passa anche da modelli industriali intelligenti, non solo da narrazioni aspirazionali.

Marco De Vincenzo gioca d’azzardo con gli “Animuomini“. Poteva essere un flop bizzarro, i suoi “animali fantastici” 2.0 sono un trionfo di “Etrosità”. Lo stilista lavora su un’operazione più sottile: riattivare il senso del vestire oggi attraverso la memoria visiva del brand. La collezione uomo riprende consapevolmente una campagna Etro del 1997 e una collezione storica di Kean, riportando in passerella le iconiche teste animalesche di allora. Il risultato non è citazionismo, ma un esercizio di traduzione temporale. De Vincenzo costruisce una collezione che sembra dialogare con l’attuale ossessione per il “ripostare” immagini del 2016, ma lo fa andando ancora più indietro, al 1996-1997. Paisley su velluto, jacquard animalier, vestaglie, pigiami, piume, maglie compatte e palette dense danno vita a un guardaroba che non è travestimento, ma linguaggio. Insomma, l’archivio funziona solo se diventa strumento critico.

A movimentare la presentazione (pur solida, centrata sul Winter Gommino e sul progetto Pashmy) dell’A/I 2027 di Tod’s ci si è messo Report, che proprio nel pomeriggio di domenica ha diffuso le anticipazioni del servizio in onda la sera sull’inchiesta riguardante il marchio, finito sotto indagine dalla Procura di Milano, con tre suoi manager, in relazione ad ipotesi di caporalato nella catena di subappalti della produzione. E così Diego Della Valle sposta il discorso sul punto che pesa su tutta la filiera: “Per prima cosa bisogna tutelare i lavoratori”, dice, e insiste: “Se vogliamo risolvere queste cose dobbiamo parlarne… il piccolo artigiano non può controllare 5 punti di filiera… bisogna sedersi… fare in un mese una legge che tuteli tutti”. E ancora: “Non possiamo far raccontare in giro per il mondo che siamo persone che non hanno a cuore il lavoro degli altri, perché non è vero”.

Il problema non è la sartorialità – che qui resta un terreno dominato con sicurezza – ma il dispositivo narrativo. La collezione “The Portrait of a Man” dichiara “archetipi lontani da qualsiasi stereotipo”, ma l’impianto è esattamente l’opposto: tutte le figure messa in passerella (lo sportivo, l’uomo di casa in pigiama, il dandy da smoking, ecc.) funzionano come stereotipo per definizione, perché procedono per etichette immediate. Ogni uscita, insomma, finisce per essere la rappresentazione didascalica e cristallizzata dello stereotipo stesso. A questo si aggiunge il dato polemico circolato sui social: la passerella composta da modelli tutti bianchi, caucasici, bellissimi neanche fossero stati creati dall’intelligenza artificiale, elemento che – in un progetto che pretende di parlare di “individualità” – diventa un limite visibile, non un dettaglio. La sfilata pretende di essere un manifesto: ma quando il manifesto è più insistito dei vestiti, qualcosa si sbilancia.
Il progetto Re-Loved / New Love è uno dei pochi esempi in cui la sostenibilità esce dalla formula e diventa metodo: upcycling creativo di capi d’archivio e materiali in esubero, senza produzione extra; capi rimodellati sui codici della main collection (palette e accostamenti), maniche e bordature dei piumini sostituite con inserti in maglia, maglie che nascono dall’unione di due modelli, righe pop con ricami artigianali. È interessante perché non “romanticizza” lo scarto: lo tratta come materiale progettuale.

Qui il rischio è l’eccesso di “bolla” concettuale. Il brand lavora sul recupero e sulla trasformazione del già esistente – un metodo nato nel lockdown e diventato identitario – ma la collezione “New Age” accumula segni e personaggi fino a rendere meno chiara la destinazione. Gonne a sbuffo, tulle addensato, strascichi, sottovesti, paillettes, high/low dichiarato, ready-made e spostamenti (colletti che diventano t-shirt, calzini che diventano abiti), corone e diademi, tacchi e babbucce, Madonna come colonna sonora: l’idea c’è, la mano pure, ma la lettura si disperde. Il progetto resta interessante sul piano concettuale, ma alla lunga il gioco di accumulo e citazione rischia di diventare autoreferenziale. L’upcycling funziona quando genera nuove funzioni, meno quando si trasforma in linguaggio chiuso. Peccato…

Per Kiton “Verità del fare” non è uno slogan, è un posizionamento che diventa leggibile nella struttura della collezione per capitoli (diverse occasioni d’uso, guardaroba contemporaneo), nella ricerca tessile sviluppata dal lanificio di Biella e nel lavoro sui volumi per una vestibilità confortevole ma proporzionata. Il punto forte è il rifiuto della monocromia rigida: accenti misurati, abbinamenti sofisticati, più carattere senza perdere misura. In un mercato nervoso, è una scelta di solidità. Il “Grand Tour” di Brioni funziona perché non diventa cartolina: qui resta un’idea di guardaroba H24 naturalmente morbido, con palette che richiama tramonto e pietra romana e grigi dal fumo ai riflessi metallici. Interessante il dialogo formale/informale: completo da ufficio con giacca militare e cravatta in maglia; Principe di Galles che alza il casual; denim che entra nel sartoriale senza forzature. La capsule montagna e l’abito da sera (micro-paillettes effetto mélange) chiudono un racconto coerente: non cerca di stupire, cerca di durare.
Top per ricerca vera: la Prototype Research_Series 09 introduce la maglieria con laminazione ad aria, con membrana HDry® accoppiata in 3D su un manichino gonfiabile ad aria calda. Il risultato tecnico (increspature, trama visibile, zip tagliate a mano dopo la membrana) è esattamente il tipo di innovazione che ha senso nel menswear. Nota a margine: il prezzo comunicato (1.000 euro) rende il progetto desiderabile ma sovraprezzato. Dietro c’è il tentativo di riposizionamento del brand sul mercato, ma il pubblico di riferimento resta quello dei giovani o giovanissimi a cui così non risulta proprio accessibile.

È un esempio di lusso “sensibile” che non cade nel vago: la collezione nasce dal ricordo di Parigi e lo dichiara con una frase concreta (“Parigi mi ha insegnato che il viaggio non finisce quando torni a casa”), poi lavora su palette (grigio nebbia, verde, celeste, nocciola, introduzione del nero) e materia (pellami di cervo accoppiati a cashmere, shearling, suede impalpabile, lane effetto denim). Il punto sta nella costruzione: volumi fluidi/strutturati, asimmetrie, sovrapposizioni calibrate, dettagli (bottoni in corno non tinto, zip bagno palladio). Non è solo atmosfera: è prodotto.
L'articolo Milano Fashion Week, i top e i flop della moda uomo: Prada resta la bussola, Dolce & Gabbana cade sugli stereotipi, il “famolo strano” dei giovani designer proviene da Il Fatto Quotidiano.
Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, ha scritto una lettera a Valentino Rossi. Come riportato da Il Resto del Carlino lo scorso 16 gennaio, l’ex pilota della MotoGp ha denunciato la compagna del papà Graziano per circonvenzione di incapace, accusandola di aver prelevato dal conto del padre circa 200mila euro in 12 mesi di relazione. Evelina ha paragonato la sua situazione a quella del pilota. La 25enne ha scritto: “La situazione di Valentino Rossi è molto simile alla mia, in entrambi i casi c’è un genitore fortemente indebolito (anche se credo che suo padre non sia mai arrivato a pesare 50 kg, e ad essere ricoverato denutrito e in stato confusionale come accaduto a Vittorio Sgarbi) che guarda caso viene isolato per volontà della compagna dal resto della famiglia e dalle sue amicizie storiche”.
Evelina ha aggiunto: “Sarà interessante vedere se, essendo Valentino Rossi campione di fama internazionale, i commentatori e gli improvvisati postini che hanno provato a crocifiggere me, faranno lo stesso con lui. O se invece, spaventati dal peso del suo nome, faranno inversione a U”. La donna ha proseguito la lettera facendo riferimento alla sua infanzia: “Il grande campione, da piccolo un padre sempre presente che lo ha anche indirizzato con successo nella carriera ce lo ha avuto e la sottoscritta no”. La 25enne ha specificato: “Ma in entrambi i casi ci sono indizi simili e ricorrenti che per chi indaga potrebbero facilmente costituire una prova della circonvenzione di incapace”.
Evelina Sgarbi si sta impegnando per salvare il padre. La ragazza ha scritto: “Da figlia che sta cercando in tutti i modi di salvare il proprio padre da chi pensa di mal gestirlo e abbandonarlo alla sua sorte, posso tranquillamente dire che comprendo perfettamente cosa Valentino Rossi stia vivendo, il suo stato d’animo, l’ansia e il pensiero di doversi pentire un giorno di non aver provato tutto ma proprio tutto per cercare di difendere gli interessi del padre da chi lui teme se ne sia già approfittato e vorrebbe approfittarsene ancora”.
La figlia di Vittorio ha augurato a Valentino Rossi ogni bene. La ragazza ha dichiarato: “Auguro ogni bene e soprattutto di non dover patire quello che ho subito io per cercare di conoscere la verità sulla salute di mio padre”. In conclusione, Evelina ha scritto: “Ps: per la cronaca. Ancora non si è vista una cartella clinica. Ma di che cosa hanno veramente paura i cattivi consiglieri di Vittorio Sgarbi?”.
L'articolo “Abbiamo entrambi un padre indebolito e isolato per la volontà della compagna, voglio vedere se crocifiggeranno anche te”: Evelina Sgarbi scrive una lettera a Valentino Rossi proviene da Il Fatto Quotidiano.


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews
Un uomo è stato investito da un treno nella stazione di Firenze Campo di Marte dopo le 19 al binario 3. Secondo quanto appreso, si tratta di un gesto autonomo, di un tentato suicidio. Sul posto è intervenuta la Polfer per gli accertamenti di polizia giudiziaria. L’incidente ha provocato ritardi per molti convogli nel nodo di Firenze, in particolare sulla linea Firenze-Roma e sulle lunghe percorrenze Roma-Milano.
“La circolazione permane fortemente rallentata per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento non mortale di una persona a Firenze Campo Marte”, si legge sul di Trenitalia. Il treno coinvolto è un Frecciarossa partito da Napoli e diretto a Gorizia. “I treni Alta Velocità e Intercity, alcuni dei quali instradati sulla linea convenzionale, e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti“, scrive ancora Trenitalia.
L'articolo Uomo investito da treno alla stazione di Firenze Campo di Marte: circolazione rallentata, ritardi di 60 minuti proviene da Il Fatto Quotidiano.


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews
Finora gennaio è stata la terza punta di un triangolo che vede la moda maschile e l’Italia come gli altri due vertici: tra la 109esima edizione di Pitti Uomo e la Milano Fashion Week, la nostra Penisola ha svolto il ruolo di palcoscenico per la moda maschile mondiale cercando di aprire e mantenere i ponti con l’estero e sostenere il mercato italiano. Nelle giornate tra fiera, sfilate ed eventi divisi tra Firenze e Milano assieme al menswear è da notare anche tutto il settore degli accessori e della pelletteria, proprio quest’ultimo l’unico segmento italiano in crescita con un +5,6% nel 2024 rispetto all’anno precedente. Tra scarpe, sciarpe e accessori da viaggio, vediamo quali sono stati i brand che hanno partecipato alle kermesse di moda maschile, tra storici nomi italiani e proposte provenienti da tutto il mondo.
Partiamo da uno dei prodotti di punta della pelletteria in generale, quello delle calzature, accessorio su cui è importante l’innovazione tecnica tanto quanto il mantenimento di strutture e forme tradizionali. Fratelli Rossetti, marchio meneghino fondato negli anni Sessanta, ricerca proprio il connubio tra silhouette classiche e sperimentazione costruttiva con la loro autunno-inverno 26/27 presentata nella cornice di casa della Milano Fashion Week: il brand accende i riflettori principalmente sul loro tradizionale mocassino Brera, che vede la rivisitazione grazie a macro cuciture a contrasto su tutta la tomaia, restituendo un pattern geometrico simil trapuntato. Anche l’altra nuova variante Brera Cut non è solo estetica, ma una sfida alla costruzione della scarpa, scomponendo la tomaia rivelando diverse possibilità in fatto di accostamento di colori.
Sceglie il palcoscenico della settimana della moda milanese anche Santoni, marchio di calzature marchigiano, presentando la autunno-inverno Aurora: ispirata alla luce che precede le albe invernali, la collezione prende forma su modelli sia tradizionali che sportivi del brand come lo stivaletto Carlo, il Chelsea Easy Nova e la sneaker Easy Bounce Mountain. Focus della collezione sulla Velatura, tecnica di colorazione a mano realizzata applicando strati su strati di colore ottenendo variazioni sottili su tonalità invernali come marrone, rosso, verde e arancione.
Anche Doucal’s, brand di calzature nato nel 1973 da Mario Giannini, italiano ma molto influenzato dalla cultura dell’abbigliamento anglosassone, attinge alle atmosfere invernali per la sua nuova collezione. La collezione autunno-inverno 26/27 dal nome Gentle Winter si fonda non solo sull’estetica ma anche sull’atmosfera di calore dei mesi più freddi: colori e forme rassicuranti per trasmettere comfort in ogni forma e per ogni occasione. La mission del brand sia dalle sue origini è tenere ben saldo il rispetto per il know-how e per le forme tradizionali senza mai far mancare l’innovazione, valore che l’ha portato ad essere presente in ogni angolo del mondo.
















Portabandiera della tradizione calzaturiera in Italia anche Antica Cuoieria, nato ufficialmente nel 2018 ma che affonda le sue origini fino al 1945 nel Calzaturificio Soldini di Arezzo. La loro fall-winter 26/27 presentata a Pitti Uomo si concentra sul mantenere la tradizione attraverso materiali e tendenze attuali: focus principale della collezione sono i mocassini, tra variazioni di forme classiche e altre più importanti, tutti realizzati con pellami e materiali in grado di garantire comfort. Rimaniamo nel regime delle scarpe sportive con Guardiani, marchio di calzature che a Pitti Uomo porta la sua nuova autunno-inverno grazie alla acquisizione da parte di Bi&Do, azienda italiana che cura il processo di creazione dal design al brand management. La collezione vede la sneaker come protagonista, realizzata con materiali come pelle e suede in colorazioni calde e profonde come l’antracite, il blu navy e il burgundy.
Con un’anima atletica sin dalla sua nascita a Padova nel 1920 anche Valsport, imponendosi da subito come marchio di articoli e scarpe sportive raggiungendo poi gli apici di produzione e status negli anni Sessanta e Settanta, quando le loro scarpe verranno indossate dai più grandi campioni dell’atletica, calcio, ciclismo e Formula Uno. Per la autunno-inverno 26-27 Valsport ripropone i loro modelli sportivi iconici come la Davis e la Olimpia per il lifestyle sia maschile che femminile, accostando materiali più tradizionali a ad altri più tecnici come il nylon, non tralasciando lavorazioni come pelli invecchiate a mano.
Oltre ai nomi italiani, il nostro paese è diventato la vetrina delle nuove autunno-inverno 26/27 per brand di calzature provenienti da tutti i continenti: In occasione di Pitti Uomo 2026, il brand statunitense di calzature Sebago spegne ottanta candeline dalla sua fondazione, cercando con la collezione autunno-inverno 26/27 di espandere il proprio universo con un abbigliamento ispirato al mondo preppy ma anche alla natura, dalla pesca ai paesaggi rurali “western” degli USA. Il loro settore di punta rimane però il footwear, costituito da conferme iconiche del brand come i mocassini e le scarpe da barca ma ampliato anche da stivali texani, in pelli e costruzioni fatte per durare.
Viaggiando dal “far west” all’estremo oriente, Flower Mountain, brand di sneakers fondato a quattro mani nel 2015 dal giapponese Keisuke Ota e dal pechinese Yang Chao, fonde lo spirito urban con gli utilizzi in natura. L’ultima linea di sneakers del brand presentata a Pitti Uomo espande la loro proposta con nuovi modelli e materiali, come le nuove Sanchia e Ranya pensate per il contesto urbano e la Asuka 3 dal look più vintage. I materiali utilizzati spaziano dai più invernali come lana e tartan fino a quelli dedicati alla capsule “Harmony of Traditions”, cotoni, tele e ricami tipici della tradizione giapponese
Anche il marchio danese Ecco, nato dalla coppia marito-moglie Karl e Birte Toosbuy nel 1963, ha portato a Pitti Uomo le novità in fatto di calzature: ispirata al concetto di “rewilding”, la riscoperta della connessione tra uomo e ambiente, diventano protagonisti per l’uomo modelli ispirati ai paesaggi artici grazie a colori come il marrone, il viola e il teal, mentre per la donna il brand si è ispirato al lavoro della pittrice danese Mie Olise Kjærgaard. Oltre al ritorno dei modelli classici di Ecco come la Walker e la Joke, è stata presentata al Pitti anche la collaborazione con lo stilista Craig Green e il brand giapponese White Mountaineering.
Se si parla di pelletteria è impossibile non citare anche gli accessori da viaggio, rappresentati a Pitti Uomo dal brand italiano Piquadro, forte della sua esperienza nel settore con un approccio orientato al design, alla funzionalità e alla sostenibilità dei suoi prodotti tra cui il pellame certificato come sostenibile in ogni passaggio della filiera e i tessuti interamente riciclati. La collezione autunno-inverno 26/27 di Piquadro mette la tecnica e la ricerca al servizio dell’esperienza d’uso e all’identità specifica dei singoli prodotti: la linea PQLM con focus sui diversi utilizzi grazie alla modularità così come la linea Rover pensata per gli utilizzi urbani. Ancora la linea Corner arricchita oltre che nella gamma colori anche nelle funzioni con una tasca riscaldante e cavo di ricarica integrato e la linea Sync, che utilizza l’impronta digitale del proprietario come sistema di sicurezza.
Per gli accessori non sono mancate nemmeno sciarpe, stole e foulard, in particolare quelle di Faliero Sarti, brand che affonda le sue radici nell’omonimo lanificio fondato da nel 1949. Si tratta di un vero punto di riferimento per grandissimi stilisti, da Giorgio Armani a Vivienne Westwood, che si affidava per la sua comunicazione a fotografi del calibro di Steven Meisel. Oggi alla sua terza generazione la linea Accessorio è sotto la guida della nipote del fondatore Monica, che con la autunno-inverno 26/27 rilancia tessuti stampati provenienti dall’archivio del lanificio, arricchisce la proposta con sciarpe di nuove misure e tessuti – modal lana seta -, mentre la palette stagionale si tinge di colori caldi tra vinaccia, terra e blu profondo. Proseguono anche le collaborazioni del marchio come quella con l’artista Paolo Fiumi e i suoi skyline delle città o con il brand di calzature Taji Shoes tramite una capsule di sabot in tessuti d’archivio.
L'articolo Le tendenze moda uomo per l’autunno-inverno 2026: dalle scarpe alla valigia che si apre con l’impronta digitale, tutte le novità viste a Pitti e Milano proviene da Il Fatto Quotidiano.


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews
Erano intervenuti dopo essere stati chiamati per spegnere un incendio nel Parco Rosmarino di Carbonia, in Sardegna. Non immaginavano che sotto al rogo di sterpaglie si nascondesse un cadavere. Proprio in questo modo, invece, i vigili del fuoco scoperto il corpo di Giovanni Musu, disoccupato 53enne, con alcuni precedenti penali. Le fiamme avevano raggiunto il cadavere alle gambe. Secondo quanto emerso finora, Musu sarebbe stato colpito ripetutamente con un’arma da taglio: una delle ferite, inferta alla gola, potrebbe essere stata mortale. Musu è stato ritrovato sanguinante e con le gambe avvolte dalle fiamme. L’incendio sarebbe un tentativo di cancellare le tracce.
Erano le 4 del mattino. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Carbonia insieme al nucleo investigativo di Cagliari e poi anche il Ris. A coordinare le indagini il pm della procura del capoluogo sardo Danilo Tronci. La zona del ritrovamento è stata delimitata e sul corpo del 53enne è stato eseguito un primo esame dal medico legale, in attesa della dell’autopsia, disposta dallo stesso pm.
L’indagine si muove negli ambienti dello spaccio e del consumo di droga. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi mesi di vita dell’uomo e la rete di relazioni. L’ipotesi è che il delitto possa essere maturato al termine di un litigio degenerato o come conseguenza di contrasti legati a dinamiche criminali, anche se al momento nessuna pista viene esclusa. Sono già stati ascoltati numerosi testimoni e sono scattate diverse perquisizioni. I controlli hanno riguardato l’abitazione della vittima e le case di persone ritenute potenzialmente coinvolte, nel tentativo di raccogliere elementi utili a individuare il responsabile.
Da capire se l’aggressione sia avvenuta nel parco o in un luogo esterno. Le indagini si concentrano – oltre che sui motivi dell’omicidio e sulla ricerca del colpevole – anche sul passato recente di Musu. Non si esclude una possibile assunzione di droghe prima di essere ucciso, dato il ritrovamento di alcune siringhe – che sembrerebbero confermare anche la pista legata al mondo delle sostanze stupefacenti.
L'articolo Sardegna, 53enne accoltellato e dato alle fiamme in un parco a Carbonia: si cerca il killer proviene da Il Fatto Quotidiano.
© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews
L’emendamento alla Legge sull’intelligence, approvata con 68 voti favorevoli, 8 astenuti e nessun voto contrario, conferisce enormi poteri ai servizi, riducendo a lumicino diritti civili. Tra i nuovi poteri concessi ai piedipiatti: ottenere segretamente impronte digitali, campioni vocali, odore e altri prelievi da una persona; utilizzare materiali o altri metodi di marcatura di esseri umani ai fini della loro identificazione; e acquisire equipaggiamento speciale, esplosivi e materiali esplosivi oltre alle armi d’ordinanza. Tutto ciò senza alcuna autorizzazione di un giudice, la quale potrebbe essere concessa a posteriori, 24 ore dopo. La procedura non riguarda solo i cittadini lituani, o extracomunitari, ma è applicabile anche a tutti i cittadini dell’UE residenti, soggiornanti o semplicemente in transito sul territorio lituano.
L'articolo Lituania: Legge sulla sicurezza calpesta diritti civili assicurando lo strapotere dei servizi proviene da Visione TV.
L’Associazione nazionale magistrati ha chiesto di essere audita dalla Commissione europea. Il motivo? Il sindacato delle toghe vuole illustrare la “situazione allarmante“, dovuta al “rischio di collasso della Giustizia italiana per l’inadempimento del governo italiano agli impegni assunti in sede europea con riguardo all’Ufficio per il processo“. Mentre infuria lo scontro tra magistratura ed esecutivo in vista del referendum sulla separazione delle carriere, c’è un altro fronte che si apre tra toghe e politica: quello dell’attuazione del Pnrr in tema di giustizia. La richiesta di audizione è contenuta nel documento approvato dal Consiglio direttivo centrale dell’Associazione nazionale dei magistrati.
Ricordando che l’Ufficio per il processo è stato “incluso nel Pnrr quale misura di natura strutturale, destinata a modificare in modo permanente l’organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari e dei giudici italiani”, l’Anm sottolinea che “a gennaio 2026 a meno di sei mesi dal termine del progetto, nessun bando è stato pubblicato o reso noto per la stabilizzazione dei funzionari addetti all’Ufficio per il processo, che nel frattempo stanno lasciando gli uffici giudiziari per altre opportunità di lavoro”. Eppure nel rendiconto al 31 ottobre scorso dell’Unità di missione del ministero della Giustizia sull’attuazione degli interventi del Pnrr, il governo ha dato atto “che la misura sull’Ufficio per il processo e Capitale Umano prevede l’assunzione e la permanenza in servizio di 10mila unità di personale Pnrr (addetti all’Ufficio per il Processo e personale tecnico-amministrativo), con l’obiettivo di creare un vero e proprio staff di supporto al magistrato e alla giurisdizione – con compiti di studio, ricerca, redazione di bozze di provvedimenti – e pone, altresì, le fondamenta di una struttura al servizio dell’intero Ufficio giudiziario, con funzioni di raccordo con le cancellerie e le segreterie, anche con mansioni tipicamente amministrative quale naturale preparazione e completamento dell’attività giurisdizionale, di assistenza al capo dell’ufficio ed ai presidenti di sezione indirizzi giurisprudenziali e di banca datì”.
Eppure, aggiunge il sindacato della toghe,”la stessa relazione riferisce che al 31 ottobre 2025, il personale effettivamente in servizio si era ridotto a 8.930 unità. È infatti accaduto che in assenza di qualsivoglia progetto concreto di stabilizzazione del personale assunto con i fondi del Pnrr, oltre mille funzionari, tra i più capaci, appositamente formati ed inseriti nei progetti dell’Ufficio per il processo, abbiano lasciato l’amministrazione della Giustizia per altre opportunità di lavoro”. “L’11 agosto del 2025 – prosegue l’Anm – il ministero della Giustizia ha annunciato che entro il mese di ottobre avrebbe avviato una procedura comparativa per la stabilizzazione dei funzionari addetti all’Ufficio per il processo. A gennaio 2026, a meno di sei mesi dal termine del progetto, nessun bando è stato pubblicato o reso noto per la stabilizzazione dei funzionari Addetti all’Ufficio per il processo”.
Dunque, sottolinea il sindacato dei magistrati, “il governo non ha stanziato i fondi necessari a reclutare 10mila unità di funzionari” previsti dal progetto del Pnrr in cui il governo italiano si è impegnato verso l’Unione europea. Quindi, è l’allarme, si rischia così “di disperdere risorse e progettualità, di essere costretti ad abbandonare un ormai consolidato metodo di lavoro in team e di dissipare, in breve tempo i progressi raggiunti nell’attuazione del Pnrr”. Il sindacato delle toghe specifica che “la situazione è particolarmente grave nelle Sezioni specializzate per la protezione internazionale che sono chiamate ad attuare il sistema comune europeo dell’asilo e nelle quali un team di supporto al giudice è indispensabile per assicurare le funzioni minime del processo in materia di asilo”. L’Associazione ricorda che la stessa relazione dell’Unità di Missione per il Pnrr per la Giustizia evidenzi come i tribunali e le corti italiani abbiano “raggiunto con ampio anticipo rispetto al termine del progetto (30 giugno 2026) il target della riduzione del 25% del Disposition Time (rispetto alla baseline del 2019) dei processi penali nei tre gradi di giudizio e sono prossimi a raggiungere nei tempi concordati l’abbattimento dell’arretrato dei procedimenti civili di durata ultra-triennale”. A questo punto, dunque, resta “invece incerta la possibilità di raggiungere l’ultimo target, ossia la riduzione del 40% del Disposition Time (rispetto alla baseline del 2019) dei processi civili nei tre gradi di giudizio”.
L'articolo “Governo inadempiente col Pnrr, rischio collasso della giustizia italiana”: l’Anm vuole essere audita alla Commissione Ue proviene da Il Fatto Quotidiano.
Parenti, amici e compagni di Abanoub Youssef, lo studente ucciso venerdì scorso in un istituto professionale di La Spezia, hanno dato vita una protesta spontanea questa mattina di fronte all’obitorio dell’ospedale cittadino. Un centinaio di persone ha occupato il marciapiede e la sede stradale esponendo cartelli per chiedere il massimo della pena nei confronti dell’assassino e l’impegno delle istituzioni nel rendere sicure le scuole. “La scuola è complice“, “Giustizia per Abu”, “Vogliamo una giustizia veloce”, “Abbiamo paura a tornare a scuola” alcune delle frase scritte sui cartelli mostrati dai manifestanti. Nessun momento di tensione, ma piuttosto di commozione per i parenti straziati dal dolore. La manifestazione poi si è spostata in prefettura.
L'articolo Studente ucciso a La Spezia, la protesta di parenti e amici: “La scuola dovrebbe essere un posto sicuro” proviene da Il Fatto Quotidiano.
Aveva perso la mano sinistra a causa dello scoppio di un petardo artigianale durante la notte di Capodanno e da allora era ricoverato in gravissime condizioni al Sant’Andrea di Vercelli. È morto questa mattina Bruno Savoia, 43 anni. A riportare la notizia è il quotidiano La Stampa. Troppo gravi le ferite ricevute a seguito dell’esplosione del botto – autoprodotto – che lo aveva colpito anche all’addome. Sul corpo dell’uomo erano presenti diverse ustioni.
Savoia abitava a Vercelli, in via Leopardi 11. Viveva assieme alla compagna Grazia, che la notte dell’incidente ha subito raggiunto l’uomo, ferito. E che oggi denuncia: “ho chiamato l’ambulanza 18 volte, non arrivava mai”. La Notte di San Silvestro la coppia ha trascorso il veglione con degli amici. Dopo la mezzanotte, Savoia era sceso con loro nel cortile del palazzo e aveva acceso il petardo. Il rumore dell’esplosione era stato forte, tanto da aver attirato l’attenzione di tutti gli inquilini dello stabile.
Immediatamente trasportato al pronto soccorso da un’auto della compagnia, le sue condizioni erano immediatamente apparse gravi tanto che i medici non erano riusciti a ricostruire l’arto nonostante un delicato intervento chirurgico. Le indagini dei carabinieri di Vercelli intanto proseguono, ed è possibile che verrà disposta un’autopsia.
L'articolo Perde una mano a Capodanno per l’esplosione di un petardo artigianale: muore dopo 18 giorni a Vercelli proviene da Il Fatto Quotidiano.




© RaiNews


© RaiNews
Un proiettile calibro 9, sparato da una pistola. È quello che hanno trovato i carabinieri nei pressi dell’ingresso del Palazzo di Città a Fasano, in provincia di Brindisi, la mattina di domenica 18 gennaio. Un ritrovamento inquietante, visto che in quel luogo sarebbe passato dopo pochi momenti Luca Tescaroli, procuratore capo di Prato. Il magistrato era atteso per la presentazione del suo libro, Il biennio di sangue, edito da Paperfirst, prevista per le ore 11. I militari hanno subito collegato il ritrovamento del proiettile all’arrivo del magistrato, chiedendo l’immediato intervento degli artificieri.
Le indagini, affidate ai carabinieri della compagnia di Fasano e a quelli del comando provinciale di Brindisi, sono in corso. Gli investigatori stanno verificando la presenza di telecamere sul luogo del ritrovamento, per capire chi ha abbandonato il proiettile nel luogo dove Tescaroli era atteso. L’altra ipotesi è che qualcuno abbia esploso il colpo di pistola nei pressi del Palazzo di Città. La presentazione del libro del magistrato si è comunque svolta come da programma.
Tescaroli vive sotto scorta da molti anni, a causa delle minacce ricevute in passato. “Ti faremo saltare con il tritolo. Finiremo quello che abbiamo iniziato”, c’era scritto in una lettera di minacce spedita al magistrato nel luglio del 2024. L’anno precedente, invece, un pacco sospetto era stato ritrovato davanti casa di Tescaroli a Firenze: conteneva un pacco batterie per la ricarica di microcar elettriche da cui fuoriuscivano fili neri. Già giovannissimo pm a Caltanissetta e poi procuratore aggiunto a Roma e a Firenze, negli anni il magistrato ha indagato – tra le altre cose – sulla strage di Capaci e su quella di via d’Amelio, sull’omicidio del banchiere Roberto Calvi, su Mafia Capitale e sulle bombe del 1993. Nell’esperienza da aggiunto della città toscana ha coordinato l’inchiesta su Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi (fino alla sua morte), indagati per concorso nelle stragi di Firenze, Roma e Milano. Da quando è stato nominato al vertice della procura di Prato, invece, Tescaroli ha puntato i riflettori sulle faide interne ai clan cinesi: una spirale di violenza fatta di omicidi, pestaggi e incendi.
L'articolo Minacce a Tescaroli, trovato un proiettile dove il magistrato ha presentato il suo libro: indagano i carabinieri proviene da Il Fatto Quotidiano.
Scatta l’allarme per le crocchette per cani della marca Radames, commercializzata nei supermercati Eurospin. Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo del prodotto venduto nel pacco da 10 chili, con lotto di produzione 5286 e con scadenza datata 13 aprile 2027 (le crocchette in questione sono prodotte da Gheda Mangimi S.r.l., presso la sede stabilimento Ostiglia -Mantova, Via Comuna Santuario, 1). Nel cibo, infatti, è stata rilevata la presenza di “aflatossina B1” oltre i limiti della legge. L’avviso è stato pubblicato lo scorso 9 gennaio sul portale del Ministero, che ha specificato che coloro che hanno acquistato il prodotto sono tenuti a non consumarlo e a riconsegnarlo presso il punto vendita.

Che cos’è l’aflatossina? Si tratta di un agente chimico prodotto dalla muffa Aspergillus flavus, che prolifera sui cereali spesso utilizzati come ingredienti per i mangimi degli animali domestici. È bene sottolineare che l’aflatossina è un componente presente in maniera naturale all’interno dei cibi composti da cereali. Tuttavia, come nel caso delle crocchette di Radames, se la quantità della tossina supera i limiti di legge il cibo non deve essere ingerito. L’assunzione di livelli elevati di aflatossina può provocare vomito, diarrea, perdita di appetito, ittero e, nei casi più estremi, la morte dell’animale. I nostri amici a quattro zampe sono più vulnerabili a questo agente chimico perché, a differenza degli esseri umani che seguono una dieta variegata, si nutrono degli stessi alimenti per lunghi periodi.
L'articolo Allarme chimico nelle crocchette per cani Eurospin: “Livelli di aflatossina superiori ai limiti”. Ecco il lotto ritirato dal Ministero della Salute proviene da Il Fatto Quotidiano.
Mentre dentro e fuori l’Iran la tensione rimane altissima, lo scontro è anche sulle informazioni che arrivano da un Paese dove le comunicazioni sono ancora molto complicate dopo il blackout imposto dal regime. Nelle scorse ore, l’ong Hengaw, specializzata in difesa dei diritti umani, ha smentito la notizia diffusa da Israele sulla morte di Erfan Soltani, giovane diventato un simbolo delle ultime proteste contro gli ayatollah. L’organizzazione umanitaria infatti, ha diffuso su X un comunicato con la foto del ragazzo dove si dice che alla famiglia “è stata concessa una breve visita di persona oggi” e si conferma “che è attualmente vivo e in condizioni fisiche stabili”. L’aggiornamento arriva dopo che un account ufficiale su X del governo israeliano in farsi aveva reso noto che secondo alcune fonti Soltani sarebbe stato “brutalmente ucciso mentre era in custodia della Repubblica islamica”.
Intanto, secondo i media locali, le autorità iraniane stanno valutando di ripristinare “gradualmente” l’accesso a internet dopo il blocco delle comunicazioni. L’agenzia Afp ha anche fatto sapere di esser riuscita a connettersi a internet dall’ufficio di Teheran, sebbene la maggioranza dei provider web e mobili restino interrotti. I dati sul traffico indicano un ritorno significativo di alcuni servizi online, tra cui Google, il che suggerisce che sia stato abilitato un accesso fortemente filtrato, a conferma delle segnalazioni degli utenti su un ripristino parziale” della rete, ha spiegato NetBlocks in un post sui social. Le chiamate internazionali sono possibili da martedì 13 e la messaggistica di testo è stata ripristinata ieri 17 gennaio. L’Iran avvierà il ripristino “graduale” dell’accesso a Internet, bloccato dall’8 gennaio 2026 a causa delle proteste nazionali iniziate il 28 dicembre, ha riferito all’Ansa una fonte informata. Anche i social network Instagram, Telegram, X, Facebook e YouTube erano stati vietati in Iran alcuni anni fa, spingendo gli utenti a utilizzare le Vpn, ma anche le Vpn sono state vietate dall’8 gennaio.
Secondo un rapporto redatto da medici iraniani e citato dal Sunday Times, “le vittime nella repressione delle proteste in Iran supererebbe i 16.500 morti”. Il rapporto afferma nello specifico che la maggior parte delle vittime sono giovani sotto i 30 anni e che altre 330.000 persone sono rimaste ferite, con gran parte delle uccisioni avvenute nell’arco di due giorni. “Questo è un livello di brutalità completamente nuovo”, ha dichiarato al Times il professor Amir Parasta, chirurgo oculista iraniano-tedesco che ha contribuito a creare la rete di medici che ha messo a punto il documento. “Questa volta stanno usando armi di livello militare e quello che stiamo vedendo sono ferite da arma da fuoco e da schegge alla testa, al collo e al torace”. Il rapporto afferma che i dati sono stati raccolti dal personale di otto importanti ospedali oculistici e 16 pronto soccorso in tutto l’Iran. Afferma che i medici sono stati in grado di comunicare utilizzando la tecnologia vietata Starlink durante il blocco di Internet. Il rapporto segnala anche un elevato numero di lesioni agli occhi: le forze di sicurezza avrebbero fatto ricorso anche a fucili da caccia, con almeno 700 persone che hanno perso la vista.
EXCLUSIVE – Hengaw
Hengaw has learned that the family of Erfan Soltani has been granted a brief in-person visit with him today, Sunday, January 18, 2026, and has confirmed that he is currently alive and in stable physical condition.
This development comes after days of extreme… pic.twitter.com/kwcSHVeVMG
— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 18, 2026
L'articolo Iran, una ong smentisce Israele sulla notizia della morte di Erfan Soltani: “È vivo”. Ancora accesso filtrato di internet proviene da Il Fatto Quotidiano.

La missione asiatica di Giorgia Meloni in Oman, Giappone e Corea del Sud si inserisce in una traiettoria strategica chiara. L’Italia sceglie di collocarsi in modo stabile nel nuovo baricentro globale dell’Indo-Pacifico, rafforzando la propria proiezione internazionale in sintonia con Washington e con i partner del G7. In questo percorso, la tappa coreana assume un ruolo centrale perché condensa alcune delle principali dinamiche del sistema internazionale contemporaneo. Il rapporto con la Cina, il de-risking tecnologico europeo e la riorganizzazione della sicurezza in Asia nord-orientale trovano qui un punto di convergenza strategica.
A Tokyo, nel corso della sua terza visita in Giappone da quando è alla guida del governo, la Presidente Meloni incontra per la prima volta in un vertice bilaterale la premier giapponese Sanae Takaichi, diventando il primo leader europeo a visitare il Paese dopo il suo insediamento. La visita si colloca nel contesto del centosessantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche, un passaggio simbolico scelto per elevare il rapporto bilaterale a partenariato strategico speciale e per dare impulso al Piano d’Azione Italia-Giappone 2024-2027, definito in occasione del G7 di Hiroshima.
Il linguaggio adottato dai due governi riflette una visione condivisa. Al centro vi sono l’idea di un Indo-Pacifico libero e aperto, il rispetto dello stato di diritto, la sicurezza delle catene di approvvigionamento e una crescente interoperabilità in ambito difensivo. In questo quadro, Italia e Giappone sviluppa una convergenza anche su Africa e Mediterraneo allargato. Tokyo riconosce in Roma un ponte verso l’Europa e il Nord Africa, mentre Roma individua nel Giappone un partner capace di rafforzare le proprie capacità industriali e tecnologiche in settori chiave come spazio, cyber e difesa.
A Seoul il contesto assume caratteristiche differenti. Per Meloni questa è la prima visita a Seoul, mentre per il presidente Lee Jae-myung rappresenta una delle prime visite ufficiali di un leader straniero dall’avvio del ritorno della presidenza alla Blue House, una scelta simbolica volta a marcare una discontinuità politica rispetto al predecessore Yoon Suk-yeol. Lee esprime una leadership progressista, caratterizzata da una diplomazia pragmatica e orientata all’equilibrio. Il recente dialogo di Seul con Pechino segnala una volontà di riaffermare un ruolo centrale della presidenza nella definizione della politica estera e di gestire con maggiore flessibilità le dinamiche regionali, con la consapevlozze di cercare spazi di maggiore autonomia.
Sul piano strategico, la Corea del Sud valorizza un equilibrio calibrato. L’alleanza militare con gli Stati Uniti resta un pilastro, anche nel quadro della deterrenza verso Pyongyang, mentre il mantenimento di un canale politico con la Cina contribuisce alla stabilità regionale, e completa a livello diplomatico la gestione del dossier nordcoreano.
L’attenzione di Seul verso la Cina si inserisce in una strategia volta a favorire la stabilità nella penisola coreana e a mantenere margini negoziali ampi. Con una Corea del Sud più cauta rispetto agli orientamenti normativi del Free and Open Indo-Pacific (FOIP), l’Italia considera il fattore cinese come una variabile da gestire con pragmatismo. In questo contesto, il lessico adottato privilegia il riferimento alla cooperazione regionale e a un approccio graduale, capace di tenere insieme sicurezza e stabilità economica.
La cooperazione economica tra Italia e Corea del Sud poggia su basi solide. Nel 2024 l’interscambio ha raggiunto circa 11,4 miliardi di euro, all’interno del quadro regolatorio dell’Accordo di Libero Scambio UE-Corea in vigore dal 2011. Seul rappresenta oggi il primo partner asiatico dell’Italia in termini pro capite, con catene del valore particolarmente integrate nei settori dell’automotive, della meccanica di precisione, della chimica fine, della moda e dell’agroalimentare di alta gamma.
La visita è accompagnata dalla definizione di una dichiarazione congiunta su commercio, investimenti e partenariati industriali, affiancata da intese operative su protezione civile e tutela del patrimonio culturale. Questi ambiti rafforzano la dimensione bilaterale e contribuiscono a proiettare l’immagine dell’Italia come partner tecnologicamente affidabile e culturalmente attrattivo, capace di coniugare competenze industriali e soft power.
Semiconduttori e de-risking, perché Seul conta
Tuttavia, il baricentro politico del vertice riguarda principalmente la cooperazione tecnologica avanzata, in particolare nel settore dei semiconduttori. L’Italia guarda con interesse alla Corea del Sud come attore di primo piano nella produzione di chip di memoria e negli impianti di nuova generazione. In un contesto europeo orientato al de-risking, Roma individua in Seoul un partner affidabile per diversificare fornitori e rafforzare la resilienza delle filiere industriali strategiche.
Questa cooperazione si inserisce in modo coerente nel perimetro euro-atlantico e risulta compatibile con le dinamiche della Chip 4 Alliance, che riunisce Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e Taiwan. Per Seoul, un rafforzamento strutturato dei rapporti con l’Italia favorisce l’accesso ai mercati europei e accresce il peso politico a Bruxelles. Per Roma, la partnership contribuisce a consolidare la competitività industriale e la sicurezza tecnologica in settori strategici.
Accanto alla dimensione tecnologica civile, la cooperazione in ambito difesa si afferma come un vettore strutturale di convergenza tra Italia e Asia orientale. L’esperienza maturata dall’Italia nel Global Combat Air Programme (GCAP), sviluppato insieme a Giappone e Regno Unito, ha rafforzato in modo significativo il posizionamento nazionale nel segmento più avanzato dell’industria aerospaziale e militare. Il GCAP è un programma congiunto per lo sviluppo di un sistema di combattimento aereo di nuova generazione, centrato su una piattaforma di sesta generazione integrata con droni, sensori avanzati, intelligenza artificiale, capacità di comando e controllo multi-dominio e architetture digitali aperte. Si tratta di un ecosistema tecnologico che connette difesa, spazio, cyber e manifattura avanzata.
La partecipazione italiana al GCAP ha accresciuto la credibilità del Paese come partner tecnologico di lungo periodo. Questo posizionamento ha suscitato un interesse crescente anche in Asia, dove il modello di cooperazione trilaterale viene osservato come riferimento per nuove forme di partenariato industriale e tecnologico.
In questo contesto si inserisce il dialogo con la Corea del Sud, che dispone di un’industria della difesa dinamica e fortemente orientata all’export, con competenze consolidate nei settori aerospaziale, navale e dei sistemi avanzati. Con Seul si esplorano possibili collaborazioni industriali in ambito aerospaziale e navale, con particolare attenzione ai sistemi anti-drone, ai sensori di nuova generazione, alle piattaforme a duplice uso e all’integrazione tra componenti hardware e software ad alta intensità digitale. La complementarità tra le capacità italiane nei sistemi, nell’elettronica avanzata e nella cantieristica navale, le tecnologie europee in ambito missilistico e di comando e controllo, e le competenze coreane nella produzione, nell’automazione e nella scalabilità industriale apre spazi concreti per iniziative congiunte.
Questa sinergia offre prospettive operative non limitate al perimetro bilaterale. La possibilità di sviluppare soluzioni integrate e competitive consente di guardare a mercati terzi in modo strutturato, valorizzando una presenza industriale congiunta.
Tutto mentre “Mediterraneo globale”, per usare un’espressione di Meloni, Africa e Indo-Pacifico emergono come aree coerenti con la proiezione marittima e industriale di lungo periodo dell’Italia, dove la domanda di sicurezza, sorveglianza, protezione delle infrastrutture critiche e controllo degli spazi marittimi è in costante crescita.
Pertanto, la cooperazione in ambito difesa assume una valenza che va oltre la dimensione industriale. Essa contribuisce a rafforzare l’autonomia strategica dell’Italia all’interno del quadro euro-atlantico, consolida relazioni di fiducia con partner tecnologicamente avanzati e proietta il sistema industriale nazionale in una rete indo-pacifica sempre più centrale negli equilibri globali di sicurezza.
La relazione italo-coreana si fonda quindi su interessi convergenti e risultati tangibili. Commercio, investimenti, tecnologie critiche, difesa e resilienza delle catene di approvvigionamento costituiscono un terreno comune solido.
Proprio questa dimensione pragmatica rafforza la credibilità della partnership. Per l’Italia rappresenta uno strumento efficace di ancoraggio all’Indo-Pacifico e di rafforzamento dell’autonomia strategica all’interno del quadro euro-atlantico. Per la Corea del Sud costituisce una leva per ampliare la propria presenza in Europa, diversificare le relazioni economiche e accrescere il peso nei grandi dossier globali di sicurezza economica e tecnologica.
© RaiNews
Si avvicina il rientro di Federica Brignone, ferma dallo scorso aprile per il grave infortunio rimediato alla gamba – frattura del piatto tibiale e del perone e lesione del legamento crociato anteriore – durante i campionati italiani. L’azzurra infatti risulta iscritta al gigante di Coppa del Mondo di sci in programma martedì a Plan de Corones e dovrebbe quindi tornare a gareggiare a poco più di due settimane dall’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina.
“La detentrice della sfera di cristallo prenderà parte alla sciata in pista del mattino e poi deciderà se gareggiare o meno – fa sapere la Fisi – Per lei si tratterebbe del rientro agonistico a distanza di 292 giorni dal terribile infortunio occorsole lo scorso 3 aprile in Val di Fassa”. La gara altoatesina vedrà al via per l’Italia anche Sofia Goggia, Lara Della Mea, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Ambra Pomarè, Alice Pazzaglia e Anna Tocker. La prima manche sulla pista Erta è in programma alle 10.30, la seconda alle 13.30.
L'articolo Federica Brignone iscritta al gigante di Plan de Corones: “Deciderà al mattino se gareggiare o meno” proviene da Il Fatto Quotidiano.
“Un vincitore del Premio Nobel per la Pace non può condividere il premio con altri, né trasferirlo una volta annunciato”. Il Comitato per il Premio Nobel per la Pace ha espresso forte indignazione in merito al gesto di María Corina Machado, che ha consegnato la sua medaglia a Donald Trump, definendo l’atto come una violazione delle norme che regolano il premio. La dichiarazione ufficiale del Comitato ha sottolineato con fermezza che un vincitore del Premio Nobel non può trasferire il premio ad altre persone né condividerlo, e che una volta che il premio è stato assegnato, esso non può essere revocato. Nonostante non abbia fatto riferimento esplicito né a Machado né a Trump, il Comitato ha ribadito che la decisione è definitiva e non può essere modificata dalle azioni del vincitore. Il 3 gennaio il blitz Usa, voluto da Trump, ha portato alla cattura di Nicola Maduro.
Il Comitato ha poi specificato che la medaglia, il diploma e il premio in denaro che accompagnano il Nobel sono simboli che appartengono al vincitore, ma che, sebbene questi oggetti possano essere donati o venduti, l’identità del destinatario del premio rimane immutata nella storia. Tra i vari esempi, il comitato ha citato il caso di Kofi Annan, che ha donato la propria medaglia all’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, e quello del giornalista Dmitry Muratov, che ha venduto la propria medaglia per sostenere i bambini ucraini. Gesti molto diversi da quelli dell’attivista e con un valore totalmente differente.
Il gesto di Machado, leader dell’opposizione venezuelana, è stato visto come un “momento emozionante” e simbolico, in quanto, secondo le sue parole, ha deciso di donare la medaglia a Trump per riconoscere il suo impegno a favore della libertà in Venezuela e in tutta la regione. Tuttavia, la sua spiegazione non ha placato le polemiche. Donald Trump, dal canto suo, ha espresso un tono di rispetto nei confronti di Machado, definendola una “donna molto gentile” e sottolineando che l’atto di ricevere la medaglia è stato per lui un “gesto molto carino”. Il presidente statunitense – che più volte ha sostenuto di meritare il premio (che Barack Obama ottenne “sulla fiducia” nel 2009, ndr) ha affermato di essere rimasto colpito dal suo impegno e ha voluto esternare la sua gratitudine per aver ricevuto il premio.
L'articolo L’indignazione del comitato per il Nobel dopo che Machado ha consegnato la medaglia a Trump: “Non si può condividere il premio” proviene da Il Fatto Quotidiano.
“Certe cose non sono coincidenze, sono abbracci che attraversano il cielo”. Una fede nuziale persa 50 anni fa in un campo di ulivi è tornata tra le mani del proprietario. Il Corriere di Arezzo ha riportato la vicenda accaduta tra Antria e San Polo, a pochi chilometri da Arezzo. A ritrovare l’anello è stata l’associazione di Subbiano “Quelli della Karin”, specializzata nella perlustrazione dei campi locali alla ricerca di reperti bellici. La zona è nota per i ritrovamenti di ordigni e piastrine di riconoscimento dei soldati della Seconda guerra mondiale ma, questa volta, la scoperta è stata ben diversa. La fede, ritrovata a circa dieci centimetri di profondità grazie a un metal detector, aveva al suo interno un’incisione: Alfiero 5-4-1970.
Il dettaglio ha colpito uno dei membri dell’associazione impegnato nella ricerca sul campo. L’uomo, originario della zona, ha collegato il nome inciso sull’anello al proprietario dell’oliveto ed è andato a bussare alla sua porta di casa, non lontana dal luogo del ritrovamento. Come raccontato dal Corriere di Arezzo, il signor Alfiero, proprietario dell’anello, si è emozionato alla vista dell’oggetto. L’anziano ha raccontato di aver infilato l’anello alla moglie il 5 aprile del 1970. Oggi, la coniuge non c’è più. La donna, infatti, è morta nel 2022. La restituzione della fede è diventata un momento di gioia collettiva.
“Quando abbiamo bussato alla sua porta per restituirgliela, il tempo si è fermato. Lacrime, emozione pura e mani che tremavano”, hanno dichiarato i membri dell’associazione, come riferisce Fanpage. “Siamo certi che sua moglie, da lassù, abbia guidato quel metal detector esattamente nel punto giusto. Perché certe cose non sono coincidenze”, hanno concluso dall’associazione.
L'articolo “Certe cose non sono coincidenze”: la moglie defunta perse la fede nuziale in un campo di ulivi, dopo 50 anni degli sconosciuti la ritrovano e gliela restituiscono proviene da Il Fatto Quotidiano.
Decine di migliaia di cubani hanno partecipato alla lunga marcia per rendere omaggio ai 32 militari uccisi in Venezuela durante l’operazione militare degli Usa e per mandare un messaggio alla Casa Bianca e al presidente Donald Trump. È avvenuto venerdì 16 gennaio all’Avana, in un corteo organizzato in “difesa della sovranità di Cuba e della Rivoluzione”. “Honor y gloria”, lo slogan scelto per chiamare le persone a raccolta nella “Marcia del popolo combattente”, snodatasi dalla Tribuna Antimperialista lungo il Malecón, il lungomare avanero.
I cittadini hanno cominciato a riempire le strade della città sin dalle prime ore del mattino. Il palco della manifestazione è stato montato in un luogo simbolico: alle spalle all’ambasciata statunitense. Da qui il presidente della Repubblica e segretario generale del Partito comunista cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nella classica tenuta verde oliva, si è scagliato contro “l’aggressione terrorista” compiuta a Caracas lo scorso 3 gennaio dalle forze speciali Usa. “Cuba è terra di pace” ha detto. “Non minaccia né sfida, ma se aggrediti siamo in milioni disposti a
combattere con la stessa fierezza dei nostri compatrioti caduti”.
In prima fila i 32 cartelli con impressi i nomi e i volti dei soldati impegnati nel Paese bolivariano alleato dell’Avana, tumulati nelle varie province di provenienza, dove si sono svolte altrettante celebrazioni di massa nei giorni scorsi. Un discorso pronunciato sotto un cielo grigio, tra gli applausi e le risposte corali dei presenti. Fra loro militari, studenti, lavoratori, cittadini comuni, giovani e anziani. Alcuni “spinti” dal Partito comunista che controlla il Paese, altri sinceramente fedeli al socialismo e alla Revolución, nonostante la grave crisi economica che attanaglia l’isola ormai da molti anni. “Qui non si arrende nessuno”, il grido ripetuto durante il corteo, quando il serpentone umano stretto tra i cordoni di sicurezza ha riempito il lungomare di bandiere cubane e venezuelane. Qualcuno ha il vessillo rosso con la falce e il martello, altri il volto di Fidel Castro, accostato a José Martí (eroe della Patria cubana nella lotta d’indipendenza contro gli spagnoli) e a Hugo Chávez, alla cui figura risale il legame venticinquennale tra il socialismo cubano e quello venezuelano.
Tra gli obiettivi principali degli slogan scanditi dai manifestanti ci sono Trump e soprattutto Rubio, figlio di cubani dal dente particolarmente avvelenato nei confronti del governo dell’isola. “Cuba è sovrana e
decide da sola il proprio destino“, è il concetto gridato al passaggio davanti all’ambasciata Usa, riaperta nell’era Obama in un clima di speranza e tornata oggi cupa sede dell’imperialismo “Yanqui”, come viene definito qui.
Volti seri, corrucciati ma anche sorridenti, tra tamburi e cori di scherno. Come quello di Mijaín López, pentacampione olimpico di lotta greco-romana che ha salutato il corteo al fianco del presidente, stringendo
mani e regalando selfie. Dopotutto per molti la manifestazione, scioltasi tra le strade verdi del Vedado, è stata anche una festa.
Nonostante il clima di tensione che ha spinto le autorità dell’isola ad attivare esercitazioni militari, la vita in questi giorni scorre in modo tranquillo, con le difficoltà ormai croniche dettate da una crisi che non accenna a dare tregua. Carenze energetiche in primis. Una situazione deflagrata con lo scoppio della pandemia, che ha falcidiato l’economia cubana, già colpita da centinaia di sanzioni statunitensi. Una lotta quotidiana imposta a buona parte della popolazione, divisa tra difesa della bandiera e una ricerca di ossigeno che spinge anche a emigrare.
L'articolo Cuba, l’omaggio dell’Avana ai 32 militari uccisi nel raid Usa in Venezuela: decine di migliaia in marcia sul lungomare proviene da Il Fatto Quotidiano.
L’autostrada diventa il nuovo terreno di battaglia degli ultras. Oggi poco dopo le ore 12.30 gruppi organizzati delle tifoserie di Fiorentina e Roma si sono scontrati sulla corsia d’emergenza dell’A1 a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, poche ore prima del fischio d’inizio del match tra i rossoblu e i viola, valido per la Serie A.
Circa 200 persone, con cappucci e con i volti coperti, sono scese dalle macchine in autostrada e si sono fronteggiate con caschi e spranghe, mentre gli altri veicoli hanno rischiato incidenti per evitarli. Alcune auto sono rimaste danneggiate nel corso dei tafferugli. I tifosi della Fiorentina erano appunto diretti a Bologna, mentre quelli della Roma a Torino per l’altro match di Serie A, in programma alle ore 18.
La polizia di Bologna è al lavoro per identificare i responsabili: sono al vaglio le immagini delle videocamere anche per ricostruire quanto è accaduto. Tutto sarebbe cominciato al vicino autogrill del Cantagallo, dove un gruppo di tifosi della Fiorentina (diretti a Bologna per la partita del Dall’Ara) hanno incontrato un gruppo di romanisti che stavano andando a Torino per la partita con i granata in programma alle 18. Gli scontri sono avvenuti qualche chilometro dopo, dove molte auto e alcuni minibus si sono fermati nella corsia d’emergenza e nelle piazzole. I tifosi sono scesi dalle auto e si sono affrontati con mazze, martelli, spranghe e caschi. Il tutto è durato pochi minuti, poi le auto sono ripartite, prima dell’intervento delle forze di polizia, avvertite dalle auto in transito.
L'articolo L’autostrada ostaggio degli ultras: guerriglia tra tifosi di Fiorentina e Roma sull’A1, auto danneggiate proviene da Il Fatto Quotidiano.
Un altro motivo per cui l’Ue deve accelerare su materie prime e terre rare è che a Cina non si ferma nel suo progetto di restare monopolista mondiale. Infatti il gigante dell’acciaio Baowu riceve per la prima volta minerale di ferro dalla Guinea, tramite una spedizione dalla miniera di Simandou: un fatto che segna un passo strategico per la sicurezza energetica della Cina, ma che al contempo testimonia (una volta di più) tutta la difficoltà del vecchio continente di farsi autonomo quanto ad approvvigionamento. Anche in questo senso vanno lette le relazioni del governo Meloni in aree altamente strategiche come Corea del Sud e Taiwan, “dense” di materie prime e elementi come i semiconduttori che sono vitali per le imprese italiane.
Il più grande investimento minerario realizzato in Africa riguarda il progetto realizzato in collaborazione tra il governo guineano e il consorzio Winning Consortium Simandou, Baowu, Chinalco e Rio Tinto. Si tratta di 600 chilometri di ferrovia transguineana e nuove infrastrutture portuali che consentiranno di esportare fino a 120 milioni di tonnellate di ferro all’anno. Ma al di là del singolo progetto in questione spicca il dato, generale e geopolitico, dato dalla forte volontà di Pechino di restare in cima alla classifica mondiale: i diciassette metalli che compongono le terre rare sono di fatto nelle mani di Pechino, ovvero i lantanidi e lo scandio che possono essere utilizzati in vari ambiti industriali, tutti strategici per le economie mondiali.
Il ritardo accumulato dall’Ue, sommato ad una regolamentazione asimmetrica, è un dato oggettivo su cui si stanno concentrando le iniziative di alcuni governi come quello di Roma che hanno compreso come tale gap sia deleterio per il futuro stesso della sopravvivenza di interi comparti industriali. Non bisogna dimenticare, infatti, che un caccia F-35 contiene centinaia di chili di terre rare e al contempo missili, radar, satelliti e sistemi di comunicazione sono fatti con leghe ad hoc derivate dalle terre rare, di cui la Cina detiene l’80% delle miniere mondiali. La Cina a partire dagli anni ’80 ha avviato quella che è stata ribattezzata la “dittatura monopartitica” sull’investimento nell’estrazione e nella capacità di lavorazione. E il vantaggio cinese nel settore non è dato esclusivamente dalla dotazione di risorse, ma dalla sua capacità di integrare estrazione, lavorazione e produzione su larga scala.
Al momento altri giacimenti significativi esistono negli Stati Uniti, in Australia, in Brasile, in India e anche nell’Artico. Per cui gli Stati Uniti e i suoi alleati lavorano per stemperare il predominio di Pechino che, di fatto, stringe la morsa cinese sulle terre rare: la prima iniziativa messa in campo è quella di accelerare i progetti sulle terre rare e diversificare la loro fornitura in risposta alle restrizioni alle esportazioni della Cina. Ma non è facile, anche perché tra gli alleati degli Usa non mancano Paesi molto contigui al regime cinese.
Pochi giorni fa a Washington si è tenuto un vertice con i ministri delle finanze del G7 e altri alleati, tra cui Australia, India, Corea del Sud e Ue, per affrontare le vulnerabilità nella catena di approvvigionamento delle terre rare. Un altro momento in cui assumere la consapevolezza che, al di là delle singole mosse della Casa Bianca su dazi, Artico e Iran, serve una maggiore unità di intenti anche da parte dell’Ue che deve capire la difficoltà geopolitica del momento. Cavalli di troia in questa fase sarebbero non solo pericolosi, ma un cappio al collo del vecchio continente.
Due discoteche di Crema e Cremona sono state chiuse temporaneamente a seguito di alcune violazioni in materia di sicurezza e ordine pubblico. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Cremona, Carlo Ambra, che sulla base dell’articolo 100 del TULPS ha attuato due sospensioni di licenza. I locali coinvolti sono il “Moma Club” di Crema (chiuso per 8 giorni) la discoteca “Juliette” di Cremona (chiusa per 15 giorni). I controlli sono stati eseguiti nei primi giorni di gennaio, e si inseriscono in una tipologia di controlli resi necessari probabilmente anche in reazione alla strage di Crans-Montana e al rinnovato interesse pubblico sulla questione sicurezza nei luoghi chiusi. Proprio domenica da Roma è arrivata la notizia, invece, del sequestro preventivo del Piper club di Roma.
Tra gli episodi contestati spiccano due avvenimenti: il 6 gennaio scorso, nella discoteca di Cremona, un giovane è stato aggredito alla gola con la lama di un taglierino. La ferita, fortunatamente superficiale, ha richiesto comunque l’intervento sanitario. Nella discoteca Moma Club, invece, nei giorni scorsi si è verificato un principio d’incendio di alcuni addobbi posizionati sul soffitto del locale causato dalle fontane pirotecniche installate sulle bottiglie. Una dinamica che ricorda fortemente quanto avvenuto in Svizzera la notte di Capodanno. Il locale è intervenuto su Facebook per precisare che “l’episodio relativo a un principio di incendio di alcuni addobbi natalizi, causati dai flambé, è avvenuto antecedentemente alla tragedia successa in Svizzera. Mettere in relazione i due eventi è scorretto, fuorviante e falso”. E, continua ancora la nota, dopo quanto avvenuto e dopo i fatti di Crans-Montana “i flambé sono stati completamente eliminati”.
Oltre a questi due avvenimenti, sono stati segnalati sia ripetuti episodi violenti – all’interno e all’esterno dei locali – sia la somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni. I controlli sono stati effettuati a Cremona il 16 gennaio e a Crema il 17 e sono stati compiuti dalla Polizia di Stato con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, dell’ATS Valpadana e dell’Ispettorato del Lavoro.
Tra le criticità del locale “Juliette” si segnalano: mancato documento di valutazione rischi, irregolarità nella licenza, presenza di materiali non ignifughi nei pressi delle fonti di calore e mancata omologazione – sempre rispetto alla reazione al fuoco – di alcuni arredamenti. Inoltre, assente la documentazione relativa alla formazione dei lavoratori e preoccupanti le condizioni delle uscite di sicurezza – bloccate o per lo meno compromesse da tavolini e sedie.
Nel “Moma Club” invece il controllo ha fatto emergere, oltre al già citato principio di incendio, anomalie come la presenza di minorenni in serate esclusive ai maggiorenni, la mancata verifica dei documenti d’identità e l’occultamento delle – anche qui – due uscite di sicurezza, coperte da delle tende. Inoltre, come nelle discoteca Juliette è stata riscontrata la presenza di materiali non classificati alla reazione al fuoco. Nel corso dell’ispezione sono stati infine individuati dieci lavoratori in nero, il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e la presenza di soli due operatori antincendio rispetto ai quattro previsti.
L'articolo A fuoco gli addobbi sul soffitto per le candele pirotecniche: chiusa discoteca a Crema. Stop anche a un locale di Cremona proviene da Il Fatto Quotidiano.
Una festa nel quinto piano di un edificio dell’XI arrondissement di Parigi è finita nel panico quando il pavimento della casa è crollato, probabilmente a causa del peso a cui era sottoposto per via delle presenza di 50 persone. Gli avventori, in casa per una festa, sono stati evacuati e nel crollo sono rimaste ferite 20 persone. Una donna, soccorsa dai pompieri sotto le macerie, era in arresto cardiaco e le sue condizioni sono considerate gravi. Il suo cuore ha ripreso a battere, ma non sarebbe considerata ancora fuori pericolo.
L’episodio è avvenuto dopo la mezzanotte al 34 bis di rue Amelot, vicino piazza della Bastiglia, zona della movida parigina ancora affollata a quell’ora del sabato sera. Le vie sottostanti sono state teatro di alcune scene di tensione per la fuga dei presenti. Sul posto è intervenuta una carovana di soccorsi formata da 125 pompieri, una quarantina di camion dei vigili del fuoco e una decina di ambulanze. Fonti della polizia francese confermano come l’edificio sia “un residenziale senza precedenti noti di problemi ”
L’architetto Antoine Cardon, in qualità di esperto accorso sul posto, parlando con Franceinfo ha fornito dettagli sul crollo che dovrebbe essere strutturale: “Abbiamo osservato che un pavimento era stato indebolito dall’acqua infiltrata da un balcone. L’infiltrazione ha portato al deterioramento del pavimento, che ha causato una reazione a catena di crolli su tutto il piano”. Oltre all’intero edificio, di sei piani, sono stati evacuate le due strutture adiacenti. I residenti hanno fatto rientro nelle loro abitazioni durante la notte, verso le ore 04:00.
La procura di Parigi ha aperto un’indagine sulle cause delle lesioni e del crollo e sono in corso aggiornamenti. All’interno dell’edificio era in corso una festa, come racconta uno degli invitati a LCL: “Eravamo tutti riuniti per festeggiare il 60esimo compleanno di un’amica. Proprio mentre stavamo iniziando a farle gli auguri ed eravamo tutti riuniti intorno a lei, il pavimento è crollato. Siamo caduti dal quinto al quarto piano. È successo così velocemente che non riesco nemmeno a descriverlo, ti senti solo scivolare“.
FOTO DI ARCHIVIO
L'articolo Pavimento crolla durante la festa di compleanno a Parigi: evacuati tre edifici e almeno 20 feriti proviene da Il Fatto Quotidiano.
“Ci ho messo un po’ a decidere di girare questo video in cui spiego le ragioni per cui voterò no”. Inizia così l’intervento con cui Alessandro Barbero spiega pubblicamente le ragioni del suo voto no al referendum sulla separazione delle carriere. Sono 4 minuti e mezzo di video, inviato dallo storico al Comitato “Società civile per il no”, guidato da Giovanni Bachelet, che lo ha pubblicato sul suo canale Youtube. Barbero mette in fila i motivi che lo hanno spinto a schierarsi contro la riforma del ministro Carlo Nordio. Parte da un elemento: “Il referendum non è sulla separazione delle carriere fra pubblici ministeri e giudic. La separazione di fatto c’è già. Già adesso il magistrato che prende servizio decide in quale dei due ruoli lavorare e può cambiare una sola volta nella vita e pochissimi lo fanno”, spiega lo storico, riferendosi al fatto che oggi i passaggi di ruolo tra pm e giudici avvengano con percentuali da prefisso telefonico (Nel 2023 8giudici su 6.665, lo 0,12%, diventati pm. Ventisei pm su 2.186, l’1,19%, diventati giudici).
E infatti il cuore della questione, dice il professore, è un altro. Al centro della riforma “c’è la distruzione del Consiglio superiore della magistratura, così come era stato voluto dall’assemblea Costituente. E allora spieghiamoci: il Csm è l’organo di autogoverno dei magistrati con funzioni anche disciplinari, cioè fa qualcosa che prima sotto il regime fascista faceva il ministro della Giustizia. Quindi, era il governo, cioè la politica, che sorvegliava la magistratura e che nel caso la sanzionava”. Con il suo inconfondibile tono, reso celebre da centinaia di puntate di podcast storici, Barbero improvvisa una lezione di storia costituente: “I padri costituenti vedevano benissimo che la separazione dei poteri è una garanzia indispensabile di democrazia, che il cittadino non è sicuro se si trova davanti inquirenti e giudici che prendono ordini dal governo e che possono essere puniti dal governo. Per questo la Costituzione prevede che il Csm sia composto per due terzi da magistrati ordinari eletti dai colleghi e per un terzo da professori di giurisprudenza e avvocati di grande esperienza, i cosiddetti membri laici eletti dal Parlamento”. Il Csm, dunque, “è la garanzia che la magistratura sarà sì in contatto col potere politico, ascolterà le ragioni del governo, ma sarà libera nelle sue scelte, non dovrà obbedire agli ordini”.
Se passerà il Sì, avverte Barbero, la riforma indebolirà il Csm con il rischio di una deriva autoritaria. “Intanto perché prevede che sia sdoppiato, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, e che al di sopra dei Csm ci sia un altro organo disciplinare separato, anch’esso composto da rappresentanti dei magistrati e da membri di nomina politica. Ma soprattutto la riforma prevede che in tutti questi organi i membri togati, cioè quelli che rappresentano i magistrati e che finora erano eletti dai colleghi, siano tirati a sorte. La giustificazione di questa misura pazzesca che non si usa in nessun organo di grande responsabilità, è che la magistratura e politicizzata, cosa considerata orribile, e che quando vota la magistratura elegge i rappresentanti delle sue diverse correnti e questo si vorrebbe evitarlo”. Il vero nodo, dunque, è rappresentato dal sorteggio ibrido: puro per i componenti togati dei Csm, cioè i rappresentanti dei magistrati, temperato per i laici, gli esponenti della politica, che saranno sorteggiati sulla base di un elenco compilato dal Parlamento. Solo che di questa lista non si è ancora specificata la consistenza numerica, che potrà essere di poco superiore (o addirittura identica) al numero di posti da coprire. Di fatto quindi la politica – a differenza della magistratura – continuerà a scegliere in qualche modo i propri rappresentanti al Consiglio superiore. Dunque avremo due Csm “dove i membri magistrati sono tirati a sorte mentre il governo continua a scegliere quelli che nomina lui“, sintetizza Barbero. “A me sembra che questi organismi saranno per forza di cose organismi dove il peso della componente politica sarà molto superiore. Dove di fatto il governo potrà di nuovo, come in uno stato autoritario, dare ordini ai magistrati e minacciarli di sanzioni. Ora, naturalmente, chi è favorevole alla riforma può benissimo dire, come infatti molti dicono, che va bene così. È proprio questo che vogliamo. Uno stato moderno ed efficiente deve funzionare così. Io la penso diversamente e per questo voterò no. E alla fine ho deciso che poteva aver senso che provassi a spiegare pubblicamente le ragioni per cui lo farò”.
L'articolo Referendum, Alessandro Barbero spiega perché voterà No: “Si rischiano magistrati agli ordini del governo. Peso della politica superiore nei Csm” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mentre la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, arrivava a Mascate per una visita ufficiale, la capitale omanita accoglieva con una cerimonia solenne anche l’INSV Kaundinya, al termine di uno storico viaggio di 18 giorni dal Gujarat all’Oman. Due arrivi paralleli, due traiettorie diverse — una politica, l’altra marittima — che si sono incrociate nello stesso luogo e nello stesso momento, proiettando sull’Oceano Indiano una narrazione che unisce passato e futuro, memoria e strategia.
L’India guarda all’Indo-Mediterraneo e a rotte come il Corridoio Economico India–Medio Oriente–Europa non soltanto attraverso infrastrutture moderne e corsie di navigazione contemporanee. Esiste anche una dimensione culturale e simbolica che affonda le radici nella storia antica e contribuisce a dare profondità strategica alle scelte del presente. L’INSV Kaundinya si colloca esattamente in questo spazio: non una semplice unità navale, ma una ricostruzione vivente della tradizione marinara indiana.
Ispirata alle navi a fasciame cucito raffigurate nei murali del V secolo delle grotte di Ajanta, l’imbarcazione è stata concepita come un ponte tra l’India contemporanea e il suo passato oceanico, ben precedente all’era dei motori e degli scafi in acciaio. A promuovere il progetto è stato Sanjeev Sanyal, economista e storico, oggi membro del Consiglio Economico Consultivo del Primo Ministro, con l’obiettivo dichiarato di restituire visibilità a una civiltà marittima spesso sottovalutata nella narrazione globale.
A differenza delle navi moderne, l’INSV Kaundinya è stata costruita senza l’impiego di chiodi o componenti metallici. Le tavole di legno sono state cucite a mano con corde di fibra naturale di cocco e sigillate con resine organiche, seguendo tecniche tradizionali tramandate nei secoli e ancora vive in alcune aree costiere dell’India, in particolare nel Kerala. Un sapere artigianale antico, integrato con competenze ingegneristiche moderne, che restituisce un’idea di continuità più che di nostalgia.
Il progetto è nato da una collaborazione tripartita tra il Ministero della Cultura indiano, la Marina e il cantiere navale di Goa Hodi Innovations (OPC) Pvt Ltd. La posa della chiglia nel settembre 2023 ha dato avvio a quasi due anni di lavoro, resi ancora più complessi dall’assenza di progetti tecnici originali. Il team ha dovuto affidarsi a fonti iconografiche, testi storici e test idrodinamici condotti presso l’IIT di Madras per garantire la navigabilità oceanica dell’imbarcazione.
Dopo il varo nel febbraio 2025, la nave è stata ufficialmente incorporata nella Marina indiana il 21 maggio 2025 presso la base di Karwar, nel Karnataka. Il nome Kaundinya richiama l’antico navigatore che, secondo la tradizione, avrebbe raggiunto il Sud-Est asiatico creando legami culturali duraturi: un riferimento che rafforza il messaggio di lungo periodo insito nell’intera iniziativa.
Il primo viaggio internazionale ha preso il via il 29 dicembre 2025 da Porbandar, in Gujarat, con destinazione Mascate. Una rotta che ricalca gli antichi itinerari commerciali tra il subcontinente indiano e la Penisola Arabica, molto prima che la navigazione coloniale ridefinisse i flussi globali. Porbandar è anche la città natale di Mohandas Karamchand Gandhi, ulteriore elemento simbolico in un percorso che intreccia storia, identità e diplomazia.
Durante la traversata del Mar Arabico, Sanyal ha condiviso aggiornamenti regolari sui social, raccontando i ritmi lenti della navigazione a vela, l’influenza dei venti e le sfide quotidiane di una traversata che riecheggia le esperienze dei marinai di oltre duemila anni fa. In uno dei passaggi più evocativi, ha descritto l’avvistamento lontano di una moderna portaerei: un contrasto che rende visibile, nello stesso orizzonte, la stratificazione del potere marittimo nel tempo.
L’approdo a Mascate, inaugurato ufficialmente alla presenza delle autorità locali e diplomatiche, ha assunto così un valore che va oltre la celebrazione storica. L’Oman è da secoli un nodo centrale delle reti dell’Oceano Indiano e oggi si conferma spazio di incontro tra diplomazia, commercio e sicurezza marittima. In questo contesto, la concomitante visita di Giorgia Meloni ha aggiunto una dimensione ulteriore.
Se la Kaundinya rappresenta la storia millenaria dell’India come civiltà marittima, Meloni incarna il futuro dell’Italia: prima donna a guidare il Paese come Presidente del Consiglio, ha riportato Roma a rivendicare un ruolo più assertivo in Europa e nel Mediterraneo allargato, con uno sguardo crescente verso l’Indo-Pacifico. In Oman, India e Italia si sono ritrovate simbolicamente riunite come due pilastri complementari dell’Indo-Mediterraneo, uno spazio che non è più soltanto geografico, ma strategico.
Questa convergenza non è frutto di una coreografia studiata, ma di una serendipità significativa. In un momento di forte instabilità globale, il viaggio della Kaundinya ricorda che i mari — un tempo ponti di scambio e connessione — continuano a modellare le relazioni internazionali. Tra memoria storica e proiezione strategica, l’Indo-Mediterraneo torna così a raccontare una storia antica, ma sorprendentemente attuale.
(Foto: X, @sanjeevsanal)

Come nel resto del mondo anche l’Italia è stata colta di sorpresa dall’invasione russa del febbraio 2022, ma rispetto ad altri paesi ha seguito un percorso più lungo per elaborare una strategia sull’Ucraina, anche perché sei mesi dopo lo scoppio del conflitto, ci sono state le elezioni politiche con il passaggio di governo da Mario Draghi a Giorgia Meloni.
La definizione di una strategia nazionale italiana per l’Ucraina è stata complessa anche per ragioni storiche. Francia e Germania erano state coinvolte direttamente fin dal 2014 nei negoziati di pace tra Russia e Ucraina, a seguito dell’occupazione militare russa della Crimea e del Donbas,attraverso il “Normandy Format”, cioè un tavolo a 4 con i due contendenti. Questo significa che sia a Parigi che a Berlino(come naturalmente a Washington) c’era già un “dossier Ucraina” sul tavolo con risorse diplomatiche dedicate. Altri paesi come il Regno Unito, i Paesi scandinavi e quelli Baltici hanno adottato subito una posizione di sostegno aperto all’Ucraina, perché storicamente più sensibili e preoccupatidall’aggressività militare russa fin dalla nascita dell’Unione Sovietica.
A differenza di oggi, l’Ucraina non era una priorità per la politica estera italiana. Kiev è sempre stata per i diplomatici italiani una destinazione meno prestigiosa e con meno risorse rispetto a Mosca, che era molto importante anche per l’export delle aziende italiane. Questo ha creato un dissidio interioremolto rilevante per la politica estera italiana, perché la scelta di sostenere attivamente l’indipendenza dell’Ucraina ha comportato il deterioramento della lunga relazione amichevole con la Russia.
Come spesso succede, ci sono dei fattori esterni che fungono da catalizzatori del cambiamento. E questi furono uno stranoinciampo diplomatico a Lugano e un attacco drammatico aOdessa.
Agli inizi di luglio 2022, pochi giorni prima delle dimissioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi, si tenne la conferenza di Lugano per la ricostruzione dell’Ucraina, con l’illusione che la guerra sarebbe finita presto. A questo incontro il Primo Ministro ucraino Denis Shmigal presentò al pubblico di esperti internazionali una grande mappa con le regioni e le grandi città dell’Ucraina contrassegnate da bandierine dei paesi che avrebbero dovuto prendersi la responsabilità dei progetti nei vari territori. Praticamente, era una proposta di lottizzazione della ricostruzione in base agli interessi nazionali.
La cosa che lasciò gli addetti ai lavori italiani a bocca aperta fu l’assegnazione all’Italia di Rivne, una piccola città vicino al confine con la Bielorussia, e di Donetsk, nel Donbas. Se non era chiaro quale potesse essere l’interesse dell’Italia per Rivne, per Donetsk si trattava di un’ipotesi del tutto irreale, data l’occupazione russa dal 2014. Sulle città più importanticome Kiev, Odessa, Dnipro, Leopoli, Zaporizhzja e Karkhiv, sventolavano altre bandiere nazionali. Curiosamente, su Odessa, città nota per il legame con l’Italia, c’erano labandierina svizzera e quella francese.
Questa concessione all’Italia delle ultime caselle vuote e, in particolare, di una città non disponibile, era il segno di una scarsa considerazione del ruolo economico e diplomatico dell’Italia, e della priorità data agli altri Paesi (USA, UK, Germania, Francia, Svizzera, Canada, Polonia e Turchia). La poco esperta diplomazia ucraina aveva elaborato uno strumento di indirizzo non privo di stimoli intellettuali, ma senza un vero approfondimento preliminare con tutti i paesicoinvolti.
Ma la mancata attribuzione di Odessa all’Italia, era piuttostoimbarazzante, se si tiene conto non solo del legame storico-culturale, ma anche delle eccellenze italiane in settori come la cantieristica, la logistica marittima e le infrastrutture portuali, che non erano state considerate dal piano ucraino.
Per sanare questo schiaffo diplomatico si mosse l’ambasciatore a Kiev Pierfrancesco Zazo, che si era guadagnato l’ammirazione degli ucraini per essere stato l’ultimo capo diplomatico europeo ad abbandonare una Kiev semicircondata dai Russi. Inoltre, nell’aprile 2022, fu uno dei primi a riaprire un’ambasciata nella capitale ucraina. Fu lui a sensibilizzare il Governo ucraino sulle grandi opportunità che offriva una partnership italo-ucraina con perno sulla città di Odessa. Nel 2023, a sottolineare questo legame tra il porto del Mar Nero e l’Italia, fu inaugurata la sede del nuovo Console onorario italiano. Era dalla Seconda Guerra Mondiale che mancava un consolato dell’Italia a Odessa.
Il secondo fatto catalizzatore avvenne il 23 luglio del 2023: l’attacco missilistico notturno alla Cattedrale ortodossa della Trasfigurazione di Odessa, che distrusse il tetto e gli internidell’edificio. A poche ore dall’evento che traumatizzò tutta la città, sia il Presidente del Consiglio Meloni che il Ministro degli Esteri Tajani dichiararono che l’Italia si sarebbe occupata del restauro della chiesa. Curiosamente proprio quel giorno era in visita a Odessa una delegazione di Deputati italiani della Commissione Esteri della Camera, che furonotestimoni oculari delle macerie fumanti dopo l’attacco.
Da quella decisione del Governo italiano, nata da un moto di solidarietà, è partito un percorso che ha portato alla definizione di una strategia più strutturata sull’Ucraina. Nel settembre del 2023 ci fu a Odessa la prima visita dell’inviato speciale per l’Ucraina Davide La Cecilia, già ambasciatore a Kiev fino al 2020, insieme alla responsabile dell’UNESCO a Kiev Chiara Dezzi Bardeschi, e due esponenti della cultura italiana: il presidente del Museo MAXXI di Roma Alessandro Giuli (oggi Ministro italiano della Cultura) e il presidente del Museo La Triennale di Milano arch. Stefano Boeri.
Dal quel primo incontro partì il processo di definizione del piano che approdò l’11 giugno 2024 a Berlino alla firma del Memorandum sul “Patronage italiano per la ricostruzione di Odessa e della sua regione” tra il Ministro degli esteri Antonio Tajani e il Ministro ucraino per lo Sviluppo delle Infrastrutture Vasyl Shkurakov, alla presenza del sindaco diOdessa, Gennadiy Trukhanov. Qualche mese prima di quella firma era stato aperto l’ufficio a Kiev dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo (AICS), per coordinare gli aiuti umanitari in Ucraina e controllarne l’efficacia.
Il MoU delineava la nuova strategia italiana in Ucraina, che oltre agli aiuti militari, comprendeva un programma articolato di progetti umanitari, culturali e di sviluppo economicofocalizzati su Odessa e la sua regione. La finalità complessiva di questo piano era la creazione di un ecosistema favorevole agli investimenti italiani e alle partnership industriali per la ricostruzione nel dopoguerra.
Parallelamente a questo sviluppo della politica estera italiana, cresceva la relazione Italia-Ucraina, come testimoniato dalle crescenti visite a Roma di Zelensky per incontrare Giorgia Meloni, Sergio Mattarella e i due Papi Francesco e Leone XIV. Inoltre, se l’ex Ministro degli Esteri ucraino Kuleba aveva vissuto per anni in Italia, tuttora nell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina alcuni responsabili sono stati nell’ambasciata a Roma e sono esperti nelle relazioni diplomatiche con l’Italia.
L’Italia è divenuta per l’Ucraina un paese di riferimento stabile, in confronto alle continue crisi di governo in Francia, Germania e Regno Unito. Inoltre, le relazioni molto amichevoli tra il governo Meloni e la nuova amministrazione Trump offre all’Italia un ruolo di moderatore nelle difficili relazioni ucraino-americane. Inoltre, è importante notare che gli ambasciatori dei Paesi del G7 a Kiev svolgono un ruolo rilevante nel processo di riforme per modernizzare e stabilizzare l’Ucraina. Infatti hanno incontri regolari con i ministri ucraini e monitorano i provvedimenti legislativi con il diritto di parola. Un caso unico al mondo di influenza del G7, e quindi anche dell’Italia, in una crisi internazionale.
Dopo il mandato di Pierfrancesco Zazo, a luglio 2024 l’Italia ha nominato nel luglio 2024 a Kiev l’ambasciatore Carlo Formosa, un diplomatico con esperienza di servizio in paesi difficili come l’Iran e l’Afghanistan, e in passatovicepresidente del gruppo Leonardo, il cluster italiano della difesa. Una competenza utile per la partnership militare italiana con l’Ucraina.
La scelta di Odessa è stata ispirata da un riferimento storico-culturale. La città fu fondata nel 1794 dal comandante napoletano Josè de Ribas al servizio di Caterina La Grande, e gli immigrati italiani del Regno delle Due Sicilie furono la prima classe dirigente della città. Le maggiori realizzazioni architettoniche della città portano la firma di architetti italiani.
Ma la scelta della capitale marittima dell’Ucraina è spinta anche dagli interessi nazionali italiani. L’importanza di Odessa, obiettivo prioritario della strategia militare russa, è data da molte ragioni:
Economia. I 7 porti della regione di Odessa sono il cancello del 90% dell’export ucraino. Chi controlla Odessa ha il controllo dell’economia ucraina. L’Italia è un importatore di materiali ferrosi e candidata a diventare la prima porta d’ingresso per l’export dell’acciaio “verde” ucraino. Inoltre ci sono diversi settori italiani che dipendono dalle importazioni di derrate alimentari ucraine. Durante il blocco navale russo dei porti ucraini nel 2022, il settore dell’allevamento (zootecnia) fu colpito duramente dalla mancanza di mais ucraino usato nell’alimentazione degli animali, come l’arresto delle importazioni di grano dall’Ucraina penalizzò i produttoridi pasta italiana.
Cultura. Odessa è la città ucraina più famosa al mondo grazie al cinema, alla letteratura, alla musica e all’arte contemporanea. La parola “Odessa” è un potente brand usato nel design e nel marketing industriale. Tra tutte le città ucraine Odessa è un palcoscenico di grande visibilità internazionale.
Politica. Dalla sua fondazione Odessa è la città della tolleranza culturale e linguistica. Rappresenta il modello multiculturale di sviluppo dell’Ucraina, contrapposto al modello nazionalistico mono-linguistico. Il luogo ideale del dialogo per la ricostruzione non solo fisica, ma anche morale del Paese.
Sicurezza. La proiezione militare ucraina sul mare per proteggere il traffico maritimo ha reso Odessa il guardiano del Mar Nero, obliterando il ruolo Sebastopoli, che è stata abbandonata dalla flotta russa. La città è oggi il laboratorio più avanzato al mondo di nuove tecnologie militari navali.
Carriera marittima e arte militare: grazie a Odessa l’Ucraina impara a navigare e a combattere. Le sue accademie navali formano la più alta percentuale al mondo di ufficiali di marina mercantile di etnia europea. Inoltre, alla scuola militare di Odessa si sono diplomati in generali Zaluzhny e Budanov.
“L’Italia ha scelto di occuparsi di alcuni dei simboli dei luoghi che compongono il mosaico identitario della Nazione ucraina: quel luogo è Odessa”. Così disse Giorgia Meloni all’apertura della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina. Per l’Italia la diplomazia culturale e della cooperazione non profit svolge un ruolo importante per aprire la strada alle imprese nazionali. In effetti, alcuni campioni industriali nazionali presero parte al gioco.
Durante la URC2025 a Roma la Fincantieri, il più grande gruppo europeo di cantieristica navale, annunciò un progetto pilota per la difesa del porto di Odessa con tecnologie innovative, sia di superficie che subacquee. Un progetto in linea con l’importanza della città nella sicurezza del Mar Neroe con le ambizioni industriali navali dell’Italia. È utile menzionare che proprio nel gennaio del 2025, Fincantieri aveva acquisito dal gruppo Leonardo la società UAS Underwater Business per la protezione di infrastrutture portuali da sottomarini, droni navali e siluri.
Il più grande costruttore italiano Webuild, firmò tre accordi: 1) 2 miliardi con Automagistral, azienda di Odessa specializzata nella costruzione di strade; 2) 600 milioni con l’azienda Ukrhydroenergo per produzione di energia; 3)cooperazione con l’Agenzia ucraina per la ricostruzione e le infrastrutture.
Ma l’Italia arriva in una piazza già in parte occupata da altri investimenti esteri, che si concentrano in prossimità dei suoi maggiori porti (Odessa, Chornomorsk e Yuzhny). Ecco i paesi protagonisti:
Germania. Il più grande investimento infrastrutturale tedescoin Ucraina è il CTO-Container Terminal Odessa, del gruppo HHLA, il principale operatore portuale tedesco, la cui azionista di maggioranza è il Comune di Amburgo. HHLA ha anche un terminal nei porti di Tallinn e Trieste.
Dubai. Il campione della logistica portuale degli Emirati Arabi Uniti (Dubai) DP World controlla TIS Group, il maggiore operatore privato del primo porto dell’Ucraina, Yuzhny (a nord di Odessa).
Usa. Il maggiore investimento logistico statunitense (150 milioni di dollari) è il Neptune Grain Terminal del gruppoCargill di Minneapolis, completato nel 2018 dentro il porto di Yuzhny.
Cina. Uno dei primi partner commerciali dell’Ucraina. Primoimportatore di mais e orzo ucraino (20% dell’esportazione totale nel 2021) e il secondo di olio di girasole (15%), dopo l’India (30%). È anche il principale esportatore in Ucraina di prodotti di largo consumo (USD 8,25 miliardi nel 2020).
Svizzera. La Confederazione elvetica vanta in Odessa la presenza di due grandi aziende: Risoil S.A., holding agroindustriale e principale operatore del porto di Chornomorsk; e la Mediterranean Shipping Company (MSCS.A.), la più grande compagnia di shipping al mondo. Le due società hanno sede legale a Ginevra (anche se in entrambe i capitali non sono svizzeri).
Italia: il maggiore investimento italiano diretto è l’azienda di comunicazione unificata Wildix, anche se la sopra menzionata MSC appartiene alla famiglia napoletana Aponte.
Singapore. Il principale investimento diretto della città-stato asiatica è Delta Wilmar Group, una società ucraina parte della multinazionale agroindustriale Wilmar International. Il gruppo comprende due stabilimenti nella regione di Odessa per la lavorazione di semi oleosi e oli tropicali.
Paesi Bassi. La Louis Dreyfus Company (LDC) possiede un grande terminal nel porto storico di Odessa. L’antica holding mercantile francese, che si occupa di agricoltura, finanza,trasformazione alimentare e spedizioni internazionali, ha sede ad Amsterdam e un ufficio operativo a Rotterdam. Inoltre, la Dutch Entrepreneurial Development Bank (controllata al 51% dallo Stato olandese) ha una quota nella Alseeds Black Sea, uno dei più grandi esportatori privati di olio di girasole in Ucraina, che gestisce un nuovissimo terminal di carico di olio vegetale nel porto Yuzhny.
La strategia elaborata dall’Italia sull’Ucraina mostra un cambiamento rispetto alle consuetudini della sua politica estera. Innanzitutto, non ha paura di esplicitare gli interessi nazionali, mobilitando grandi aziende. Questo nuovo stile della diplomazia italiana è coerente con il nuovo “Piano d’azione per l’export italiano nei mercati extra-Ue” varato a maggio 2025. L’Ucraina rientra in questa categoria.
In secondo luogo, la scelta di un territorio come la città/regione di Odessa, rappresenta qualcosa di nuovo, dai tempi lontani in cui le potenze europee prendevano in concessione città in altri paesi (come Tientsin in Cina per l’Italia). L’aspetto interessante è che Odessa, per la sua posizione geografica e il suo ambiente economico-sociale, offre alla diplomazia dei progetti culturali e degli aiuti umanitari, combinata con gli interessi nazionali, le condizioni ideali per gli obiettivi strategici dell’Italia.
Prima la visita di Giorgia Meloni al cimitero di Seul che onora i soldati caduti per la Nazione, in particolare durante la Guerra di Corea. Poi un punto stampa sul tema della Groenlandia e quindi l’incontro con le imprese italiane, in attesa del bilaterale con il presidente Lee Jae Myung. Dopo 19 anni un premier italiano torna a Seoul, a dimostrazione di una spiccata attenzione verso l’Indopacifico, per una serie di ragioni geopolitiche, economiche, commerciali (e anche personali).
Non è una novità il fatto che Giappone e Corea del Sud nelle logiche di Palazzo Chigi siano visti come due attori non solo affidabili, ma con cui rafforzare il livello delle relazioni di medio-lungo periodo. Si tratta ovviamente di un fazzoletto di mondo gravido di sfide e opportunità: accanto al macro tema geopolitica rappresentato dalle mire cinesi su Taiwan, spicca il link tra Mare Cinese e Mediterraneo e la questione delle terre rare accanto a chip e semiconduttori. Un paniere di temi altamente strategici che il capo del governo intende affrontare di petto, a maggior ragione dopo l’uscita dell’Italia dalla Via della Seta, senza dimenticare un elemento di supporto oggettivo: le società giapponesi e sudcoreane presentano numerose affinità con l’Italia sotto molteplici punti di vista (economici, commerciali e demografici), oltre a condividere i medesimi valori.
LO SHOWROOM HIGH STREET ITALIA
Il made in Italy a quelle latitudini è particolarmente apprezzato, ciò si trasforma in potenziali nuove opportunità legate al nostro export che può contare su questo valore aggiunto rispetto alla produzione di altri paesi. Le filiere interessate sono la moda, la pelletteria, il calzaturiero, il settore alimentare e vitivinicolo, senza dimenticare l’interior design. A proposito di prodotti e fiere, a Seoul nel 2019 ha visto la luce l’High Street Italia, uno showroom di quattro piani aperto in una delle zone più frequentate dello shopping della capitale, nella Garosu-gil, che rappresenta una vetrina per le aziende italiane che qui possono presentare la vasta gamma dei propri prodotti al mercato coreano. Realizzato dall’ICE col supporto del Ministero dello Sviluppo Economico e in collaborazione con l’ambasciata d’Italia, l’iniziativa rientra nel piano più generale della promozione straordinaria del Made in Italy nella Corea del Sud, che include anche della diffusione di cultura e lifestyle italiani
Le relazioni tra Roma e Seoul sono iniziate nel 1884 e hanno visto da poco il 140° anniversario, celebrato con un Anno dello Scambio Culturale. A tal fine infatti lo scorso 26 giugno l’ambasciata in Italia della Corea del Sud ha illuminato il Colosseo per celebrare le relazioni diplomatiche con Italia.
IL RUOLO DELLA COREA DEL SUD
Oltre a essere un player mondiale nel campo dell’innovazione tecnologica, la Corea è famosa in tutto il mondo anche per la cultura popolare legata a videogiochi, gruppi musicali e film. Settori spesso sottovalutati ma che possono contribuire, in nome della soft diplomacy, a rafforzare intese e cooperazioni. Cultura, conoscenza e qualità sono i tratti in comune tra i due paesi. La Corea del Sud incamera l’1% dell’export italiano per un valore di oltre 5 miliardi di euro, è il terzo mercato in Asia.
Corea del Sud fa rima con semiconduttori, per questa ragione il governo pensa di fare un ulteriore passo in avanti con la costruzione di una fonderia da 3 miliardi di dollari per incrementare la produzione e quindi confermare la propria posizione di leader globale nel settore dei chip grazie a marchi come Samsung Electronics e SK Hynix.
(Foto: Governo.it)
“L’Italia è perfettamente consapevole di quanto questa regione del mondo rappresenti un quadrante strategico negli equilibri globali, e intende continuare a fare la propria parte per preservare l’Artico come area di pace, cooperazione e prosperità”. Questo il punto centrale del messaggio inviato dalla premier Giorgia Meloni alla conferenza di presentazione del documento dedicato alla Politica Artica Italiana in cui si indicano le linee strategiche che il nostro Paese intende seguire, come osservatore nel Consiglio Artico, sostenitore del diritto internazionale del mare e membro della Ue e della Nato.
La posizione italiana ha radici antiche che risalgono alle missioni di esplorazione scientifica del secolo scorso ed all’adesione al Trattato delle Svalbard. L’accordo del 1920 contiene infatti clausole che, nel riconoscere la sovranità della Norvegia, stabiliscono il suo impegno a preservare l’ambiente naturale, non installare basi navali e fortificazioni, favorire la ricerca scientifica, consentire la presenza delle Parti contraenti.
Il regime di smilitarizzazione delle Svalbard è ritornato di attualità ora che la Russia ne pretende il rispetto. Esso va però inteso nella sua giusta accezione: non rinuncia ad esercitare difesa e deterrenza nell’Arcipelago da parte della Norvegia (e della Nato) ma impegno a non farne un uso offensivo. Questa è proprio la chiave per comprendere il senso della politica italiana che considera l’Artico “regione strategica, dove si intrecciano economia, ambiente, ricerca, energia e – oggi più che mai – sicurezza e difesa”. Ma l’aderenza della visione del nostro Paese alla realtà del Grande Nord è confermato da altri elementi.
Mentre per il territorio antartico esiste uno specifico trattato che ne stabilisce l’uso per fini pacifici proibendo appropriazioni di aree, installazioni e manovre militari, l’Artico non è governato da alcuno specifico accordo. Ad esso, si applica infatti l’ordinario diritto del mare come specifica la Dichiarazione di Ilulissat (Groenlandia) del 2008: il testo esprime la visione dei Paesi fondatori del Consiglio Artico, Canada, Danimarca, Norvegia, Russia e Stati Uniti (da notare che la Cina strumentalmente si definisce “Near-Arctic State”).
Nell’Oceano Artico gli Stati costieri sono quindi titolari di diritti nelle aree di piattaforma continentale e Zee come accade in altri regioni marine; sotto i ghiacci del Polo ci sono invece spazi di mare libero. I Paesi artici e quelli come l’Italia che hanno lo status di “osservatori” nel Consiglio si sono tuttavia impegnati a cooperare tra loro per la protezione del fragile ecosistema marino.
Ecco quindi che considerare l’Artico una zona di pace è un’esigenza connessa alla tutela degli habitat, ad evitare i rischi di inquinamento della navigazione commerciale e dello sfruttamento incontrollato delle risorse. Questo, in linea con la Convenzione del diritto del mare del 1982 che stabilisce l’uso pacifico dei mari come bene comune.
Non a caso l’Italia vede nella Norvegia il suo partner ideale per realizzare la sua strategia (come dichiarato anche da Eni): Oslo interpreta infatti al meglio i principi di cooperazione pacifica nel campo ambientale, scientifico ed economico che dovrebbero garantire la tutela degli spazi artici.
Ma che dire della Russia che sin dal tempo degli Zar considera l’Artico uno spazio che le appartiene sino al Polo come prolungamento delle terre emerse? E come non temere la sua massiccia militarizzazione delle coste e dei mari adiacenti o il controllo navale della Rotta a Nord Est (ora Northern Sea Route) che attraversa la sua Zee? Naturale quindi che Il sostegno italiano alla presenza della Nato nell’Artico vada visto come misura per “prevenire tensioni, preservare la stabilità e rispondere alle ingerenze di altri attori”.
La minaccia militare russa nell’Artico è una realtà incontestabile, non foss’altro perché Mosca deve difendere nel Circolo Polare Artico un enorme sviluppo costiero di circa 25.000 km. con risorse naturali ricchissime. È bene ricordare che nel momento in cui l’ex Urss si stava dissolvendo, Gorbashev lanciò nel 1987, con la Murmansk Initiative, una serie di proposte per fare dell’Artico una zona denuclearizzata e demilitarizzata. Non si trattava però di un piano di pace. A Mosca interessava soltanto allontanare dalle regioni polari le Forze occidentali sì da farne un proprio mare chiuso.
Con lo scioglimento dei ghiacci le zone polari si stanno ora aprendo alla navigazione internazionale ed alla competizione energetica: tra non molto sarà inevitabile per l’Occidente confrontarsi con la Russia per l’uso pacifico e condiviso dell’Artico.
Comunicazioni domenicali del Presidente di DSP Francesco Toscano. “Vi aspetto a Roma Sabato 31 Gennaio e Domenica 1 Febbraio- hotel Ergife- per il grande Congresso nazionale di Demicrazia Sovrana e Popolare
L'articolo Basta UE, Nato e globalismo proviene da Visione TV.
Pragmatismo è, anche o soprattutto, capire i tempi della politica e delle crisi in atto. Quando Giorgia Meloni da Seoul dice che solo senza escalation si va (tutti) a dama in Groenlandia, chiede in primis di abbassare i toni, avviare una discussione “tra di noi” e usare il “luogo” della Nato al fine di lavorare insieme per rispondere a una preoccupazione che “ci coinvolge tutti”. Ovvero che attori ostili possano avere la meglio su un interesse comune.
In questo senso va letta, secondo la presidente del Consiglio, la volontà di alcuni Paesi europei di essere parte attiva all’interno di un progetto che miri ad una maggiore sicurezza in Artico, anche con l’invio di truppe. Inoltre dice chiaramente ciò che pensa sui dazi (“un errore”). Ma su questo secondo elemento secondo Meloni c’è stato un problema di comprensione e di comunicazione. Per cui il primo messaggio che giunge dalla Corea del Sud è fermare tutte quelle azioni che potrebbero innescare un quadro di altissima tensione e, piuttosto, avviare un dialogo costruttivo per meglio comprendere i parametri di analisi e di azioni. Il tutto tenendo ben presente un passaggio che, secondo Meloni, è nevralgico: da parte americana c’è la preoccupazione per l’eccessiva ingerenza esterna su una zona strategica e, al contempo, da parte europea vi è la volontà di contribuire ad affrontare questo problema. Per cui, è il sunto dell’analisi, si può e si deve trovare un punto di incontro tra Ue e Usa.
Un problema che investe, gioco forza, i destini europei per una serie di ragioni geopolitiche come emerso due giorni fa dalla presentazione da parte del governo di Roma del corposo documento programmatico sull’Artico, che vuole definire un percorso progettuale tramite il rafforzamento dell’impegno italiano nella regione. Sull’ipotesi di una possibile partecipazione militare italiana come segnale di unità con gli europei alla missione nell’isola Meloni fuga ogni dubbio: “Ora è prematuro parlarne perché sto lavorando per cercare di abbassare la tensione e di tornare al dialogo”.
Per questa ragione la premier ha parlato al telefono con Donald Trump (“al quale ho detto quello che penso”) e ho con il segretario generale della Nato (“che mi conferma un lavoro che l’Alleanza Atlantica sta iniziando a fare da questo punto di vista”). Ma non finisce qui, dal momento che ci sarà anche un contatto tra leader europei in occasione di una riunione a livello di Coreper dell’Unione europea. C’è anche spazio per una precisazione a uso interno quando Meloni spiega per l’ennesima volta che non c’è un problema politico con la Lega sui nuovi dazi annunciati da Trump contro i Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia.
Meloni cita la postura del premier finlandese, Alexander Stubb, che ha specificato come tra alleati serva dialogo e non pressioni. Il riferimento è alla necessità di un’azione coordinata dagli alleati al fine di ribadire “i principi dell’integrità territoriale e della sovranità”. La costante del ragionamento di Meloni tocca un caposaldo della strategia euro-atlantica, ovvero il ruolo della Nato: è solo quello “il luogo nel quale noi dobbiamo cercare di organizzare insieme strumenti di deterrenza verso ingerenze che possono essere ostili”. Il fatto che la Nato abbia cominciato a lavorare in tale direzione è certamente una buona notizia.

“Ho sentito il presidente americano Donald Trump ed ho espresso le mie perplessità”, dice questa mattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un momento di particolare tensione nelle relazioni tra Stati Uniti ed Europa attorno al dossier “Groenlandia”. Il messaggio, che arriva dalla Corea del Sud, chiede di evitare l’escalation abbassando i toni. Un lavora che l’Italia sta cercando di spingere anche in sede Ue.
La convocazione di una riunione straordinaria degli ambasciatori dell’Unione Europea nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 18 gennaio, per valutare una risposta coordinata all’annuncio statunitense di nuove tariffe contro alcuni Paesi membri, segna l’ingresso della crisi sulla Groenlandia in una nuova fase. Non più soltanto uno scontro retorico o una disputa diplomatica, ma un dossier che incrocia commercio, sicurezza economico (e non solo) e coesione transatlantica, costringendo Bruxelles a una risposta “intelligente, coordinata e possibilmente non ulteriormente incendiaria” a Washington, dice una fonte dai corridoio europei.
Il detonatore è stato l’annuncio di Trump, che sabato ha fatto sapere che nuovi dazi colpiranno una serie di Paesi alleati – tra cui Francia, Germania, Danimarca e Regno Unito – accusati di aver rafforzato la propria presenza militare in Groenlandia come forma di deterrenza contro gli Stati Uniti. Una misura che riapre una frattura commerciale che l’Europa riteneva superata dopo la tornata di dazi di inizio presidenza, e che collega esplicitamente il terreno economico a quello strategico, nel momento in cui l’Artico torna a essere uno spazio di competizione crescente e la Groenlandia gioca un ruolo per l’asse transatlantico e per il Western Hemisphere che Trump intende proteggere come missione identitaria della “sua” National Security Strategy.
Da Bruxelles, il presidente del Consiglio europeo, António Costa, ha parlato della necessità di una risposta comune, ribadendo che l’Unione europea difenderà il diritto internazionale e l’integrità territoriale dei suoi Stati membri – nel caso la Danimarca, che p sovrana sulla Groenlandia. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha avvertito che una spirale tariffaria rischia di danneggiare la prosperità condivisa e di indebolire il fronte occidentale, messaggio arrivato anche della Hr/Vp Kaja Kallas, che ha citato esplicitamente Cina e Russia come i favoriti dalle divisioni transatlantiche. Diversi leader europei hanno sottolineato come la sicurezza della Groenlandia possa e debba essere affrontata all’interno dei meccanismi Nato, che racchiude sia gli Usa che diversi Paesi europei.
Il dato politico, tuttavia, va oltre la contingenza. La riunione degli ambasciatori segnala che la questione groenlandese non è più un tema periferico, ma un banco di prova per la capacità dell’Occidente di gestire divergenze strategiche senza trasformarle in crisi sistemiche. È su questo crinale – tra deterrenza, dialogo e interessi divergenti – che si gioca ora la partita più delicata.
Sul piano analitico, la narrativa che giustifica un cambio di status dell’isola regge poco. Come ha osservato Richard Fontaine, Ceo del Anas, la Groenlandia non è un dossier intrinsecamente complesso: lo diventa solo se lo si carica di obiettivi che esulano dalla realtà dei fatti. Gli Stati Uniti dispongono già, grazie agli accordi con la Danimarca, di ampi margini operativi in termini di basi, tra radar e presenza militare di ogni possibile genere. La difesa dell’Artico e il monitoraggio delle attività di Cina e Russia possono essere rafforzati senza bisogno di “possedere” il territorio, spiega l‘esperto americano. L’idea che la sicurezza richieda l’annessione statunitense, o che la deterrenza passi dall’invio simbolico di piccoli contingenti multinazionali come quelli europei, finisce per produrre l’effetto opposto: politicizzare e radicalizzare un dossier che potrebbe essere gestito in modo pragmatico.
Anche l’argomento secondo cui la Groenlandia rischierebbe di “cadere” sotto l’influenza di potenze rivali appare debole se non accompagnato da scelte coerenti. Secondo Fontaine, se davvero Mosca e Pechino rappresentassero una minaccia imminente, la risposta più lineare sarebbe rafforzare i dispositivi esistenti e il coordinamento Nato, non aprire un contenzioso politico con Copenaghen e con gli alleati europei. Le alleanze, ragiona, si fondano proprio sulla difesa reciproca di territori che non si possiedono: è questa la logica che ha retto l’ordine post-1945 e che continua a garantire stabilità.
Un’ulteriore chiave di lettura arriva dall’intervista pubblicata sabato dal Corriere della Sera con protagonista l’ex ambasciatrice statunitense in Danimarca Carla Sands. Sands, forte della sua esperienza diretta sul dossier groenlandese e attualmente nel team dell’America First Policy Institute, ha ricordato come l’interesse americano sia legato soprattutto alla sicurezza e alle risorse strategiche, non a una conquista formale. Le sue parole aiutano a distinguere tra l’obiettivo sostanziale – evitare che l’isola finisca sotto un’influenza ostile di Cina o Russia – e la retorica che rischia di irrigidire le posizioni. In questo senso, l’accento posto sul possibile percorso di lungo periodo verso una maggiore autonomia groenlandese suggerisce che il nodo non sia “a chi appartiene” il territorio, ma come garantirne stabilità e sviluppo senza forzature.
È in questo spazio che si inserisce la posizione italiana, improntata a responsabilità e controllo, con le perplessità espresse da Meloni. Durante la presentazione del Documento strategico sull’Artico, il 16 gennaio 2026, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha messo in guardia contro approcci frammentati e simbolici, osservando che l’idea di piccoli contingenti europei dispiegati sull’isola non somiglia a una strategia credibile. Il punto, ha sottolineato, è tenere unito il mondo occidentale e preservare il quadro di cooperazione. A posteriori, quelle parole suonano quasi profetiche: il giorno dopo, l’annuncio dei dazi americani contro quei contingenti ha mostrato quanto rapidamente una gestione muscolare possa produrre contraccolpi politici ed economici.
Il paradosso è che entrambe le strade estreme – l’idea di “conquistare” la Groenlandia e quella di usarla come palcoscenico per segnali di deterrenza – finiscono per alimentarsi a vicenda. Il rischio è che l’una legittimi l’altra, in una dinamica che favorisce solo gli attori interessati a dividere l’Occidente. Fonti diplomatiche spiegano che la via d’uscita è più sottile, ma anche più realistica: un dialogo strutturato che consenta a Washington di rivendicare un rafforzamento della sicurezza artica, e a Trump di ottenere “qualcosa che possa essere raccontato come una vittoria”, e all’Europa di mantenere lo status quo, garantendo al tempo stesso che l’isola resti saldamente ancorata allo spazio euro-atlantico.
In quest’ottica, il compromesso non è una resa, ma uno strumento politico. Permette a Trump di presentare un risultato tangibile al proprio elettorato – maggiore attenzione all’Artico, più investimenti in sicurezza, tagliare fuori i rivali dell’emisfero occidentale – e agli europei di evitare una deriva che metterebbe in discussione sovranità e alleanze cruciali come quella con gli Usa. La Groenlandia è strategica, e proprio per questo va sottratta alla logica della provocazione. Meno benzina sul fuoco, più diplomazia: è l’unico modo per spegnere una scintilla prima che diventi crisi.
Il rischio del confronto è anche racchiuso nel messaggio che emerge da alcuni recenti sondaggi, come quello di Ecfr. Gli scontri – verbali, postulali, pratici – legati alle posizioni complicate prese da Trump rischiano di allontanare le opinioni pubbliche europee dagli Stati Uniti, con un riflesso ancora più problematico: creare spazi dove la narrazione e la disinformazione cinese si nuove per piegare gli europei e altri alleati statunitense verso Pechino.
La politica estera è spesso complessa, stratificata, ambigua. La Groenlandia, no. È da questa premessa che parte Richard Fontaine, Ceo del Center for New American Security di Washington, analizzando punto per punto le argomentazioni circolate a Washington e Bruxelles sull’idea che gli Stati Uniti debbano prendere il controllo dell’isola artica. Non per minimizzare la sua importanza strategica, ma proprio per ricondurla a una dimensione realistica, la lettura di Fontaine è lucida e soprattutto aggiornata con le discussioni sia a DC che tra i corridoio Ue.
Il primo nodo riguarda la difesa americana. Secondo Fontaine, è innegabile che la Groenlandia sia rilevante per la sicurezza degli Stati Uniti: radar, basi, sistemi di allerta precoce e, oggi, anche l’architettura di difesa missilistica rientrano pienamente nell’equazione. Ma da qui a sostenere che Washington debba possedere il territorio, il salto logico è enorme. Gli Stati Uniti, ricorda, possono già fare praticamente tutto ciò che desiderano sul piano militare senza esercitare alcuna sovranità diretta. L’accordo di difesa firmato con la Danimarca nel 1951 – e aggiornato nel 2004 – consente presenza militare, infrastrutture e operazioni. La sicurezza, dunque, non richiede annessione.
La seconda argomentazione che Fontaine contesta è quella dell’urgenza geopolitica: la Groenlandia sarebbe sul punto di cadere sotto l’influenza di Russia o Cina, e gli Stati Uniti dovrebbero intervenire prima che sia troppo tardi. Qui l’analisi diventa quasi banale nella sua semplicità. Se davvero esistesse una minaccia imminente – ipotesi che Fontaine giudica infondata – la risposta più logica sarebbe rafforzare la presenza americana. Un tempo, sull’isola stazionavano fino a 10.000 soldati statunitensi; oggi sono circa 200. Se la preoccupazione è reale, perché non partire da lì?
Il terzo punto riguarda la dimensione marittima. Se navi russe e cinesi stessero realmente “brulicando” intorno alla Groenlandia, osserva Fontaine, la Marina statunitense avrebbe piena capacità di pattugliare l’area in modo massiccio e immediato. Non lo sta facendo. Anche questo dato suggerisce che la narrativa dell’assedio non corrisponde ai fatti operativi.
Segue poi uno degli argomenti più evocativi, ma anche più fragili: “Non si difendono i territori che si affittano”. L’idea è che, anche concedendo pieno accesso militare, esisterebbe una differenza qualitativa tra possesso e uso. Fontaine liquida questa impostazione come una versione caricaturale delle relazioni internazionali – la teoria secondo cui “nessuno lava un’auto a noleggio”. Nella realtà, spiega, gli Stati Uniti difendono costantemente territori che non possiedono. È il senso stesso delle alleanze. Washington ha appena difeso Israele; difende Paesi Nato; nessuno di questi è territorio americano.
Il quinto passaggio è forse il più delicato sul piano politico: l’idea che la Danimarca sia un cattivo alleato e che, per questo, dovrebbe cedere la Groenlandia. Fontaine ribalta completamente la prospettiva. La Danimarca, ricorda, è stata un alleato esemplare. In Afghanistan, in proporzione alla popolazione, ha subito perdite superiori a quelle di molti altri partner. In altre parole, i danesi hanno combattuto per la sicurezza americana, pur non possedendo alcun territorio degli Stati Uniti.
C’è poi la dimensione ideologica, quella che richiama un nuovo “destino manifesto”. L’idea di un’America naturalmente espansiva, destinata ad allargarsi incorporando nuovi territori. Qui Fontaine richiama un principio cardine dell’ordine internazionale post-1945: il divieto di acquisizione territoriale tramite coercizione. L’Iraq non può prendersi il Kuwait, la Russia non può avere l’Ucraina, il Canada non diventa il 51° Stato. E, allo stesso modo, gli Stati Uniti non possono costringere la Groenlandia a entrare nella propria orbita sovrana. Il mondo in cui la conquista è la norma, avverte, è il mondo della legge della giungla.
Infine, l’ultima ipotesi: tutto questo non sarebbe reale, ma semplice trolling politico nei confronti di alleati europei eccessivamente nervosi. Anche questa lettura viene respinta. Anche se fosse solo provocazione, resta una distrazione significativa dai dossier che dovrebbero occupare il centro dell’agenda transatlantica: Russia, Ucraina, Iran, Cina. E soprattutto mina un bene strategico fondamentale: la fiducia degli alleati nella parola e nelle intenzioni americane.
Fontaine torna così al punto di partenza. Molte questioni di politica estera sono difficili. La Groenlandia non lo è. È diventata tale solo perché è stata trasformata artificialmente in una crisi. E, conclude, prima questa crisi costruita svanisce, meglio è per tutti.
Si ricomincia, due mesi dopo le ATP Finals. Anche se forse non ci sei è mai fermati, non del tutto. Gli sponsor, quelli che governano il circo, non vanno volentieri […]
The post Torna il tennis, torna l’Happy Slam first appeared on il manifesto.
Il referendum costituzionale della primavera 2026 segna un passaggio fondamentale nell’evoluzione dell’architettura costituzionale italiana. La riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati, fulcro della consultazione, non è una mera modifica tecnica, ma rappresenta un bivio ineludibile per la cultura della giurisdizione in Italia. L’obiettivo è realizzare una “democrazia compiuta”, chiudendo una lunga stagione di conflitto istituzionale e rispondendo a patologie sistemiche che hanno eroso la fiducia dei cittadini. Questa non è solo una riforma benefica, ma un intervento essenziale per invertire un declino dimostrabile nell’efficacia e nella credibilità del sistema, rendendo il voto del 2026 un punto di non ritorno.
La tesi centrale di questa analisi è che votare “Sì” significa scegliere un sistema giudiziario più equilibrato, imparziale ed efficiente, in piena coerenza con i principi del giusto processo e con una volontà popolare già espressa ma rimasta inascoltata. La riforma è l’esito di un dibattito decennale che giunge oggi a maturazione, offrendo al Paese un’opportunità irripetibile di modernizzare una delle sue funzioni sovrane più delicate e decisive.
Il principio cardine della riforma è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti. Questa non è una semplice riorganizzazione, ma l’attuazione più completa del principio del “giusto processo” (art. 111 Cost.), che esige un giudice terzo e imparziale di fronte a parti che si confrontano su un piano di parità. Sul piano dei principi costituzionali, la riforma sana un’anomalia del nostro ordinamento: un modello di carriera unitaria che tiene insieme, sotto lo stesso tetto, due funzioni — quella requirente e quella giudicante — che per un sano equilibrio istituzionale, ispirato alla separazione dei poteri, devono essere nettamente demarcate.
Separare le carriere non significa solo distinguere i ruoli, ma plasmare una diversa e specifica forma mentis per chi è chiamato a giudicare e per chi è chiamato ad accusare. La scelta quasi irreversibile della funzione, operata a inizio carriera, modella progressivamente una cultura professionale coerente con il proprio ruolo. Per comprendere la portata del cambiamento, è essenziale distinguere tra il sistema attuale, basato sulla distinzione delle funzioni, e quello proposto, incentrato sulla separazione delle carriere.
Questa impostazione è sostenuta da un’ampia parte del mondo giuridico e istituzionale. Come si legge nella relazione della Commissione europea, “il ministro della Giustizia ritiene che la separazione delle carriere rafforzi il ruolo dei magistrati e attui il principio generale secondo cui la giurisdizione è esercitata tramite un equo processo in cui le parti sono su un piano di parità dinanzi a un giudice imparziale”. Posizioni analoghe sono state espresse dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Unione delle Camere Penali Italiane, che hanno definito la riforma “essenziale per garantire l’imparzialità dei giudici”.
La necessità di assicurare un’imparzialità non solo formale, ma anche sostanziale e percepita, si lega direttamente alle carenze strutturali che affliggono il sistema, le quali richiedono un intervento deciso e non più procrastinabile.
La riforma costituzionale non è un’esercitazione teorica, ma una risposta necessaria a disfunzioni strutturali, ampiamente documentate, che minano l’efficienza della giustizia e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La Relazione sullo Stato di diritto 2025 della Commissione Europea offre un quadro impietoso delle patologie che il sistema italiano deve affrontare.
La lentezza della giustizia “costituisce tuttora un grave problema”. In particolare, i tempi per risolvere i contenziosi civili e commerciali sono “i più lunghi nell’UE”, richiedendo in media circa sei anni per una conclusione nei tre gradi di giudizio.
La percezione della corruzione nel settore pubblico “continua ad essere relativamente elevata”. I dati dell’Eurobarometro indicano che l’82% degli italiani la ritiene un fenomeno diffuso, una cifra allarmante se confrontata con la media UE del 69%.
Il sistema soffre di “lacune persistenti” nel personale. Si registra un tasso di carenza del 17% per i magistrati ordinari e del 37% per il personale amministrativo, una situazione che paralizza gli uffici giudiziari.
Questi dati non sono solo numeri, ma la negazione quotidiana del diritto a una giustizia rapida ed efficace. Una magistratura gravata da carenze di organico del 17% e da processi che durano anni non può permettersi l’inefficienza derivante da una carriera indifferenziata. La specializzazione imposta dalla separazione è una leva diretta per ottimizzare risorse scarse e aggredire le lungaggini alla radice, introducendo una logica di efficienza e chiarezza di ruoli oggi assente. Un sistema così inefficiente genera sfiducia e allontana i cittadini dallo Stato, rendendo la riforma non solo opportuna, ma strategica.
Questa urgenza di cambiamento non è avvertita solo a livello istituzionale, ma trova un forte riscontro nella volontà popolare, come dimostrato da recenti consultazioni.
Il dibattito sulla separazione delle carriere non è un’imposizione improvvisa, ma una questione che anima la discussione pubblica da decenni. Proposte di riforma sono state avanzate da commissioni parlamentari, come la “Commissione D’Alema”, e da iniziative di legge popolari, segnalando un’esigenza di cambiamento profonda e trasversale. Questo lungo percorso ha trovato la sua più chiara espressione nella volontà manifestata dai cittadini in occasione dei referendum abrogativi del 2022.
In quella consultazione, il terzo quesito proponeva di abrogare le norme che consentono il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. Il risultato, tra coloro che si recarono alle urne, fu inequivocabile.
Nel referendum del 2022, il 73,26% dei votanti si è espresso a favore della separazione delle funzioni.
Sebbene il quorum non sia stato raggiunto, impedendo l’abrogazione delle norme, il significato politico di quel voto è innegabile. Esso ha rivelato una volontà schiacciante tra i cittadini partecipanti, un orientamento netto verso un sistema in cui i ruoli di giudice e pubblico ministero siano nettamente distinti. Ignorare questa indicazione significherebbe ignorare la voce di milioni di italiani.
Il referendum costituzionale del 2026 offre finalmente l’opportunità di dare attuazione a questa chiara indicazione popolare. Votare “Sì” non significa quindi avallare una riforma imposta dall’alto, ma portare a compimento un percorso democratico che parte dal basso. È la risposta a un’esigenza di chiarezza e terzietà che i cittadini hanno già manifestato. Questa spinta riflette anche il desiderio di superare le tensioni istituzionali che hanno troppo a lungo caratterizzato la giustizia italiana.
La scelta che gli italiani saranno chiamati a compiere nella primavera del 2026 è un verdetto sul futuro del nostro sistema democratico. Votare “Sì” alla riforma costituzionale significa garantire un processo equo, con un giudice veramente terzo e separato dalla parte che accusa, in piena attuazione dell’articolo 111 della Costituzione, rispondere alle disfunzioni del sistema, promuovendo la specializzazione e la chiarezza dei ruoli come leve per aggredire le intollerabili lungaggini processuali, dare seguito all’indicazione inequivocabile emersa dal referendum del 2022, onorando un’istanza democratica già espressa, chiudere una lunga stagione di conflitti e ripristinare quel clima di “rispetto reciproco fra le varie istituzioni dello Stato” che, come ricordato dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione, è condizione indispensabile per alimentare la fiducia dei cittadini.
È importante sottolineare che la separazione delle carriere non è una misura “punitiva” nei confronti della magistratura, ma un passo evolutivo per l’intero sistema-Paese. Si inserisce in una visione organica dello Stato, in cui ogni potere esercita la propria funzione in modo autonomo ma equilibrato, con l’unico fine di tutelare i diritti dei cittadini. La riforma rafforza la magistratura stessa, consolidandone il ruolo a garanzia della legalità e della giustizia.
Per queste ragioni, il voto del prossimo referendum è molto più di una scelta tecnica: è un voto di fiducia nel futuro. Un “Sì” rappresenta un passo coraggioso verso una democrazia più forte, più giusta e un servizio giustizia finalmente più efficiente e vicino alle esigenze reali dei cittadini.

Un veterano di 25 anni in servizio presso un dipartimento di polizia della Florida ha vissuto una situazione decisamente fuori dal comune quando, a seguito di una chiamata per un animale vagante, si è trovato costretto ad ammanettare un emù.
L’ufficio dello sceriffo della contea di St. Johns ha raccontato l’episodio sui propri canali social, spiegando che il caporale Keisler è intervenuto venerdì dopo la segnalazione di un emù in libertà.
«Keisler ha provato a catturare l’emù, ma il grosso uccello non ha obbedito ai suoi ordini, ha scalciato ripetutamente con i suoi potenti artigli e si è dato alla fuga correndo in modo sconsiderato», si legge nel comunicato.
Alla fine il poliziotto è riuscito a bloccare l’animale con un lazo e ha utilizzato le manette per immobilizzargli le zampe.
Policing teaches you to expect the unexpected.
Even a handcuffed emu! pic.twitter.com/fuxKgzg3mr
— Bill Bratton (@CommissBratton) January 16, 2026
Aiuta Renovatio 21
L’emù non ha riportato ferite ed è stato regolarmente riconsegnato al legittimo proprietario. «Tutte le accuse penali nei confronti dell’emù sono state ritirate», ha concluso con ironia il post.
Gli emù (Dromaius novaehollandiae) sono uccelli ratiti originari dell’Australia, secondi per altezza dopo lo struzzo: raggiungono i 190-200 cm e un peso di 30-55 kg.
Tale specie di pennuti dispone di un piumaggio doppio con struttura particolare (due rachidi per ogni stelo), occhi di grandi dimensioni, zampe molto lunghe e muscolose. Le creature raggiungono una velocità massima di circa 50 km/h, con falcate fino a 3 metri. Il maschio incuba le uova per circa 56 giorni senza alimentarsi, perdendo fino al 25% del peso corporeo. L’emù possiede una sacca tracheale che produce suoni gravi e rimbombanti.
Normalmente riservati, tali uccelloni possono diventare aggressivi se si sentono minacciati, durante il periodo riproduttivo o in difesa della prole. I calci, inferti con zampe dotate di artiglio centrale affilato e forza notevole, provocano ferite lacero-contuse gravi, fratture o, in casi estremi, lesioni potenzialmente letali, sebbene gli incidenti mortali restino rari – per il momento.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di Sean Keller via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
L'articolo Poliziotto ammanetta emù proviene da RENOVATIO 21.
Un uomo della Pennsylvania è stato condannato a sei anni di carcere per aver acquistato parti del corpo rubate da una donna di Little Rock, Arkansas, e da altri individui. Il giudice ha stabilito che il condannato dovrà anche pagare una multa di 2.000 dollari e scontare tre anni di libertà vigilata.
Jeremy Lee Pauley, 43 anni, di Thompson, Pennsylvania, è stato condannato a dicembre con l’accusa di associazione a delinquere e trasporto interstatale di beni rubati. Sconterà i sei anni e poi sconterà altri tre anni di libertà vigilata.
La donna di 38 anni dell’Arkansas, Candace Chapman Scott, che lavorava in un obitorio, aveva contattato Pauley su Facebook per vendergli le parti del corpo. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Pauley aveva acquistato una serie di parti del corpo da Scott dopo essersi unito a un gruppo Facebook chiamato «oddities». Scott è stata condannata a 15 anni di carcere.
«I resti includevano un cranio, diversi cervelli, un braccio, un orecchio, diversi polmoni, diversi cuori, diversi seni, un ombelico, testicoli e altre parti. Durante un mandato di perquisizione eseguito presso l’abitazione di Scott a Little Rock, gli investigatori hanno trovato numerose parti del corpo rubate che la donna ha ammesso di aver trasportato in sacchi della spazzatura dal suo lavoro. Scott ha ricevuto un totale di 10.625 dollari dall’acquirente in Pennsylvania per i resti umani», si legge in un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia.
Pauley ha anche ammesso il suo ruolo «in una rete nazionale di individui che hanno acquistato e venduto resti umani rubati dalla Harvard Medical School e da un obitorio dell’Arkansas», ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
«Il traffico di resti umani rubati tramite la posta statunitense è un atto inquietante che colpisce famiglie già in lutto, creando al contempo una situazione potenzialmente pericolosa per i dipendenti e i clienti delle poste», ha dichiarato Christopher Nielsen, ispettore responsabile della divisione di Filadelfia del Servizio di Ispezione Postale. «Spero che i nostri sforzi e queste condanne portino una certa serenità a coloro che sono stati colpiti da questo terribile crimine».
Come riportato da Renovatio 21, il commercio di parti di cadaveri dalla prestigiosa università di Harvard aveva avuto negli scorsi anni diversi sviluppi.
Non si tratta del primo caso di orrori e cadaveri delle università
Come riportato da Renovatio 21, tre anni fa un grande scandalo colpì l’Università di Paris-Descartes: il più grande centro di anatomia europeo presso la scuola di medicina dell’Università di Paris-Descartes fu chiuso a causa di gravi carenze nello stato di conservazione dei cadaveri, locali fatiscenti e sospetti che i corpi venissero mercificati.
I corpi di «migliaia di persone» che avevano donato i loro corpi alla scienza sono stati tenuti in «condizioni indecenti»: e, si scoprì, per decenni.
«I corpi sono stati lasciati marcire, mangiati dai topi, al punto che alcuni dovevano essere inceneriti senza essere sezionati» scrisse L’Express. «Corpi accatastati l’uno sull’altro, senza alcuna dignità e contrari a qualsiasi regola etica».
L’Ispettorato generale per gli affari sociali scrisse un rapporto in cui fiutò, anche qui, il traffico di cadaveri: «utilizzatori e potrebbero essere stati in grado di impegnarsi in un’attività redditizia all’interno del CDC [Centro di Donazione del Corpo, ndr]». In altre parole, anche lì vi poteva essere mercificazione delle parti dei cadaveri.
Come riportato da Renovatio 21, secondo varie testimonianze, in Nigeria è possibile acquistare resti umani al mercato, al fine di utilizzarli per fini esoterici.
«Le ricerche – scrive ancora il quotidiano nigeriano Vanguard – dimostrano che le parti femminili sono più richieste di quelle maschili. Ciò avviene a causa di quello che è descritta come la “potenza” di alcuni organi come i seni e i genitali all’interno di money ritual da parti di herbalist [erborista, sciamano, NdR] o gruppi occulti». Tanto per tenere a mente la storia della vagina sparita di Pamela.
«Abbiamo visto che una testa umana fresca può andare da 60.000 naira (circa 135 euro) in su, mentre un teschio è venduto per 20.000. Le gambe fresche sono vendute per 30.000 ciascuna, mentre una gamba decomposta viene venduta per 20.000. Un dito fresco viene venduto per 5.000, se decomposto o per 3.000. Gli intestini freschi sono venduti per 20.000 mentre quelli secchi sono venduti per 5000. Pezzi di ossa fresche sono venduti per 2.000 e oltre».
I traffici nigeriani di resti umani si sviluppa su due filoni: quello degli omicidi rituali (per i quali c’è stata addirittura una richiesta di stato di emergenza in Parlamento), e quello dei cimiteri, dove guardiani fanno affari riesumando i cadaveri poche ore dopo la sepoltura e sezionandone le parti che interessano a chi prepara le pozioni.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di East Pennsboro Township Police Department, via Twitter, rielaborata per adattamento al formato.
L'articolo Uomo condannato a 6 anni per aver acquistato parti del corpo rubate da una donna incontrata su Facebook proviene da RENOVATIO 21.
Nikola Grbić è una leggenda della pallavolo serba e mondiale. Palleggiatore olimpionico, ha conquistato l’oro a Sydney 2000 e numerosi titoli internazionali con la nazionale jugoslava/serba. Il suo palmarès comprende anche un ricco bottino di trofei con i club, tra cui due scudetti e due Champions League.
Il suo percorso sportivo, durato quasi vent’anni in Italia, è stato continuo e di altissimo profilo. Dopo il ritiro dall’attività agonistica, Grbić si è affermato come allenatore di grande prestigio, apprezzato per leadership, competenza tecnica e mentalità vincente.
Oggi è commissario tecnico della Polonia, con cui ha conquistato la medaglia d’argento agli ultimi Giochi Olimpici di Parigi. Serbo – jugoslavo… – di nascita, italiano d’adozione e cittadino del mondo, Nikola Grbić si racconta in questa intervista a Renovatio 21, parlando di pallavolo, famiglia e valori sportivi, e offrendo uno sguardo su una disciplina che oggi gode di grande visibilità e partecipazione di pubblico, soprattutto in Italia, sede di uno dei campionati più prestigiosi al mondo.
La pallavolo è una questione di famiglia per te, perché tuo padre è stato un giocatore di pallavolo. Hai eredito questa passione che poi è diventata una professione.
Sono cresciuto in un paesino di 2.500 abitanti. Ho vissuto un’infanzia belli ssima, perché eravamo sempre fuori a giocare a pallacanestro, a calcetto e a pallavolo. L’attività fisica era sempre presente, nonostante non avessimo una palestra. Avevamo a disposizione una vecchia casa tedesca – ereditata dalla seconda guerra mondiale – dove in un soggiorno enorme avevano messo due attrezzi per fare una sorta di ginnastica in inverno.
Non abbiamo avuto la possibilità di fare educazione fisica in una palestra vera e propria. Solo negli anni Novanta, quando già ero andato via, l’hanno finita di costruire. A me piaceva molto giocare a calcetto e calcio, ed ero molto bravo, almeno penso [ride]. Quando però è arrivato il momento di scegliere, papà mi ha detto: «Tu giochi a pallavolo». A me piaceva, sia chiaro, però il suo è stato più che un suggerimento, diciamo così. Devo dire che ha fatto molto bene, perché conoscendo il mio carattere e conoscendo il mondo del calcio, soprattutto in Serbia, è stata una scelta e una decisione più che giusta.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Tra le righe leggo comunque un ottimo rapporto tra te e tuo padre.
Sono quello che sono grazie a lui, perché ha avuto una grande influenza su di me, anche se non è mai stato un padre troppo affettuoso. La sua vita è stata caratterizzata da molte difficoltà. I suoi genitori, dopo la Seconda Guerra Mondiale, furono portati con i treni in Voivodina dalle zone rurali dell’Erzegovina, della Bosnia e del Montenegro. Quelle zone un tempo appartenevano all’Impero Austro-Ungarico e poi alla Germania. Una volta terminato il conflitto bellico hanno cercato di cancellare ogni traccia residuale di quel brutto periodo e c’era bisogno di popolare zone semi disabitate. Per incentivare ciò veniva dato un pezzo di terra e una casa a molte famiglie.
Tutto ciò avvenne quando mio padre era adolescente e di conseguenza è cresciuto in povertà. Non avevano niente. Mio babbo mi ha cresciuto con una disciplina rigida, ma giusta. Diceva sempre: «Se vuoi fare una cosa, falla e falla bene, sennò lascia perdere». Mi ha trasmesso questa mentalità. Non sarei quello che sono, non avrei vinto quello che ho vinto, se non fosse per questo tipo di educazione che mi ha impartito. Un approccio mentale e una disciplina ferrea e decisa.
Il tuo primo contatto col professionismo avviene proprio in Serbia.
Era il 1991. C’era una doppia licenza al tempo: alcuni giocatori giovani ingaggiati da una società di serie A, avevano la possibilità di giocare in un campionato di tre divisioni più basso. Se io mi allenavo con la squadra, essendo molto giovane, avrei avuto zero possibilità di giocare le partite. Usando questa metodologia hanno dato la possibilità ai ragazzi che si allenavano con la prima squadra, di giocare in categorie minori.
Giocavo nella squadra del paese dove andavo a scuola, in quarta divisione, e ogni tanto mi aggregavo con la prima squadra. Quando ho compiuto i diciotto anni ho firmato un contratto professionistico di due anni più due. Ho giocato lì due anni, ho fatto un anno di militare e poi son venuto in Italia.
A ventun anni vieni ingaggiato dalla squadra di Montichiari, la Gabeca Pallavolo. Squadra nuova e nazione straniera: che impatto hai avuto, vista anche la tua giovane età?
È stato un sogno che si è avverato, perché in quel periodo il campionato italiano era il più forte in assoluto. Tutti i giocatori di altissimo livello di tutte le nazionali quali Russia, Brasile, Olanda, giocavano in Italia. La cosa complicata è che al tempo c’era la possibilità di avere solo due stranieri per squadra e non quattro come adesso. Sono stato fortunato, perché quella squadra e quella dirigenza hanno scommesso su di me.
Considera che non avevo nemmeno esperienze di nazionale. Quella squadra aveva tutte le premesse per fare qualcosa di importante, quantomeno di entrare tra le prime quattro in campionato. Fu una possibilità clamorosa che mi si prospettò e ho cercato di impegnarmi al massimo. All’inizio fu difficile, perché non parlavo una parola di italiano e il mio inglese non era fluente.
In televisione tutti parlavano in italiano, andavo al supermercato e tutti parlavano italiano e non c’era Google Translate [ride]! Ho impiegato quattro mesi per imparare la lingua e iniziare a capire. Non ho preso nemmeno una lezione d’italiano in tutta la mia vita. Tutto quello che so l’ho imparato vivendo, ascoltando e conversando con la gente. È stato un impatto non facile, sotto tutti i punti di vista: emotivo, di maturità e di solitudine, perché ero lontano dalla mia famiglia e dalla mia terra.
Pensa che nell’appartamento dove alloggiavo, essendo nuovo, non avevano ancora istallato il telefono fisso e per chiamare i miei familiari andavo in una cabina telefonica lungo la strada e con una scheda da cinquemila lire parlavo qualche minuto con casa mia.
Immagino che la tua famiglia ti abbia appoggiato in questa tua scelta professionale.
Assolutamente! Ho avuto sempre il massimo supporto.
Iscriviti al canale Telegram ![]()
La tua carriera da giocatore è prevalentemente in Italia, ma il tuo ultimo anno – stagione 2013/2014 – lo giochi in Russia. Che ambiente hai trovato rispetto al campionato italiano?
Ero un giocatore maturo, avevo quarant’anni e padre di due figli. Ho avuto la fortuna e l’opportunità di giocare nel Volejbol’nyj klub Zenit-Kazan’ che è a tutt’oggi una delle squadre più forti al mondo. È una società con grandi ambizioni che investe molti danari. Ha giocatori di livello altissimo, allenatore e staff tecnico non ti dico. Tutti al top.
Non è un club come tanti, e se non fosse arrivata una richiesta da un club così importante forse sarei rimasto a Cuneo e finito la mia carriera lì. Successe che si fece male un titolare che doveva stare fermo per sei mesi e mi contattarono all’improvviso. Una città bellissima, un allenatore con cui ancora oggi sono in buoni rapporti, il suo secondo era Tom Totolo che chiamai quando allenai la Serbia nel mio ultimo anno. È stata un’esperienza bellissima sotto tanti punti di vista, al di là dell’aspetto economico.
La tua carriera pare non conoscere pause. Nella primavera del 2014 ti ritiri da giocatore e inizi subito ad allenare.
Ho avuto cinque giorni di pausa!
Come è avvenuto questo cambio di ruolo? È stata una scelta meditata quella di intraprendere la carriera di allenatore?
Mi chiama Slobodan Kovač, che aveva firmato come CT dell’Iran, e mi dice che la nazionale non gli permetteva il doppio incarico e lui era costretto a lasciare la Sir Safety Perugia. Nel frattempo Gino Sirci [presidente della Sir Safety Perugia, ndr] aveva preso informazioni su di te tramite Kovač. La domenica gioco la mia ultima palla e il lunedì mi chiama Gino. Gli ho chiesto due giorni per pensarci e nel frattempo mi sono confrontato col mio procuratore per chiedergli se potesse trovarmi un altro ingaggio [ride]!
Avevo appena vinto il campionato in Russia, ed è vero che avevo quarant’anni, però vista la vittoria potevo ambire ad un altro anno di contratto. In realtà ci fu concretamente questa possibilità, perché la squadra di Cuneo sembrava che dovesse spostarsi a Torino con un nuovo sponsor molto importante, ma la piazza di Cuneo protestò e non permise questo cambio di location. Il presidente mi voleva in quella squadra e ambivo a due anni di contratto. Sarebbe stata una chiusura perfetta per la mia carriera per poi decidere con calma sul futuro.
Non se ne fece nulla e così richiamai Sirci e accettai il mio primo incarico da allenatore. È stato difficile perché io in quel momento, appena finito di giocare, pensavo di sapere tutto con la mia lunga esperienza da giocatore costellata di tante vittorie. Invece non sapevo nulla! Conoscevo benissimo la pallavolo, questo è chiaro, ma non avevo contezza di quelle cose legate all’organizzazione, alla preparazione, ai video, alla comunicazione, ad organizzare lo staff e alla gestione di quattordici giocatori. È un altro mondo.
Quell’anno mi ha subito maturato. Dopo ho firmato per la Serbia. Se ti chiama la tua nazionale e non ci vai? A tutt’oggi a Gino ancora non piace condividere l’allenatore e decise di non prolungarmi il contratto in quanto mi ero impegnato con la Serbia. Da lì in poi è stata una progressione in crescendo; ogni anno imparavo qualcosa di più e tutto quel percorso mi ha aiutato a diventare quello che sono oggi.
Immagino che la giornata tipo del giocatore e quella dell’allenatore siano sostanzialmente diverse.
Certo che sono diverse. Da giocatore pensi solo a te stesso, hai il tuo tempo libero e non ti preoccupi di nulla, quando arrivi all’allenamento c’è qualcuno che ti dice quello che devi fare e come ti devi allenare. Un allenatore invece si preoccupa di preparare e fare di tutto perché tutti i giocatori siano al loro massimo per affrontare al meglio la gara: tecnicamente, tatticamente, fisicamente e mentalmente. Da giocatore avevo la possibilità di cambiare il risultato, di cambiare qualcosa con il mio gioco, con una mia azione, che sia un muro, una battuta, una schiacciata.
Ero coinvolto nel match da protagonista. Da allenatore guardo diciotto partite, preparo la tattica, preparo la squadra in base anche agli avversari, come giocano, quello che fanno e di conseguenza hai un approccio diverso alla partita. Faccio degli schemi che dovranno eseguire e se tutto va per il verso giusto e vincono, quanto siamo bravi. Se si perde, quanto sono scarso come allenatore perché non li ho guidati bene. Se la squadra non va il primo che si sostituisce è l’allenatore. Se le cose non vanno è chiaro che l’allenatore ha le sue colpe e le sue responsabilità, ci mancherebbe, ma essendo stato giocatore lo so come funzionano certi meccanismi.
Gli ultimi anni della mia carriera da giocatore, oramai riuscivo ad avere una visione a tutto tondo della situazione e se avessi voluto far cambiare l’allenatore, lo potevo fare tranquillamente. Fare l’allenatore, rispetto al giocatore, è una posizione più a rischio: in caso di troppe sconfitte viene esonerato il coach e difficilmente vengono sostituiti i giocatori. È prassi infatti che gli allenatori firmino contratti della durata media di due anni.
Questa è stata ed è una sfida ulteriore che ti si pone nella tua vita sportiva e professionale.
Da allenatore sono stato licenziato tre volte, e tutte e tre le volte, a posteriori, le società si sono pentite di quella scelta, ma fa parte del gioco. Oramai ho gli anticorpi, so che è parte del nostro lavoro e io sono tranquillo, perché prima di iniziare un’avventura con chiunque, io dico: «Queste sono le condizioni per cui io possa lavorare bene. Ho bisogno di queste cose…».
E non è mai una questione di soldi, anzi, i soldi non sono in cima alla scala delle mie priorità. Se una società riesce a darmi ciò di cui necessito, allora instauriamo un rapporto professione. Se invece, ad esempio, vi è una dirigenza, un presidente che pretende di fare la formazione, decidere chi gioca e chi no, allora non se ne fa nulla.
Altri miei colleghi, pur di allenare un top team farebbero di tutto, io no. Ho le mie regole e una mia etica di lavoro. Se devo prendermi una responsabilità deve essere come dico io, non perché io penso di essere più importante del presidente o il più bravo del mondo, ma semplicemente vorrei delle condizioni in cui possa svolgere bene il mio lavoro. Se ci sono le condizioni bene, altrimenti non se ne fa nulla e va bene così. A volte i risultati arrivano, altre volte meno. Le variabili sono molteplici: gli infortuni, la sfortuna, lo scarso rendimento di qualche giocatore…
Può succedere che un tuo giocatore di punta possa attraversare un momento personale difficoltoso e riversarlo nel suo modo di giocare andando a inficiare le sue performance e di conseguenza quelle della squadra?
Ti potrei parlare di tanti di quei momenti che incidono nel risultato finale che sono al di fuori dal mio controllo. Nell’ultimo anno che ho allenato a Perugia [2022, ndr] abbiamo giocato quasi tutta la stagione senza Roberto Russo che è il miglior centrale italiano da anni. Abbiamo giocato con Stefano Mingozzi e Fabio Ricci, che con tutto il dovuto rispetto non sono dei top player come Russo. Wilfredo León scoprì una calcificazione al ginocchio che poi ha dovuto operare e con la testa non era al cento per cento.
Oleh Plotnyc’kyj ha avuto una stagione stupenda, ma a fine febbraio scoppia la guerra in Ucraina [2022, ndr] e lui essendo ucraino, era fortemente preoccupato per la situazione e stava sempre al telefono con i suoi cari e di fatto in quel periodo era inutilizzabile. Ce ne sono tante di situazioni così di cui io, come allenatore, non posso avere il controllo. La mancata vittoria in quell’anno e la firma per la nazionale polacca hanno sancito il mio addio alla Sir Safety Perugia.
Nel ruolo di allenatore, quanto sono importanti le tecniche e le tattiche e quanto gli aspetti psicologici nei rapporti con gli atleti?
È tutto molto importante. Io ti posso preparare mentalmente e tu fai tutto quello che c’è da fare, ma se non ce la fai tecnicamente è del tutto inutile. Se tu tecnicamente e fisicamente sei pronto, ma hai paura nei momenti importanti, non raggiungi comunque il risultato. Io preferisco che uno abbia carattere. Un carattere forte – ovviamente parliamo di giocatori che possono giocare in un top club come Perugia ad esempio – può superare ogni ostacolo, anche con qualche carenza tecnica. Al come devo scegliere un giocatore per la mia squadra mi sono ispirato a Željko Obradović, ex allenatore di basket che ha vinto nove Coppa dei Campioni – Eurolega con cinque squadre diverse.
Lui chiama cinque persone di cui si fida e che hanno lavorato col giocatore in questione; se una di queste cinque persone gli dice una cosa negativa, non lo prende. Io cerco di usare il medesimo sistema, preoccupandomi soprattutto del carattere del giocatore, senza seguire in maniera rigida le statistiche sportive. Mi interessa sapere se è disciplinato e se sa stare nel gruppo. Se hai una testa calda nel gruppo che non riesce a capire l’importanza della squadra, ti crea più problemi che altro.
C’è un allenatore che ti ha particolarmente ispirato?
Tanti! Ho avuto la fortuna di lavorare con molti allenatori di altissimo livello quali Julio Velasco, Gian Paolo Montali, Daniele Bagnoli, Vladimir Alekno… Ognuno mi ha insegnato qualcosa, perché sono diversi tra loro. Uno è più management della squadra e dei giocatori, un altro ha un approccio psicologico maggiore, da un altro ho appreso la disciplina, da un altro la tattica. Altri allenatori mi hanno insegnato come non bisogna fare assolutamente, ed è importante anche quell’aspetto. per cui, nel bene e nel male, ho appreso da diversi coach. Apprendere come una cosa non la si deve fare, è un grande aiuto comunque.
Sostieni Renovatio 21
Come gestisci e come hai gestito, nel corso del tempo, la famiglia e la professione?
È una grande difficoltà. Mi è capitato nel corso della mia carriera di dovere essere staccato dalla famiglia, come quando andai a giocare in Russia. Mia moglie è rimasta con i nostri due figli piccoli a Cuneo. Eravamo divisi e non riuscivamo a vederci spesso, perché la Russia non è proprio dietro l’angolo e anche con l’aereo ci vuole il suo tempo. Due giorni liberi non bastavano, perché le distanze sono enormi. Stesso discorso quando giocavo in Polonia. Abbiamo cercato sempre di stare insieme a prescindere e alcune scelte della mia carriera sono dovute alla situazione di famiglia. Magari sarei potuto andare non so dove, perché sarebbe stato importante per la mia carriera, ma avrei avuto notevoli difficoltà con i miei cari.
A volte i soldi non sono tutto. La ragione per cui io adesso non prendo un club da allenare è perché ho voluto stare di più con i miei figli. Fare il commissario tecnico di una nazionale mi concede più tempo libero. Negli ultimi quattro anni sto di più a casa e faccio il babbo. Li porto i ragazzi agli allenamenti… gli faccio da tassista [ride]! Se allenassi un club sarei impegnato quasi tutto l’anno e tutti i giorni della settimana. È un momento della nostra vita che sto abbracciando con grande calore perché mi permette di passare del tempo con i miei figli che vivono un momento – che è l’adolescenza – dove hanno bisogno del padre. Vivo un tempo qualitativo che non ho mai avuto fino ad ora. È una cosa importante questa, perché so quanto sia difficile per i giocatori che hanno la famiglia spostarsi, scegliere i contratti sulla base di come è la città in cui si trova il club, capire se la moglie vuole o meno trasferirsi. Sono tante le variabili.
Nel 2019, per due anni, alleni i polacchi dello Zaksa. Grandi vittorie e grandi soddisfazioni con la conquista della Champions League. Ci racconti quell’esperienza?
Ero al mio secondo anno quando abbiamo vinto la coppa. Il primo anno sono arrivato e il giocatore più forte che avevano, Sam Deroo, andò alla Dinamo Mosca, ma quando firmai il contratto ancora era presente in rosa. Ciò comportò che alla scadenza del mercato dovemmo cercare, in fretta e furia, un sostituto alla sua altezza, ma invano. È venuto Simone Parodi, con cui ho giocato quando aveva ventitré anni, vincendo tanto insieme.
È un ragazzo che adoro, però al tempo arrivò che aveva trentasei anni e di fatto era a fine carriera. Quella prima stagione fu interrotta a marzo a causa della pandemia COVID, però nel corso di quei mesi ho potuto scegliere i giocatori per l’anno successivo. Con quella squadra abbiamo vinto quando era più difficile di quanto lo sia ora, perché una volta scoppiata la guerra in Ucraina le squadre russe sono state estromesse dalle competizioni europee.
Lo Zaksa ha vinto tre Champions League: la prima contro Kazan, la seconda sarebbero dovuti andare a giocare la semifinale contro la Dinamo Mosca, che era fortissima, proprio nella capitale, ma il match fu annullato causa conflitto bellico. Poi hanno vinto la coppa, ma quella semifinale sarebbe stata veramente dura da superare sul campo. Non voglio assolutamente sminuire nulla, anche perché hanno vinto tre coppe consecutive con tre allenatori diversi. Evidentemente la squadra c’era. Mi ricordo che al sorteggio di quella Champions speravo di non beccare né Civitanova, né Kazan.
Quarti di finale Lube Civitanova e semifinale Kazan [ride]! La prima partita con Kazan perdevamo 2 a 0 a casa loro, ma abbiamo vinto. Fu un cammino tutto in salita e in finale incontrammo Trento. Abbiamo vinto una Champions League quarantasei anni dopo l’ultima vittoria di una coppa da parte di una squadra polacca. È stato un successo imparagonabile! Il mio primo trofeo internazionale da allenatore.
Tu e la tua famiglia vivete da tempo a Perugia. È stata una scelta di cuore?
È stata una scelta di mia moglie [ride]! A me piace, abbiamo tanti amici qua, ma per quanto mi riguarda è lontana dall’aeroporto di Roma e per me che viaggio spesso, non è una grande comodità. È una città dove si vive bene, è tranquilla. Mia moglie ci sta bene. Aggiungo un’altra cosa: prima della vittoria di Champions con lo Zaksa avevo firmato un prolungamento del contratto con loro.
Abitavamo con la mia famiglia a Katowice e per raggiungere la sede degli allenamenti mi facevo un’ora di macchina tutti i giorni. Vista la logistica non troppo comoda un po’ per tutti, ci eravamo promessi che io sarei rimasto lì e i miei familiari sarebbero tornati in Serbia. Mi richiamano da Perugia e io per forza ho preso in considerazione la proposta, cosa che non avrei fatto per nessun’altro club. E così prendemmo la decisione di tornare a Perugia che è una scelta di vita. Ovviamente a livello professionale era un grande stimolo, perché Perugia ha una squadra molto forte.
Però allo Zaksa stavo benissimo con tutti: con il presidente, con lo staff e con i giocatori. Quando mi arrivò l’offerta da Perugia – significativamente più alta rispetto a quella dello Zaksa – Sebastian Świderski fece carte false pur di trattenermi. Lo ringrazio sentitamente perché fece di tutto per tenermi, ma la scelta di Perugia è stata una scelta per la famiglia, per stare finalmente insieme. Lui ha capito la situazione.
Ti piacerebbe tornare a vivere in Serbia in futuro?
A vivere no, perlomeno ancora no.
Come vedi dall’esterno la situazione politica nel tuo paese?
Adesso è difficilissimo dal punto di vista politico e dal punto di vista della vita. La gente è polarizzata: o sei pro o sei contro. Non c’è una via di mezzo. Purtroppo non è un ambiente dove io vorrei crescere i miei figli. Per quanto mi riguarda io potrei tornare a casa mia, nella mia cittadina dove ci sono duemila cinquecento abitanti, sto bene lo stesso.
Ne abbiamo parlato in famiglia, ma al momento non ci sono i presupposti. Se ne parla spesso, perché è il nostro paese, perché anche mia moglie è serba. Abbiamo una bella casa a Belgrado. Volendo potremmo, però al momento va bene così. Mai dire mai in futuro.
La Serbia ha tanti campioni importanti nel mondo dello sport. Su tutti il campionissimo di tennis Novak Djokovic che pochi anni fa fu al centro di una polemica – in piena era pandemica – quando tenne il punto e non retrocedendo di un millimetro riguardo la sua legittima scelta di non sottostare all’imposizione vaccinale dimostrando un carattere molto determinato. Questa determinazione caratteriale è una caratteristica del vostro popolo?
Adesso è un eroe, mentre ai tempi fu crocifisso. Credo che noi serbi abbiamo questa prerogativa, che non è un capriccio, non è semplice orgoglio di per sé, ma un misto di sensazioni. Quando ci troviamo in una situazione dove il mondo è contro di noi, o quando l’avversario è più forte di noi, noi abbiamo una forza interiore che non riesco a spiegare.
Gli americani si stupiscono per i vari colpi che abbiamo in campo quando affrontiamo un match, e pensano che facciamo degli esercizi particolari per crearli. In realtà non è così, noi giochiamo sin da piccoli e sin dall’infanzia abbiamo questa sana competizione: fare di tutto per battere l’avversario, non importa se ci giochiamo il gelato o uno scudetto. È uguale, io voglio batterti. Quanto una competizione è difficile, tanto più sale la motivazione di superare le difficoltà.
Novak in questo è stato incredibile. Non credo ci sia un altro esempio nella storia di questo tipo. Lui è rimasto stoico quando tutto il mondo gli andava contro. Lo deridevano chiamandolo anziché col suo nome, Novak, lo apostrofavano chiamandolo «NoVax», per prenderlo in giro. Tutte le forze massmediatiche erano contro di lui. Arrivarono a segregarlo in quell’albergo squallido, non so se ti ricordi, quando andò in Australia. Delle cose mai viste.
Oggi quando si scopre cosa fa questo vaccino – una truffa mai vista – per molti è diventato un eroe. Mi ricordo quei momenti. Non era semplice prendere una decisione. Ricordo alcuni amici che decisero di non vaccinarsi e tutti quanti gli andavano addosso che non ti dico. È stato un periodo che spero non si ripeta mai più.
In quel periodo una personalità così forte come Djokovic ha saputo rimanere con la schiena diritta nonostante tutto il mondo lo criticasse. Per molti credo sia stato da esempio, non pensi?
Assolutamente sì!
Aiuta Renovatio 21
Un passo indietro. Olimpiadi di Sidney 2000. Con la nazionale jugoslava vincete l’oro olimpico dopo il bronzo conquistato ad Atlanta ’96. In semifinale giocate contro l’Italia e in finale contro la Russia. L’oro olimpico è la vittoria più ambita da ogni sportivo.
Per la pallavolo si, mentre per il calcio non è così ad esempio. Noi progressivamente stavamo crescendo dopo il bronzo alle Olimpiadi. Quando siamo partiti per Sidney c’era la possibilità per noi di vincere una medaglia, non si diceva, però eravamo tra i papabili. Purtroppo la persona che ha organizzato il nostro rientro da Sidney non pensava andasse così e ci prenotò il volo la sera del giorno della finale. Andammo a giocare la finale olimpica portandoci appresso tutti i nostri bagagli e una volta terminata la partita il responsabile ci disse: «Va bene ragazzi, abbiamo vinto l’oro, ma dobbiamo sbrigarci sennò perdiamo l’aereo!». Non abbiamo avuto neanche un momento per celebrare o andare in giro a festeggiare.
Il nostro sponsor tecnico ci aveva organizzato una nave tutta per noi per fare festa, ma non se ne fece nulla. Tornati in Serbia troviamo Belgrado sotto le barricate per i tumulti politici che c’erano al tempo e ci sconsigliarono di andare in centro città a festeggiare. È stato un periodo complicato per il mio popolo, ma a me egoisticamente dispiacque, perché dopo aver vinto la medaglia più prestigiosa, non potemmo neanche celebrare questa vittoria per il timore che qualcuno potesse approfittare di quella festa per scopi politici.
Andammo così a Novi Sad, dove anche lì c’era un meeting di protesta, ma quando arrivammo tolsero tutti gli striscioni e le bandiere politiche e ci accolsero con grande calore. Fu una celebrazione sincera, almeno per quella mezz’ora! Dopo le olimpiadi di Atlanta, quattro anni prima, dove conquistammo il bronzo, tornammo in patria in agosto e c’erano trecentocinquanta mila persone in centro città ad applaudirci. Fu meraviglioso! Per l’oro anche il clima ci fu avverso, perché era ottobre, pioveva e faceva freddo.
A Sidney fu più difficile per voi la semifinale contro l’Italia o la finale con la Russia?
I quarti di finale contro l’Olanda che vincemmo 3 a 2. Quello fu uno spartiacque per noi. Gli incontri successivi li giocammo contro le due squadre con le quali perdemmo nel girone! Perdemmo nel primo match 3 a 1 contro la Russia e 3 a 2 contro l’Italia, ma in semifinale e in finale fu tutta un’altra storia. Pensa che ancora non ho rivisto le partite. La prima volta che ho visto quella finale in televisione fu quindici anni dopo.
Ero allenatore della nazionale serba e alle tre di un pomeriggio la federazione organizzò una festa per i quindici anni dalla vittoria olimpica. Dopo la festa salimmo sul bus per andare in Bulgaria a giocare delle amichevoli. Nel pullman apro il portale delle news e vedo un articolo riguardo la nostra vittoria con un link video. Pensavo fosse un reportage, invece c’era la partita per intero! Un’ora e sette minuti. Me la sono guardata tutta e non sapevo che fosse finita in così poco tempo. Pensavo fosse durata di più. Il resto delle altre partite non le ho mai riviste. Mi piacerebbe prima o poi riguardarle.
I ricordi più veri e più nitidi li hai dentro di te.
Eh sì!
Gli anni della guerra in Jugoslavia, te come li hai vissuti?
Ero in Italia per fortuna. La guerra nella ex Jugoslavia era partita in Slovenia e piano piano stavano cercando di buttare fuori le forze del regime e le armate della Jugoslavia per sostituirli con i militari sloveni o croati. In questa ritirata, chiamiamola così per intenderci, la guerra si è trattenuta più a lungo in Bosnia e in alcuni luoghi della Croazia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale Tito aveva incoraggiato la gente a coabitare, a fare dei matrimoni misti tra musulmani e croati, tra serbi e croati e così via. Si sceglievano le donne di un’altra etnia per rinforzare la coesione tra i popoli slavi.
Specie in Bosnia potevi trovare un paesino che era musulmano e pochi chilometri più in là trovare tutti serbi e più in là ancora tutti croati. Era poi difficile rivendicare le proprie terre a quel punto. Fortunatamente il conflitto vero e proprio non è mai arrivato in Serbia. I miei genitori vivevano sotto embargo. C’era la benzina che era pesantemente razionata: avevano un buono di trenta litri al mese e aspettavi in fila al distributore per giorni interi. Momenti difficilissimi.
Tornando allo sport, prima hai fatto un accenno al bronzo di Atlanta ’96. Che emozione fu per te quella prima importante medaglia? Eri molto giovane.
Avevo ventitré anni. mi ricordo che per quell’olimpiade ci furono diverse polemiche perché erano i cento anni dalla prima edizione e tutti pensavano che fosse naturale assegnare la sede ad Atene, ma probabilmente alcuni fecero forti pressioni affinché si assegnassero agli Stati Uniti. Mio padre è stato capitano della nazionale e il massimo che aveva vinto fu un bronzo agli Europei.
Quando ci siamo qualificati per le olimpiadi posso dire di averlo superato, perché lui non riuscì in questa impresa. Aver vinto poi nei quarti di finale contro il Brasile, che erano i campioni olimpici in carica, fu un risultato clamoroso ed eravamo in zona medaglia. Dall’eccitazione agonista non riuscii a dormire, te lo giuro!
Quando abbiamo battuto la Russia per la seconda volta – 3 a 1 nella finale terzo e quarto posto – faccio fatica a spiegarti l’emozione che avevo. Ero ad inizio carriera e capisci che quelle emozioni sono state veramente intense. Potevo anche smettere di giocare a pallavolo dopo questo incredibile inizio di carriera! Fu un flash questa sensazione, ma racchiude l’intensità di quello che provavo per la conquista di un bronzo olimpico.
Faccio un salto temporale di molti anni. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 tu sei il commissario tecnico della Polonia. Vincete la medaglia d’argento. Un’altra medaglia, ma stavolta in un ruolo diverso. Che ricordi hai?
È diverso. Io sono diverso.
Vivendo le Olimpiadi da sportivo, hai visto dei cambiamenti nel corso delle varie edizioni in cui hai preso parte?
Tante cose sono sempre uguali e alcune cose sono cambiate, di solito in meglio. Noi arrivammo al villaggio olimpico di Parigi nel pomeriggio e per cena siamo scesi alla mensa più vicina a noi e abbiamo aspettato quaranta minuti come tutti gli altri, perché era il giorno antecedente alla festa di apertura. In Francia fu la prima volta che non partecipai alla cerimonia di apertura, perché giocavamo il giorno dopo e dovevamo rimanere concentrati in vista dell’esordio. Va bene che la prima era contro l’Egitto, ma è sempre un incontro che non deve essere preso alla leggera.
Ogni Olimpiadi si porta appresso uno strascico di polemiche e Parigi non fece di certo eccezione.
Le polemiche ci sono sempre. Quello che a me non è piaciuto è stata la cerimonia di apertura. C’era quella parte della celebrazione dell’amore o che ne so – non ho niente contro – però vedendola dalla tv non mi piacque per niente. Qualche cosa che non va c’è sempre, dall’alloggio, ai pasti… però ricordo una sala pesi molto ben attrezzata e a disposizione della nostra squadra e di quella femminile.
Mi ricordo che dissi ai ragazzi: «Come è per noi è per tutti quanti, quindi concentrati, perché i futuri campioni mangiano dove mangiate voi e dormono negli alloggi come i vostri. È così per tutti». Quando sei giocatore è diverso come esperienza, perché come ti ho detto anche prima, sei protagonista vero in campo. Come allenatore ho un ruolo senz’altro importante, però sto fuori dal campo di gioco.
Ti viene la voglia, ogni tanto, di varcare quella linea e tornare a giocare?
All’inizio si! Adesso no.
Nel 2001 vinci l’oro ai Campionati Europei con la Jugoslavia battendo l’Italia in finale. In quell’edizione sei stato nominato anche miglior palleggiatore. Una doppia soddisfazione.
Credo di avere vinto diverse volte il premio di miglior palleggiatore, ma non ho mai badato a questo tipo di riconoscimento. Abbiamo vinto gli Europei ed è quello che conta veramente.
Fu complicata quella finale contro i ragazzi italiani?
Finimmo in un’ora. 3 a 0. Non c’è stata partita. La Russia fu un avversario più difficile, però anche a loro rifilammo un 3 a 0. Abbiamo dominato quell’Europeo, soprattutto verso la fine, perché eravamo ancora più forti dell’anno prima a Sidney. Eravamo più maturi e avevamo una grande forza agonistica.
Passando alle squadre di club, con il Treviso vinci la Coppa dei Campioni nella stagione 1999/2000.
A Treviso è stata la più difficile esperienza della mia carriera professionale. Sono stato malissimo, anche se è stato l’anno in cui ho vinto di più con un club. Vincemmo la Coppa Italia che non vincevano da sette anni, poi partecipammo alla Supercoppa Europea che se la giocavano ai tempi le finaliste della Coppa Campioni, della CEV e della Coppa delle Coppe. Un torneo importante.
Purtroppo perdemmo Lorenzo Bernardi per infortunio e conseguente operazione – infatti saltò le Olimpiadi di Sidney – e Samuele Papi che si infortunò prima del primo match. Vista la situazione emergenziale giocammo in recezione con Alberto Cisolla, che generalmente giocava come secondo opposto, e Marcos Milinković che giocava in nazionale come opposto e a Treviso come centrale.
C’era Daniele Bagnoli come allenatore, una figura carismatica e io come giocatore ero più debole caratterialmente. Avevo quattro anni di contratto, ma mi hanno mandato via senza pagare una lira. Milano, con cui ho poi firmato, ha dovuto pagare una penale di qualche migliaio di euro. È stata un’esperienza difficile, per non dire altro.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Hai giocato con tanti campioni talentuosi come te. Visto che lo hai citato, Lorenzo Bernardi a detta di tutti è un campione senza tempo. Me lo confermi?
Non è facile amarlo, perché non si fa amare, però credo abbia una forza agonistica senza pari e tutti, io compreso, se dovessimo giocare una finale lo vorremmo in squadra.
Nel 2007 passi al Trentino Volley e vinci il tuo primo scudetto contro Piacenza. L’anno dopo arrivi secondo sempre contro Piacenza in un match tiratissimo al quinto set e all’ultimo punto.
Non ci ho dormito per sei mesi! Abbiamo avuto tre contrattacchi, 13 a 11 per noi, ma alla fine perdiamo.
Nonostante fossi un giocatore esperto e maturo, una sconfitta così lascia il segno. Alla fine anche le sconfitte fanno parte della vita.
È vero! Quando vinco, non ti dico come se fosse normale, però la grande emozione e l’euforia durano poco, perché già mi proietto alla prossima gara. Invece quando subisco una sconfitta, come quest’ultima in semifinale al Mondiale, nonostante abbiamo vinto il bronzo, faccio molta fatica a metabolizzare le sconfitte anche se ho la tranquillità di aver fatto tutto il possibile per vincere.
Le sconfitte sedimentano in noi in maniera diversa rispetto alle vittorie.
Se tu pensi quante volte ho perso in semifinale e quante finali ho perso tra club e Nazionale, sono tante le sconfitte. Ho due ori e ho giocato sedici anni in Nazionale. Ho venti medaglie, ma solo due d’oro. Vedi quante volte sono arrivato vicino al traguardo finale. Spessissimo l’ultimo ostacolo era la Nazionale italiana! Quando tu vinci, crei delle aspettative per te stesso e nella gente intorno a te, e più vinci e meno si parla della vittoria, mentre se perdi si amplifica il clamore dopo la sconfitta. Quando una squadra non ha vinto niente e si consacra con una vittoria importante, al primo successo si crea una gioia incredibile, ma se avessi perso all’ultimo, visto che non era abituata a vincere, la sconfitta sarebbe stata compresa e ben metabolizzata.
Con le vittorie anche i giocatori acquisiscono consapevolezza di essere forti, ma al contempo le aspettative si alzano notevolmente. La gente comune e i tifosi non hanno contezza di quello che c’è dietro a ogni partita. Magari vedono una squadra a cui manca un titolare importante, ci giochi contro e vinci 3 a 0 per loro è scontato, ma non è sempre così, specie se di fronte hai un avversario forte come lo è l’Italia. Ogni partita fa storia a sé. Se il primo match vinci 3 a 0, dopo due giorni, con gli stessi giocatori, è molto difficile che riesci a ribadire quel risultato. È completamente un’altra partita.
Scorrendo il tuo nutrito palmarès vedo che ti manca solo una vittoria ai Mondiali.
La vittoria al Mondiale è l’unica che mi manca in carriera.
Ma arriverà prima o poi.
Spero di vincerlo con la Polonia nella prossima edizione.
Hai vissuto tante partite al tie-break. È un equilibrio molto sottile, una questione a volte di centimetri per un pallone che cade di qua o di là dalla riga. Come gestisci, da allenatore, queste situazioni che si giocano sul filo di lana?
Come gestisci una situazione dove fino al 22 pari del primo set Kamil Semeniuk ha avuto il 100 per cento di attacco efficiente in parallela in tutto il torneo? Contro l’Italia ha tirato una parallela fuori di un niente. Io quello che gli insegno è di pensare alla palla successiva, quella oramai è andata. Una volta finita la partita puoi ripensarci quanto vuoi, ma in quel momento non c’è il tempo per ripensare al punto sbagliato. I ragazzi devono subito concentrarsi sulla prossima azione. Se ti lasci influenzare dall’errore che hai fatto, poi non sarà solo uno, ma saranno due, tre o di più, finché non ritrovi l’equilibrio e continui a giocare, ma poi è tardi.
L’aspetto mentale è importante.
Moltissimo! C’è da dire anche questo: molte squadre hanno ottimi allenatori, ottimi giocatori, ottimo staff, ottime condizioni di lavoro. E lì non è che c’è un vantaggio per qualcuno, tutti sono allo stesso livello. Il vantaggio è solo come i giocatori interpreteranno il finale dei set e che rapporto avranno con un eventuale errore e con la pressione.
Nel tuo mestiere di commissario tecnico, quanto è importante la disciplina e la meticolosità nei dettagli per preparare una gara? La pretendi la disciplina dai tuoi giocatori?
Si parla spesso di disciplina e di motivazione. Sono due cose diverse, perché la motivazione è una cosa che dura molto poco. Se ti motivo ora sei carico, ma l’effetto non è duraturo. La disciplina invece ti mantiene a un certo livello nel lungo termine. Se tu non hai disciplina, non riesci a superare le difficoltà. Quando sei motivato puoi fare delle cose straordinarie, ma se il giorno dopo non hai la stessa carica agonistica o motivazione, non arriverai neanche vicino all’obiettivo. Invece la disciplina ti mantiene sempre lì. E non ti parlo della disciplina di ripetere le cose sempre alla stessa maniera tecnicamente, ma di una disciplina mentale. Dimenticare quello che c’è stato e concentrarti su quello che devi fare in quel momento lì.
Io sto cercando in tutte le maniere possibili di preparare i miei giocatori a fare queste cose qua, ad avere questo approccio, ma quando arrivi al finale dei set quello che devi fare è essere in grado di adattarti. Ai quarti di finale, in semifinale e in finale le squadre che incontri sono tutte molto forti, il meglio del meglio, con dei campioni che sono in grado di cambiare le carte in tavola istantaneamente. Tu prepari una cosa e loro iniziano con una cosa completamente diversa. L’avversario ci studia allo stesso modo e cercherà strategie alternative. Noi dobbiamo essere adattabili, adattarsi a quello che stanno facendo gli avversari.
L’allenamento alla disciplina mentale che insegni oggi ai tuoi atleti ha avuto una sua evoluzione rispetto a trent’anni fa?
Prima era un po’ diverso e oltretutto il nostro sport è cambiato. Se guardi le regole, è cambiato più di tutti gli altri sport messi insieme. Ti faccio un esempio delle cose che sono cambiate da quando io ho cominciato. Ai tempi si giocava con il cambio palla e quindi si poteva giocare all’eternità, perché se c’era un cambio palla continuo il punteggio rimaneva invariato. Alla lunga la preparazione fisica era determinante.
La tecnica aveva una sua importanza, perché se tu mantieni un certo livello di gioco per un lungo periodo di tempo, le squadre che non sono abituate o tecnicamente non eccelse, prima o poi sbagliano. Il 90% delle volte vinceva la squadra favorita. Era molto importante la pazienza. Adesso ci sono squadre che non sono tra le prime quindici al mondo che con una palla buona, se tu non batti bene, hanno un attacco straordinario. Loro attaccano, noi attacchiamo e in un attimo si arriva sul 23 pari e poi è un attimo perdere la partita. Questo adattamento oggi è diventato molto più importante, perché in un attimo può cambiare l’andamento del match.
È meglio come oggi oppure torneresti alle vecchie regole?
Oggi è molto più stressante, molto più complicato. I valori si sono avvicinati.
Sostieni Renovatio 21
Tu hai giocato quasi tutta la tua carriera nel campionato italiano. C’è un giocatore italiano con cui hai giocato che ti ha impressionato con il suo talento?
Ci sono dei giocatori che mi hanno impressionato. Ho giocato due anni con Samuele Papi, un anno con Gardini, un anno con Gravina, con Lorenzo Bernardi, con Pippi, con Giretto, con Simone Rosalba, con Bovolenta… Ho giocato con Andrea Gardini quando era a fine carriera e aveva già trentotto anni. Se proprio devo sceglierne uno ti direi Lorenzo. Anche Papi un fenomeno, però Lorenzo con la sua mentalità è stato uno dei più forti con cui ho giocato.
Il «divismo», peraltro vacuo, che c’è nel calcio, nella pallavolo non c’è. Oggi con i social e con la sovraesposizione mediatica il calcio gode di un overbooking di popolarità che sfocia nel gossip, nel pettegolezzo e a volte nel ridicolo. Nel vostro sport mi pare si avverta una purezza, un’integrità e una semplicità genuina.
In Polonia la pallavolo è sport nazionale ed è seguita più del calcio, ma rimane un mondo più sano. Non c’è paragone. Tu porti i figli a una gara di pallavolo ed è una festa. Sono rimasto sorpreso dalle tifoserie polacche: a fine partita si scambiano le sciarpe e c’è un momento di comunione. A memoria mia in Italia ricordo solo due brutti episodi con degli incidenti. Non c’è una minima preoccupazione nel portare i figli piccoli a una partita. Ci si insulta tra tifoserie, certo, ma finisce tutto lì. È quel tifo che potrei definire una sana terapia [ride]!
Visto che hai allenato la Sir di Perugia, oggi come la vedi?
Credo che adesso sia la squadra più forte al mondo, senza dubbio. È coperta in tutti i ruoli. Angelo Lorenzetti è un allenatore che ha vinto tutto, ha autorità, è preparato e la squadra lo segue, che ti devo dire di più? Ha dei grandissimi giocatori che oramai potrebbero giocare ad occhi chiusi. Vedremo Trento come arriverà alla fine della stagione o la Lube se torna a giocare come ha giocato fino a qualche mese fa, ma per ora Perugia è la squadra più solida.
Che consiglio daresti ai ragazzi che vorrebbero affacciarsi a questo sport?
Prima viene il divertimento. Se non ti diverti non va bene. Non puoi obbligare un ragazzino a fare un’attività fisica. Mi dici la percentuale dei ragazzini che amano andare a scuola? Molto bassa, anzi, io non ne conosco neanche uno.
Perché? Perché la scuola non è divertente, è un obbligo. Alcuni genitori vivono la loro ambizione tramite i figli. Se tu fai diventare l’attività fisica del figlio un obbligo, come alcuni genitori fanno magari per vantarsi con gli altri perché il proprio figlio fa quello sport in quella squadra, non va bene. I figli così si sentono soffocati, non gli piace, non si divertono.
Prima il divertimento, però è chiaro che a un certo punto questo viene trasformato, perché se vuoi continuare a livelli alti, c’è molto meno da divertirsi e molto più sacrificio. C’è la possibilità del trasferimento in un’altra città, lontano dalla famiglia e dagli amici oppure andare direttamente in un altro paese e avere difficoltà con la lingua. Più cresci e più questo divertimento si trasforma in lavoro – passami il termine – però pensa che bellissimo lavoro è. Giochi e ti diverti, perché questo sport, come altri del resto, è un gioco e ti pagano anche bene per farlo.
Facciamo un esempio: tu guadagni ottantamila euro l’anno, che per la pallavolo è un contratto normale. Dimmi che tipo di lavoro devi fare nella vita normale per guadagnare questa cifra. Forse un direttore di banca.
Se sei parsimonioso in dieci o quindici anni di carriera puoi accumulare un discreto tesoretto.
La problematica di questo mestiere è che non ti dà la pensione. Oggi forse qualche regola è cambiata, ma prima non avevi nulla dopo il termine della tua carriera. Devi essere bravo e indipendente nel saper investire i tuoi guadagni per il tuo futuro. Inoltre c’è da aggiungere che non tutti i giocatori diventano allenatori o manager e possono proseguire la loro carriera in questo sport. Lo sport è bellissimo.
Le sfide non finiscono in campo, ma proseguono anche dopo.
La vita è sempre in salita, prima accetti questo fatto e prima riesci a vivere meglio. Ma la vita è bella anche per questo. Noi siamo qua dove siamo ora, perché abbiamo dovuto combattere nella nostra quotidianità. Questo combattimento ci ha reso più forti. Se non avessi avuto tutte queste sfide nella vita – private e professionali – non sarei la persona che sono adesso. Le ho abbracciate e le ho accolte con grande soddisfazione. Si va sempre avanti, perché tutti i giorni puoi incontrare delle difficoltà e delle battaglie da combattere che sono tue e sono personali.
Grazie, Nikola!
Grazie a te!
Francesco Rondolini
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
L'articolo La pallavolo, la Jugoslavia, l’Italia, Djokovic, i vaccini, le Olimpiadi: Renovatio 21 intervista la leggenda del Volley Nikola Grbic proviene da RENOVATIO 21.
Il recente crimine verificatosi alla Stazione Termini e perpetrato da una ghenga di immigrati che ha lasciato in fin di vita un funzionario statale, non è altro che uno dei tanti episodi di violenza e spudorata prevaricazione che ormai da alcuni anni si verificano su treni e stazioni.
Le stazioni di treni, metro ed autobus in particolare possono ormai essere definite «non luoghi» per usare un concetto coniato dall’antropologo francese Marc Augé (1935-2023) ossia spazi privi d’identità, di valore relazionale e di storia. Non-luoghi dell’anarco-tirannia e gangli grandi suoi motori nel contesto urbano europeo, aggiungiamo noi.
Pensiamo alle grandi stazioni attorno alle quali gravitano in Italia e in tutta Europa, ceffi e genghe di ogni sorta pronte ad avventarsi sullo studente o sul pendolare di turno ma anche a piccole stazioni di paese, prive di personale ferroviario, fornite di biglietterie automatiche e sostanzialmente non sottoposte ad alcun tipo di controllo.
Pensiamo anche al fatto che molti di noi prendono il treno per andare a lavorare, per ragioni personali o anche solo per una gita fuoriporta. Quasi tutti prima o poi passano da una stazione o prendono un mezzo pubblico.
Aiuta Renovatio 21
Per cui il pendolare, spesso e volentieri esponente di una classe media lavoratrice oppressa da tasse, balzelli e multe di ogni genere si trova a dover temere per la vita sua o dei suoi cari, a causa di un vero e proprio percorso di guerra giornaliero in cui può incappare in belve su due gambe che anche lui mantiene con i suoi contributi.
Quindi potremmo definire le stazioni non-luoghi fondamentali dell’anarcotirannia, spazi in cui si ricorda al cittadino onesto che la sua vita è esposta ad un pericolo inimmaginabile fino a qualche anno fa, tanto nelle grandi città quanto in quella che abbiamo più volte definito «provincia sonnacchiosa».
Molte stazioni, soprattutto durante gli orari notturni appartengono ormai anche alle cosiddette «no go-zone», quei luoghi in cui lo Stato anarcotirannico abdica a sè stesso, non riesce a controllare o decide scientemente di non farlo, dicendo praticamente ai cittadini «lasciate ogni speranza voi che entrate».
Ed ecco che la stessa libertà di movimento, di uscire di casa e vivere la propria vita, sparisce completamente ed ecco che molti pianificano viaggi che non arrivino a destinazione la notte per evitare guai con conseguente dispendio di denaro e di tempo.
Sappiamo bene che il potere anarcotirannico non è alieno a ciò, basti pensare ai lockdowns della dittatura biotica di cui abbiamo parlato negli anni passati, considerando che anche alle bestie selvatiche si lascia la libertà di andarsene in giro per la foresta. Oggi anche le belve hanno più libertà e più importanza di noi basti pensare a quanti lupi scorrazzino indisturbati fuori dalle nostre case.
Lo abbiamo scritto più volte, il problema ha ormai risvolti di controllo, reale, pratico del territorio, quindi di tipo militare, sembra però che nessuno sia disposto a farsene carico.
E torniamo a parlare anche di necrocultura, perché l’anarcotirannia è intimamente collegata ad essa, ne è parte integrante. Come sempre le vittime da sacrificare, le vittime designate siete voi. Qualcuno, da qualche parte vi vuole morti, vuole la vostra rovina.
Ancora una voltra: siete disposti ad accettarlo?
Victor García
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di AMANO Jun-ichi via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 3.0 Unported
L'articolo Le stazioni, i non-luoghi dell’anarco-tirannia proviene da RENOVATIO 21.
Renovatio 21 traduce questo articolo per gentile concessione di Children’s Health Defense. Le opinioni degli articoli pubblicati non coincidono necessariamente con quelle di Renovatio 21.
Il mese scorso, il Centro per la Valutazione e la Ricerca sui Prodotti Biologici della FDA ha inviato avvisi a diverse aziende produttrici di vaccini, tra cui Sanofi, AstraZeneca, GSK e CSL Seqirus, chiedendo loro di aggiungere l’avvertenza. L’agenzia ha citato studi che mostrano un aumento del rischio di convulsioni febbrili il giorno successivo alla vaccinazione.
La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti vuole che i vaccini antinfluenzali riportino un’avvertenza che le iniezioni possono causare convulsioni febbrili nei bambini piccoli.
La scorsa settimana, il Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) dell’agenzia ha inviato avvisi a diversi produttori di vaccini, tra cui Sanofi, AstraZeneca, GSK e CSL Seqirus, chiedendo loro di aggiungere l’avvertenza.
Il CBER ha citato due studi osservazionali post-marketing da lui condotti, dai quali è emerso che i bambini di età compresa tra 6 mesi e 4 anni hanno un rischio maggiore di convulsioni febbrili il giorno successivo alla vaccinazione.
La FDA ha proposto questa formulazione per le etichette dei vaccini:
«In due studi osservazionali post-marketing separati, è stato osservato un aumento del rischio di convulsioni febbrili durante il primo giorno successivo alla vaccinazione con vaccini antinfluenzali trivalenti (2024-2025) e quadrivalenti (2023-2024) a dose standard nei bambini di età compresa tra 6 mesi e 4 anni».
Sostieni Renovatio 21
L’avvertenza verrebbe aggiunta alle etichette dei vaccini FluMist di AstraZeneca, Fluarix di GSK, FluLaval di ID Biomedical, Fluzone di Sanofi Pasteur e Afluria e Flucelvax di Sequiris.
I produttori di vaccini hanno 30 giorni di tempo per accettare l’aggiornamento dell’etichetta proposto, proporre modifiche o presentare una confutazione.
Un portavoce di Sanofi ha dichiarato a Fierce Pharma che le convulsioni febbrili si sono verificate solo in un «sottogruppo limitato di pazienti» e che l’azienda include già informazioni su tali convulsioni nell’etichetta di Fluzone.
GSK ha dichiarato a Fierce Pharma che l’azienda sta esaminando la richiesta della FDA e che è «fiduciosa» nel «profilo di sicurezza ed efficacia» dei suoi vaccini antinfluenzali.
Le convulsioni febbrili sono convulsioni spesso causate da febbre scatenata da infezioni correlate a comuni malattie infantili. Le convulsioni si verificano in genere nei bambini di età compresa tra 6 mesi e 5 anni, quando la temperatura supera i 38 °C.
La maggior parte delle convulsioni febbrili dura meno di 15 minuti e non è pericolosa per la vita. Secondo Medpage Today, «non causano danni permanenti e non hanno effetti duraturi».
Brian Hooker, Ph.D., direttore scientifico di Children’s Health Defense (CHD), non è d’accordo. «Qualsiasi crisi epilettica è negativa, punto e basta», ha affermato.
«Le convulsioni febbrili “lievi” possono raddoppiare le probabilità che un bambino riceva una diagnosi di epilessia, mentre le convulsioni febbrili ‘complesse’, che durano più di 15 minuti, possono aumentare tale rischio fino a 10 volte», ha affermato Hooker.
Karl Jablonowski, Ph.D., ricercatore senior del CHD, ha affermato: «L’intera teoria a sostegno dell’ammissibilità delle convulsioni febbrili post-vaccinazione si basa su un’idea: che siano innocue».
Jablonowski ha affermato che alcuni studi, tra cui una revisione del 2023 pubblicata su Frontiers in Cell and Developmental Biology, indicano che potrebbe non essere così. La revisione ha dimostrato che “le convulsioni febbrili che si verificano durante lo sviluppo neurologico… possono ‘in ultima analisi portare alla malattia'”, ha affermato.
La revisione «mette in evidenza in particolare l’ADHD [disturbo da deficit di attenzione/iperattività], l’epilessia e il declino cognitivo in età adulta», ha affermato.
Hooker ha suggerito che affermare che le convulsioni febbrili sono innocue aiuta a normalizzare un infortunio che può causare danni più ampi ai bambini, in particolare a quelli con altri problemi di salute.
«È disgustoso come le reazioni ai vaccini vengano minimizzate e normalizzate dalle grandi aziende farmaceutiche», ha detto Hooker. »Troppi bambini vengono danneggiati – il tasso di convulsioni nelle persone autistiche può raggiungere il 20% – e il danno viene nascosto sotto il tappeto».
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Il CBER ha valutato i vaccini antinfluenzali per due stagioni di raffreddore e influenza tra il 2023 e il 2025. L’agenzia ha analizzato i dati delle compagnie assicurative per confrontare l’incidenza delle convulsioni febbrili nei bambini dai 6 mesi ai 4 anni nel primo giorno successivo alla vaccinazione, con l’incidenza di tali convulsioni tra gli 8 e i 63 giorni successivi alla vaccinazione.
Secondo il CBER, i dati indicavano un tasso di eccesso stimato di 21,2 convulsioni febbrili per milione di vaccini antinfluenzali quadrivalenti a dose standard e 44,2 convulsioni extra a seguito della somministrazione di vaccini trivalenti.
Uno studio del 2012 condotto su bambini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni ha rilevato un aumento del rischio di convulsioni febbrili nelle 24 ore successive alla somministrazione concomitante di un vaccino antinfluenzale inattivato e del vaccino pneumococcico coniugato 13-valente (PCV13 o polmonite) o del vaccino contro difterite, tetano e pertosse acellulare (DTaP).
La dottoressa Meryl Nass, ex medico internista e fondatrice di Door to Freedom, concorda sul fatto che i vaccini antinfluenzali comportino un rischio di convulsioni febbrili. Tuttavia, ha affermato, altri vaccini, tra cui quello contro morbillo-parotite-rosolia (MPR), presentano un rischio ancora maggiore.
L’anno scorso, il Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione (ACIP), che fornisce consulenza ai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) in materia di politica vaccinale, ha votato per non raccomandare più il vaccino MMRV (morbillo-parotite-rosolia-varicella) per i bambini di età inferiore ai 4 anni.
Il voto dell’ACIP è seguito a una presentazione contenente prove di un aumento del rischio di convulsioni febbrili in seguito alla somministrazione del vaccino MMRV.
In uno studio del 2024 pubblicato su JAMA Network Open, i ricercatori della FDA hanno rilevato un segnale di sicurezza per le convulsioni nei bambini piccoli a seguito della vaccinazione mRNA contro il COVID-19. La maggior parte delle convulsioni era febbrile.
Un segnale di sicurezza è un segnale che un evento avverso potrebbe essere causato dalla vaccinazione, ma sono necessarie ulteriori ricerche per verificare tale collegamento.
In una pre-stampa pubblicata all’inizio del 2024, i ricercatori della FDA hanno scoperto che i bambini di età compresa tra 2 e 5 anni che avevano ricevuto il vaccino mRNA contro il COVID-19 presentavano un rischio maggiore di convulsioni febbrili subito dopo la vaccinazione.
Nass ha messo in dubbio l’utilizzo da parte del CBER di studi osservazionali per trarre le sue conclusioni.
«Ciò di cui abbiamo bisogno sono alcuni studi prospettici di sorveglianza attiva per ottenere dati reali sui tassi di convulsioni febbrili e altri problemi nei bambini piccoli». Ha affermato che questi problemi spesso non vengono rilevati negli studi retrospettivi sulle cartelle cliniche.
Aiuta Renovatio 21
La comunicazione del CBER ai produttori di vaccini antinfluenzali è arrivata pochi giorni dopo che il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha apportato modifiche radicali al calendario delle vaccinazioni infantili, riducendo il numero di vaccini raccomandati per tutti i bambini da 17 a 11.
Nell’ambito di tali cambiamenti, i vaccini antinfluenzali non sono più raccomandati per tutti i bambini. Al contrario, il CDC ora raccomanda la condivisione delle decisioni cliniche tra medici e genitori.
L’anno scorso, l’ACIP ha votato per non raccomandare più i vaccini antinfluenzali contenenti timerosal, un conservante a base di mercurio associato a disturbi dello sviluppo neurologico.
Uno studio condotto dalla Cleveland Clinic su 53.402 adulti lo scorso anno ha scoperto che le persone che si erano vaccinate contro l’influenza durante la stagione del raffreddore e dell’influenza dell’anno precedente avevano il 27% di probabilità in più di contrarre l’influenza.
Michael Nevradakis
Ph.D.
© 16 gennaio 2026, Children’s Health Defense, Inc. Questo articolo è riprodotto e distribuito con il permesso di Children’s Health Defense, Inc. Vuoi saperne di più dalla Difesa della salute dei bambini? Iscriviti per ricevere gratuitamente notizie e aggiornamenti da Robert F. Kennedy, Jr. e la Difesa della salute dei bambini. La tua donazione ci aiuterà a supportare gli sforzi di CHD.
Renovatio 21 offre questa traduzione per dare una informazione a 360º. Ricordiamo che non tutto ciò che viene pubblicato sul sito di Renovatio 21 corrisponde alle nostre posizioni.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
L'articolo La FDA chiede un avvertimento sui vaccini antinfluenzali riguardo al rischio di convulsioni febbrili nei bambini proviene da RENOVATIO 21.
I parlamentari conservatori stanno attaccando duramente il primo ministro canadese Mark Carney dopo che, durante un viaggio nella Cina comunista, ha dichiarato di essere «rincuorato dalla leadership» del presidente Xi Jinping e che la collaborazione tra le due nazioni prepara il terreno per un «Nuovo Ordine Mondiale». Lo riporta LifeSite.
Giovedì il Carney, insieme ai suoi principali ministri, ha incontrato il premier cinese Li Qiang e ha commentato che le due nazioni possono essere «partner strategici» su questioni come la «sicurezza».
«Credo che i progressi compiuti nella partnership ci preparino bene per il Nuovo Ordine Mondiale».
WATCH: Today in Beijing, PM Mark Carney says he is “heartened by the leadership” of the Chinese dictator, that Canada and Communist China can be “strategic partners” – including on “issues of security” – and invokes the “New World Order.” pic.twitter.com/D5ROsBbqJA
— Juno News (@junonewscom) January 15, 2026
Aiuta Renovatio 21
La reazione online ai commenti di Carney è stata immediata da parte dei conservatori canadesi. Barbara Bal, candidata conservatrice alle ultime elezioni, ha osservato come le osservazioni di Carney dimostrino che i teorici della «cospirazione» sul Nuovo Ordine Mondiale potrebbero aver avuto ragione fin dall’inizio.
Non si tratta ad ogni modo del primo politico che cita il Nuovo Ordine Mondiale in un discorso ufficiale.
Molti politici hanno pronunciato la locuzione «Nuovo Ordine Mondiale» («New World Order») nei loro discorsi, quasi sempre in senso geopolitico e non cospirativo.
Il caso più celebre resta George H.W. Bush (1990-91), che la usò ripetutamente per descrivere la cooperazione internazionale post-Guerra Fredda e la risposta all’invasione del Kuwait: «un mondo in cui le nazioni si riuniscono per difendere la legge».
In epoca recente l’ex segretario di Stato USA Henry Kissinger (1923-2023) ha dedicato libri e interventi proprio al tema del Nuovo Ordine mondiale, inteso come riorganizzazione degli equilibri tra grandi potenze.
Tra i leader europei e italiani l’espressione è apparsa sporadicamente, spesso legata a crisi globali o assetti post-1989. I primi ministri italiani Giuseppe Conte e Mario Draghi hanno parlato di «Nuovo Ordine Mondiale» in chiave economica-finanziaria durante la pandemia e la guerra in Ucraina, evocando la necessità di riformare governance globale e multilateralismo.
Anche il premier magiaro Viktor Orbán ha usato l’espressione in chiave critica, attaccando élite globaliste. In Italia la formula resta rara tra i big (Berlusconi, Renzi, Meloni, Prodi non risultano averla usata in modo centrale), ma circola nei dibattiti di politica estera.
Come riportato da Renovatio 21, di Nuovo Ordine Mondiale parlarono apertis verbis, usando proprio questa espressione in accezione chiaramente positiva, l’esponente del PD di origine ebraica Emanuele Fiano e pure il capo sindacalista Landini.
1 MAGGIO 2022.
Landini parla di NUOVO ORDINE MONDIALE spudoratamente…non riesco a crederci… pic.twitter.com/z6ye0x0iH6
— Jack Doson (@JacPr4185774) May 2, 2022
Sostieni Renovatio 21
L’espressione fu usata, forse con significati opposti, anche da Joseph Ratzinger, sia quando era cardinale che quando poi divenne romano pontefice.
Di «Nuovo Ordine Mondiale» ha parlato di recente anche il servizio segreto estero tedesco (BND) per descrivere i piani della Russia «nostro nemico».
L’argomento è stato trattato in vari discorsi ed omelie dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò, che condanna il diabolico progetto arrivando poi a parlare di una chiesa di Roma «concubina del Nuovo Ordine Mondiale» e con una gerarchia divenuta sua serva per l’instaurazione di una Religione dell’Umanità massonica. Per il monsignore, la «sinodalità» della nuova chiesa è una menzogna al servizio del piano ordinovista.
«Opponiamo il Vangelo all’ideologia di morte del Nuovo Ordine Mondiale. Rifondiamo gli Stati sulla roccia che è Cristo Signore» ha detto due anni fa al al Secondo Congresso del Movimento Russofilo Internazionale. In altre occasione ha accusato «la Sinarchia massonica del Nuovo Ordine Mondiale» e la storica infiltrazione del Vaticano».
Viganò ha definito la vittoria elettorale di Trump come una «battuta d’arresto per il piano criminale del Nuovo Ordine Mondiale», una vera «controrivoluzione» contro la tirannide ordinovista, mentre l’Europa delirante e guerrafondai si muove verso il Nuovo Ordine.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di Policy Exchange via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 2.0 Generic
L'articolo Il primo ministro canadese menziona il «Nuovo Ordine Mondiale» mentre elogia la partnership con la Cina proviene da RENOVATIO 21.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sottolineato con fermezza che la scelta di non procedere con il bombardamento dell’Iran è stata esclusivamente sua e non ha subito pressioni da parte di alcun Paese terzo.
Trump aveva lanciato ripetute minacce di intervento militare contro la Repubblica Islamica nel pieno delle violente proteste che stanno attraversando l’Iran. I disordini sono esplosi a fine dicembre, inizialmente scatenati dalle gravi difficoltà economiche e dall’inflazione galoppante, per poi evolversi in un movimento di protesta antigovernativa su scala nazionale, con un bilancio di centinaia di morti. Rivolgendosi direttamente ai manifestanti all’inizio della settimana, il presidente aveva dichiarato: «Gli aiuti stanno arrivando».
Mercoledì l’agenzia Reuters aveva riportato che un attacco statunitense contro l’Iran appariva «imminente». L’operazione, tuttavia, non si è mai concretizzata e, in seguito, vari media americani hanno riferito che alti rappresentanti di Qatar, Arabia Saudita, Oman, Egitto e Israele avevano chiesto a Trump di rinunciare al piano.
Interpellato venerdì dai giornalisti su tali indiscrezioni, Trump ha replicato: «Nessuno mi ha convinto. Mi sono convinto da solo».
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Secondo quanto affermato dal presidente, un fattore decisivo è stato il «grande impatto» prodotto dall’inversione di rotta da parte dell’Iran, che aveva inizialmente annunciato processi sommari e impiccagioni rapide per alcuni dei manifestanti più violenti arrestati, salvo poi annullare tutto.
«Ieri avevate programmato oltre 800 impiccagioni. Non hanno impiccato nessuno. Hanno annullato le impiccagioni», ha spiegato Trump. «Rispetto molto il fatto che abbiano annullato tutto», ha aggiunto.
Mercoledì il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, intervistato da Fox News, aveva dichiarato che non ci sarebbero state «impiccagioni né oggi né domani». Araghchi ha inoltre sostenuto che la calma è tornata nelle città iraniane, con il governo che mantiene il pieno controllo della situazione, e ha attribuito i disordini a Israele e a interferenze esterne.
Alla domanda se la sua promessa di sostegno ai manifestanti iraniani resti ancora valida, Trump ha risposto: «Vedremo».
Nonostante la rinuncia all’attacco aereo, gli Stati Uniti hanno comunque inviato almeno una portaerei verso il Medio Oriente, come riportato venerdì da Fox News sulla base di fonti militari. Secondo l’emittente, Washington dispone già nella regione di tre cacciatorpediniere e tre navi da combattimento litoranee.
All’inizio della settimana gli Stati Uniti hanno inoltre varato nuove sanzioni contro l’Iran, colpendo cinque funzionari della sicurezza accusati di aver partecipato alla «violenza e alla crudele repressione» dei manifestanti, una prigione del Paese e altri 18 individui ed entità sospettati di aver aiutato Teheran a aggirare le restrizioni sul commercio di petrolio.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di pubblico dominio CC0 via Flickr
L'articolo Trump: «mi sono convinto da solo» a non bombardare l’Iran proviene da RENOVATIO 21.
Con l’arrivo del nuovo anno in India, la comunità cristiana si trova ad affrontare una crescente ondata di persecuzioni, caratterizzata da episodi di violenza e arresti arbitrari. Secondo recenti resoconti pubblicati dai media cattolici, gli attacchi contro i cristiani sono aumentati, in particolare la domenica e durante le festività natalizie.
La «tregua di Natale» non ha avuto luogo sulle rive del Gange… Nell’Uttar Pradesh, lo stato più popoloso dell’India, la polizia ha arrestato dieci cristiani, tra cui diverse donne, il 14 dicembre 2025, durante un incontro di preghiera domenicale nel distretto di Mirzapur.
Il motivo? Una presunta violazione della legge anti-conversione dello Stato, che prevede fino a vent’anni di carcere per le conversioni effettuate con coercizione o induzione. Le autorità hanno sequestrato Bibbie, quaderni e telefoni cellulari. Nel vicino distretto di Jaunpur, altri due cristiani sono stati arrestati lo stesso giorno e posti in custodia cautelare.
Nel Rajasthan (Nord-Ovest del Paese), attivisti indù hanno interrotto una messa – sempre il 14 dicembre – celebrata nella chiesa cattolica di San Giuseppe a Bichhiwara, nel distretto di Dungarpur. Gli estremisti hanno accusato il sacerdote, padre Rajesh Sarel, di aver convertito con la forza gli indiani delle caste inferiori.
Questa intrusione avviene dopo l’adozione, il 9 settembre 2025, di una legge anti-conversione ancora più severa nel Rajasthan, che inverte l’onere della prova e incoraggia azioni legali abusive contro le minoranze.
Sostieni Renovatio 21
La Conferenza episcopale cattolica indiana (CBCI) ha espresso il suo «profondo sgomento» per questo «allarmante aumento» degli attacchi, in una dichiarazione pubblicata il 23 dicembre. I prelati indiani hanno denunciato la violenza come un attacco alla libertà religiosa, teoricamente garantita dalla Costituzione indiana.
Tra i fatti riportati nella dichiarazione della conferenza episcopale c’è un incidente avvenuto a Jabalpur, nel Madhya Pradesh, dove Anju Bhargava, vicepresidente locale del BJP (il partito nazionalista al governo), ha molestato un fedele ipovedente pochi giorni prima di Natale.
La violenza ha raggiunto il culmine durante le celebrazioni natalizie. Il 24 dicembre, nello stato nord-orientale dell’Assam, una ventina di uomini affiliati al Vishwa Hindu Parishad (VHP) e al Bajrang Dal – gruppi nazionalisti indù – hanno invaso e vandalizzato la scuola cattolica St. Mary a Panigaon, nel distretto di Nalbari.
Questi eventi sono in netto contrasto con i gesti ufficiali del primo ministro Narendra Modi, che ha partecipato alla funzione natalizia il 25 dicembre presso la Cattedrale della Redenzione a Nuova Delhi. Il giorno X, il capo del governo nazionalista indù ha persino augurato ai cristiani un Natale pieno di speranza e gentilezza.
Il cardinale Baselios Cleemis, arcivescovo maggiore della Chiesa cattolica siro-malankarese, ha criticato questa dissonanza: «da una parte, Modi scambia saluti con i rappresentanti cristiani; dall’altra, gli attacchi persistono», ha affermato l’alto prelato, che ha segnalato altri incidenti, come l’aggressione a un gruppo di cantori di canti natalizi in Kerala da parte di un militante indù, e gli inviti all’odio contro i cristiani in Chhattisgarh.
I cristiani, che rappresentano meno dell’1% della popolazione nell’Uttar Pradesh e nel Rajasthan (dove gli indù sono la maggioranza, con oltre l’80%), si sentono vulnerabili: «essere cristiani è diventato difficile; si può essere arrestati per una semplice preghiera o per il possesso di una Bibbia», racconta un credente.
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di Prime Minister’s Office, Government of India via Wikimedia pubblicata su licenza Government Open Data License – India (GODL); immagine tagliata
L'articolo India: nessuna tregua per i cristiani a Natale proviene da RENOVATIO 21.
Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano Masoud Pezeshkian, mentre la Repubblica Islamica è ancora attraversata da vaste proteste popolari scoppiate nelle ultime settimane.
I disordini sono iniziati verso la fine del mese scorso, provocati principalmente dall’impennata dell’inflazione e dal crollo verticale del valore del rial iraniano. Le manifestazioni si sono presto trasformate in scontri violenti con le forze dell’ordine, con un bilancio – secondo diverse fonti – di centinaia di vittime. Le autorità di Teheran hanno accusato Stati Uniti e Israele di essere i veri artefici delle rivolte.
In una nota diffusa venerdì dal Cremlino si legge che Pezeshkian «ha informato Vladimir Putin sui continui sforzi del governo iraniano per normalizzare la situazione nel Paese».
I due capi di Stato hanno concordato sulla necessità di una «de-escalation delle tensioni in Iran e nella regione nel suo complesso il prima possibile», sottolineando che «ogni problema emergente deve essere risolto esclusivamente attraverso mezzi politici e diplomatici».
Aiuta Renovatio 21
Putin e Pezeshkian hanno inoltre riaffermato «il loro reciproco impegno a rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra Russia e Iran», con particolare attenzione ai progetti economici congiunti in corso.
La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, intervenendo questa settimana, ha dichiarato che Mosca «condanna fermamente le interferenze straniere destabilizzanti» negli affari interni iraniani. Secondo la diplomatica, alcune potenze estere avrebbero cercato di trasformare una protesta inizialmente pacifica in «disordini crudeli e insensati», con l’obiettivo di provocare un cambio di regime a Teheran.
La Zakharova ha definito «assolutamente inaccettabili» le minacce statunitensi di ricorrere alla forza contro la Repubblica Islamica, avvertendo che un intervento militare contro l’Iran rischierebbe di destabilizzare l’intero Medio Oriente.
La stessa portavoce ha inoltre attribuito le attuali difficoltà economiche iraniane principalmente alle sanzioni imposte dall’Occidente.
Negli ultimi giorni il presidente statunitense Donald Trump ha rivolto ripetute minacce all’Iran, esortando i manifestanti a impadronirsi delle istituzioni statali. All’inizio della settimana il leader americano ha dichiarato che la sua amministrazione stava «valutando alcune opzioni molto forti» per intervenire contro Teheran.
L’Iran rappresenta da lungo tempo un alleato strategico della Russia: i due Paesi hanno formalizzato un accordo di partenariato strategico in occasione della visita di Pezeshkian a Mosca lo scorso gennaio.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di President of Russia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
L'articolo Putin parla con il presidente iraniano Pezeshkian proviene da RENOVATIO 21.
Gli Stati Uniti hanno dispiegato almeno una portaerei verso il Medio Oriente, come riportato da Fox News citando fonti militari anonime. La mossa segue le minacce velate lanciate negli ultimi giorni dal presidente Donald Trump contro l’Iran.
La Repubblica Islamica è scossa da proteste di massa iniziate alla fine di dicembre, scatenate dal malcontento popolare per l’inflazione galoppante e il crollo del valore del rial iraniano. Le manifestazioni si sono rapidamente trasformate in scontri violenti con le forze di sicurezza, con un bilancio che, secondo varie fonti, ammonterebbe a centinaia di morti. Teheran ha accusato Stati Uniti e Israele di essere i responsabili dell’agitazione.
Giovedì, Fox News ha indicato che la nave da guerra diretta nella regione potrebbe essere la USS Abraham Lincoln o una delle due portaerei salpate di recente da Norfolk e da San Diego. L’emittente ha precisato che, al momento, gli Stati Uniti dispongono già nella zona di tre cacciatorpediniere e tre navi da combattimento litoranee.
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Fonti anonime hanno riferito al network che Washington intende probabilmente rafforzare ulteriormente la propria presenza militare intorno all’Iran, con l’invio di capacità di attacco aereo e terrestre, oltre a sistemi di difesa missilistica, nei prossimi giorni e settimane. Funzionari non identificati hanno descritto l’operazione come un «rafforzamento della forza», che metterebbe il presidente in condizione di autorizzare un’azione militare «offensiva» se lo ritenesse opportuno.
Sempre giovedì, la NBC, basandosi su diverse fonti informate, ha riportato che Trump stava considerando l’ipotesi di un colpo rapido e decisivo contro il governo iraniano, preferendolo a un coinvolgimento prolungato in un conflitto. Poiché i suoi consiglieri non sarebbero in grado di assicurare che un intervento armato porterebbe a un immediato rovesciamento delle autorità di Teheran, il presidente si è finora mostrato cauto nel dare l’ordine di attacco, secondo quanto riferito dalla rete.
Come riportato da Renovataio 21, diversi Paesi del Golfo avrebbero contattato privatamente Trump per cercare di dissuaderlo da un’azione militare contro l’Iran, temendo un’instabilità regionale più ampia e gravi ripercussioni sul mercato globale del petrolio.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di pubblico dominio CC0 via Wikimedia
L'articolo Portaerei statunitense diretta in Medio Oriente proviene da RENOVATIO 21.






© RaiNews
Ci sono giornali che fondano un regime, come la Repubblica e la sua “una certa idea dell’Italia”, e regimi che fondano giornali, come la sec... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Analisti assennati e di buonsenso, quelli invitati ritualmente ai talk televisivi, ci spiegheranno che occorre guardare con fiducia all’iniziativa di pace di Donald Trump per Gaza. La realtà è ben […]
The post Business e sicurezza: il Board che deciderà il futuro della Striscia first appeared on il manifesto.
E’ una teoria per certi versi simile alla processione di vergini e martiri dei mosaici ravennati di Sant’Apollinare Nuovo, evocati nelle prime pagine del volume per testimoniare la diffusione del […]
The post I teatri delle passioni nella griglia dell’Urbe first appeared on il manifesto.
La gente di Gaza assiste stanca allo spettacolo internazionale di dichiarazioni, promesse, autocelebrazioni e strette di mano. Ci si potrà permettere di festeggiare a Washington o nelle rispettive sedi – […]
The post Galà coloniale, i palestinesi di Gaza non hanno nulla da festeggiare first appeared on il manifesto.
Baracche, degrado, criminalità. Nulla di questo sopravvive al primo sguardo al Villaggio delle Rose, alle porte sud di Milano. Qui, da oltre venticinque anni, cinquanta famiglie rom harvati vivono in […]
The post Il Villaggio modello rom che Milano vuole cancellare first appeared on il manifesto.
In Minnesota si stanno decidendo le sorti di ciò che resta della democrazia americana. Il regime Maga ha fatto del gelido e tranquillo stato del Midwest il banco di prova […]
The post Minneapolis, l’atto di forza di Trump contro sindaco e governatore first appeared on il manifesto.
Quarantasette anni fa oggi, Mohammad Reza Pahlavi, l’ex scià dell’Iran, lasciò il Paese per sempre. Quarantasette anni fa oggi, anche io e la mia famiglia lasciammo l’Iran, senza sapere che […]
The post L’ipocrisia di Israele: ciechi di fronte a Gaza, ora invocano libertà first appeared on il manifesto.
Il presidente dell’Uganda Yoweri Museveni ha vinto le elezioni fa con una percentuale di poco superiore al 71%, assicurandosi così il settimo mandato presidenziale. Museveni, 81 anni, è in carica […]
The post Uganda, Wine: «Sono riuscito a fuggire». E denuncia brogli elettorali first appeared on il manifesto.
Guido Piovene, oltre che raffinato romanziere e saggista, è stato un affermato giornalista, cimentatosi soprattutto con il genere, a lui molto congeniale, del reportage. Basti pensare ai servizi realizzati per […]
The post Guido Piovene, giornate senza umorismo in Polonia e in Ungheria first appeared on il manifesto.
Studiosa di occultismo, pittrice, autrice di poesie, romanzi, saggi e guide di viaggio, Ithell Colquhoun ha legato, nel corso degli anni Trenta, la sua produzione artistica di stampo britannico al […]
The post Ithell Colquhoun, lo zio-stregone, l’isola fatata e la prigioniera senza nome first appeared on il manifesto.
Dallo scorso 8 gennaio in Iran non è possibile connettersi a risorse internet al di fuori del paese. Il blocco imposto dal regime, però, potrebbe diventare strutturale. Secondo gli attivisti […]
The post Iran, dalla censura dei contenuti all’«internet sovrano». E non per tutti first appeared on il manifesto.
Tenace fautrice di uno sperimentalismo verbale a un tempo lirico e visionario, Herta Müller non ha mai nascosto la propria insofferenza nei confronti delle espressioni generiche, non trasfigurate dalla percezione […]
The post Herta Müller, la vita nell’ipotesi che verrà un altrove first appeared on il manifesto.
Autobiografia camuffata da romanzo, in cui tutto è vero ma suona come fosse una finzione, Lika – la quinta parte, pubblicata separatamente nel 1933, della Vita di Arsen’ev, la più […]
The post Bunin, giovane editor incontra i sensi del borioso poeta first appeared on il manifesto.
Nel titolo di una silloge si addensano spesso i significati profondi della personalità di un autore o, addirittura, di un’intera epoca letteraria. Pare che ad Alessandria d’Egitto fosse seppellito sotto […]
The post Ungaretti, Porto Sepolto, dialogo stretto con i francesi first appeared on il manifesto.
Nel 1983, la rivista «Granta» pubblicò per la prima volta la lista dei venti migliori scrittori inglesi sotto i quarant’anni: era, ai tempi, una proposta innovativa, non una hit parade, […]
The post Isabella Hammad, l’eco della Storia esonda fuori scena first appeared on il manifesto.
Il centrodestra ha posto una pistola sul tavolo del confronto con le opposizioni sulla legge elettorale. Prima ancora che esso sia convocato. Preventivamente, come una minaccia, che è stata esplicitata. […]
The post Legge elettorale, il ricatto del governo alle opposizioni first appeared on il manifesto.
Dalla mostra Jacques-Louis David, aperta fino al 26 gennaio al Louvre, si esce con una ferma convinzione: nella storia della pittura francese – da Poussin a Matisse, passando per Courbet […]
The post Jacques-Louis David, politico non solo, dal fuoco giacobino al sogno borghese first appeared on il manifesto.
Il Portogallo va alle urne oggi per scegliere il prossimo presidente della Repubblica. Contrariamente a quanto accaduto negli ultimi quarant’anni, quando il capo dello Stato veniva eletto al primo turno […]
The post Presidenziali in Portogallo, l’estrema destra ci spera first appeared on il manifesto.
Canadese, nato nel 1973, regista, sceneggiatore e produttore, Denis Côté è autore di un cinema ibrido che sfugge alle classificazioni, che ama i personaggi marginali raccontandoli con un realismo venato […]
The post Denis Côté, «Il mio cinema resistente, all’attacco delle belle immagini» first appeared on il manifesto.
Fine della «coalizione magenta» nel Brandeburgo. È durato appena un anno e un mese lo «storico» governo fra la Spd e il Bsw di Sahra Wagenknecht. A innescare l’insanabile crisi […]
The post Germania: sinistra, fallisce l’alleanza magenta. E l’Afd avanza first appeared on il manifesto.
«Abbiamo sempre dato, e stiamo dando, la nostra piena disponibilità ad avere un ruolo di primo nel progetto di pace in Medio Oriente». La premier Giorgia Meloni ha confermato, di […]
The post Gaza, Meloni: «Dall’Italia piena disponibilità». E a Palazzo Chigi arriva l’invito first appeared on il manifesto.
«Oggi all’una del pomeriggio brucerò un Corano sulle scale del comune di Minneapolis. L’America è un paese cristiano, non permetteremo ai pirati somali di conquistare Minneapolis». È l’ultimo post su […]
The post «Brucerò il Corano»: la “protesta” di Jake Lang first appeared on il manifesto.
«Il governo Meloni ha sbagliato i calcoli, il popolo resiste e rilancia»: così si chiudono le 5 ore di assemblea nazionale lanciata da Askatasuna. La risposta è arrivata ieri, un […]
The post Torino, Askatasuna annuncia «l’alba di un nuovo movimento sociale» first appeared on il manifesto.
Dopo venticinque anni di negoziati tesi, ieri a Asunción, in Paraguy, è stato firmato l’accordo commerciale di libero scambio tra l’Europa e i Paesi Mercosur (Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay). […]
The post Mercosur, intesa firmata. Nella Ue strada in salita first appeared on il manifesto.
Dall’assemblea nazionale di Italia viva, tenutasi a Milano, Matteo Renzi rivendica il lavoro fatto in questi anni. «La cosa più difficile è stata il nostro posizionamento nel centrosinistra. Oggi ne […]
The post Renzi a Milano: «Adesso serve la Margherita 4.0» first appeared on il manifesto.
La mostra Dessins des Carrache La fabrique de la Galerie Farnèse (in corso al Louvre, fino al 2 febbraio) procede à rebours: parte dalla fortuna critica della Galleria nella Francia […]
The post Carracci, disegni-prodigio fra natura e Idea first appeared on il manifesto.
«Greenland is not for sale» hanno gridato le piazze ieri mattina in Danimarca alle quali hanno fatto eco all’unisono, nel pomeriggio, quelle in Groenlandia: «Kalaallit nunaat, Kalaallit pigaat» (la Groenlandia […]
The post «Giù le mani dalla Groenlandia» E Trump annuncia dazi al 10% first appeared on il manifesto.
Il «Board of Peace» sarà «il Consiglio più imponente e importante mai riunito, che sarà istituito come nuova Organizzazione internazionale». Lo scrive, con la consueta sobrietà, Donald Trump nella lettera […]
The post Onu archiviata da una monarchia assoluta first appeared on il manifesto.
Jafar Panahi ha aperto a sorpresa la 38a edizione degli Efa, gli European Film Awards, che si è svolta ieri sera a Berlino. Sul palco ha lanciato un appello conto […]
The post Jafar Panahi apre a sorpresa gli Efa: «Bisogna reagire alla violenza in Iran» first appeared on il manifesto.
Il rapporto fra uomo e mondo o natura occupa, fra le questioni filosofiche, un posto di assoluta centralità. Marx faceva presente, nei Manoscritti economico-filosofici del 1844, che «l’uomo è una […]
The post Nella consapevolezza della vulnerabilità first appeared on il manifesto.
Conosciuta soprattutto per la trilogia di romanzi storici sui Tudor – Wolf Hall, Anna Bolena, Lo specchio e la luce – e per la monumentale Storia segreta della rivoluzione francese, […]
The post Dal Sud Africa dell’apartheid al Norfolk, fantasmi al seguito: Hilary Mantel first appeared on il manifesto.
«Davvero, vivo in tempi bui!», scriveva Bertolt Brecht in una celebre poesia, Ai posteri, composta durante i suoi primi anni di esilio, mentre nel mondo cominciava ad aggirarsi lo spettro […]
The post Müller, la guerra dei paesaggi first appeared on il manifesto.
Recluso nel 1794 nel carcere dell’Hôtel des Fermes per il suo sostegno a Robespierre e al Terrore, Jacques-Louis David inizia a concepire un’opera – Le Sabine – destinata a segnare […]
The post Jacques-Louis David, il maestoso regista del nuovo catechismo laico first appeared on il manifesto.
«Non vorremmo essere qui, in questa assemblea. Dovremmo usare meglio il nostro tempo in questo complicato periodo storico. Per lottare contro il genocidio in Palestina, stare al fianco di chi […]
The post Casale Garibaldi, in 300 contro il rischio di sgombero first appeared on il manifesto.
È rubricabile sotto la categoria del pettegolezzo la presentazione di una «straordinaria scoperta» fatta di recente su Dylan Thomas. Come ha rivelato al Times Literary Supplement e poi ribadito a […]
The post Dylan Thomas, marachelle di un poeta first appeared on il manifesto.
I fanciulli nei due ritratti hanno in comune una tavolozza scura, terrosa, e una penombra alla Rembrandt che permette di concentrarsi sulle loro azioni. Il primo, Un bambino che si […]
The post Greuze, l’illuminista dell’infanzia tradita first appeared on il manifesto.
Nella morsa di questo tempo travagliato, la poesia russa non tace. Tra le voci più dissonanti degli ultimi anni, quella di Julij Gugolev, nato a Mosca nel 1964, paramedico di […]
The post I versi di Julij Gugolev, fra tanfo di morgue, zuppe calde, olezzi di rose first appeared on il manifesto.
L’omicidio di La Spezia, con la tragica morte dello studente Youssef Zaki, accoltellato da un coetaneo compagno di classe, si connota come una profezia che si auto-adempie, dove le conseguenze […]
The post I capri espiatori nel circolo vizioso della violenza first appeared on il manifesto.
Dal 23 al 25 gennaio il Forum Disuguaglianze Diversità organizza «Democrazia alla prova», tre giorni di incontri e dibattiti in cui «capire come le democrazie possano rigenerarsi», spiega il fondatore […]
The post Florio: «Contro gli oligopoli serve l’intelligenza sociale» first appeared on il manifesto.
C’è chi non voleva credere ai propri occhi: la presidente ad interim Delcy Rodríguez che stringe la mano al direttore della Cia John Ratcliffe in visita al paese su ordine […]
The post Intelligence, greggio e lotta ai narcos: stretta di mano tra la Cia e Rodríguez first appeared on il manifesto.
In parallelo con le molte ricerche che ci rivelano come per comunicare le piante usino diversi – certo dai nostri – tipi di linguaggio (molecolare, biochimico, posizionale…), che esigono da […]
The post Anaïs Tondeur e Michael Marder, i segnali delle piante offese first appeared on il manifesto.
Non si sa molto sul tipo di musica che doveva essere suonata e cantata dai giullari itineranti: almeno per i primi secoli del Medioevo le testimonianze sono pochissime e le […]
The post Pier della Vigna e altri quadri del lungo Medioevo latino first appeared on il manifesto.
«Coloro che sono legati a Israele e agli Stati uniti hanno causato enormi danni e ucciso diverse migliaia (di persone)»: ieri il leader supremo Ali Khamenei è intervenuto sulle mobilitazioni […]
The post Khamenei «ammette»: migliaia di uccisi first appeared on il manifesto.
«Questa città di chi credi che sia?». Non è Militant A a cantarlo dal palco stavolta, ma la domanda con cui sono iniziati i tavoli di lavoro della Rete FareSpazio […]
The post I centri sociali milanesi occupano temporaneamente un’ex scuola per immaginare un’altra città first appeared on il manifesto.
Non ha pace la relazione complicata tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e la Lega. Ieri un nuovo capitolo dello scontro si è consumato intorno all’annuncio di Donald Trump […]
The post Dazi, altro scontro tra Lega e Crosetto first appeared on il manifesto.

Mentre i fessi, specie italiani, celebravano la mai avvenuta liberazione del Venezuela e abboccavano come pesci all’idea del sostegno americano alla popolazione iraniana, Donald Trump ha provveduto a cancellare l’Alleanza Atlantica, a dichiarare guerra all’Europa e a imporre ulteriori dazi a una manciata di Paesi europei e quindi anche ai contribuenti americani, almeno quelli cui non fa sparare in faccia celebrando poi l’eroismo degli assassini.
I Paesi europei seri, tra cui purtroppo non c’è l’Italia, non sanno più che cosa fare con il boss mafioso della Casa Bianca: hanno provato a blandirlo con tutti i vossiabinirica possibili, a corteggiare il suo narcisismo extra large, a girarsi dall’altra parte di fronte alle sue mattane, ma sabato sono arrivati al punto di non ritorno: Trump ha ribadito che vuole prendersi con la forza un pezzo della Danimarca, quindi dell’Europa e della Nato, senza alcuna ragione logica se non quella di voler mettere le sue piccole mani sulla più grande isola del mondo.
Trump è fatto così, è un mammasantissima adolescente, «governa da alcolista» (parole della sua capo di gabinetto Susie Wiles), vuole vantarsi di possedere l’isola che sul mappamondo gli sembra gigantesca ma solo per ragioni di ego patologico e forse anche per far dimenticare agli americani tutte quelle volte che, invece, è stato ospite nell’isola piccina piccina dei Caraibi del suo best friend Epstein.
Non c’è nessuna (altra) ragione plausibile che possa spiegare la volontà predatoria di annettersi la Groenlandia, un’operazione speciale che un secolo fa i tedeschi hanno fatto diventare virale col nome Anschluss. La Groenlandia fa parte della Nato, e fino a poco tempo fa ospitava sedici basi militari americane che gli stessi americani unilateralmente hanno smantellato fino a lasciarne soltanto una, ma che potrebbero riaprire quando e come vogliono, perché stando a quanto stabilisce il trattato tra i due Paesi a Trump basterebbe inviare una lettera al Regno di Danimarca per installare basi e inviare soldati ed equipaggiamenti e garantire all’emisfero occidentale la protezione che sostiene di voler assicurare.
A parte l’ego adolescenziale, potrebbe esserci anche un’altra spiegazione dietro la dichiarazione di guerra di Trump agli alleati europei, una guerra dichiarata perché gli europei hanno inviato qualche soldato in Groenlandia, come concordato nel vertice di Washington con J.D. Vance e Marco Rubio, anche per rispondere alla critica trumpiana di scarsa protezione danese dell’isola.
Quest’altra spiegazione è che Trump sia un asset del Cremlino, come gli “Americans” della serie tv, il cui compito primario è quello di cancellare l’Alleanza Atlantica che per quasi un secolo ha tenuto a bada l’imperialismo russo e di smontare l’Unione europea democratica che attrae le popolazioni orientali colonizzate fino a poco tempo fa dalla Russia, e ora terrorizzate dall’idea che Mosca possa tornare a opprimerle.
Trump sta facendo tutto questo alla luce del sole, esattamente come Putin non nasconde le sue mire, e quindi indebolisce l’Europa, rende inutile la Nato e fa apertamente il tifo per i partiti eversivi di estrema destra, ma gli vanno bene anche quelli dell’altra parte purché eversivi, tutti insieme impegnati a chiudere la società aperta, a reprimere il dissenso e a trasformare le democrazie in autocrazie illiberali.
Lo avete letto soltanto qui, e non da ieri, ma dal giorno numero uno: Trump è il primo presidente antiamericano degli Stati Uniti e sta realizzando tutte le sue promesse elettorali, molto sentite nel collegio di Mosca. State certi che Trump non accetterà di perdere le elezioni di metà mandato di novembre, figuriamoci quelle del 2028, come già ha provato a cancellarle, fallendo, il 6 gennaio 2021 istigando l’assalto armato al Congresso, e poi graziando al primo giorno del secondo mandato tutti i golpisti, alcuni dei quali si sono arruolati nell’Ice, il gruppo paramilitare con cui ora terrorizza gli americani con i metodi dei collectivos venezuelani, dei basij iraniani, della Gestapo nazista e aprendo inchieste giudiziarie di stampo staliniano contro i suoi oppositori (nell’ultima settimana: contro il presidente della Fed, peraltro nominato da lui, contro i vertici istituzionali del Minnesota e proprio ieri minacciando di procedere contro tutta l’ex amministrazione Biden).
Vedremo che cosa faranno adesso i leader europei con la testa sulle spalle: Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Donald Tusk, i leader baltici e Volodymyr Zelensky, a cominciare ovviamente dalla sospensione dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti siglato qualche mese fa sempre per compiacere il capo mandamento di Washington.
Ma a questo punto è anche la tenuta democratica dell’Italia a preoccupare, con una premier trumpiana e orbaniana, e di riflesso quindi putiniana come ai bei tempi andati, che mentre l’Europa e la Nato stanno morendo lei mangia il gelato. Con una maggioranza di governo ancora più impresentabile, e un’alternativa democratica altrettanto ambigua e grottesca.
Resistono i soliti cinque o sei parlamentari del Pd, Carlo Calenda e qualche eroe solitario qua e là, nella totale indifferenza di stampa e televisione. Siamo nei guai.
L'articolo Trump dichiara guerra all’Europa, e Meloni mangia il gelato proviene da Linkiesta.it.
Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. Lo ha annunciato lo stesso Scorza in un video pubblicato sui suoi profili social. Insieme agli altri componenti dell'Autorità, Scorza è indagato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Roma che indaga per peculato e corruzione, nata dopo alcuni servizi della trasmissione Report. "Credo si tratti di una decisione giusta e necessaria nell'interesse dell'istituzione anche se, permettetemi di pensarlo, non posso che ritenerla ingiusta nella sostanza e nelle modalita' che mi hanno portato ad assumerla. Non ho nessuna remora ne' imbarazzo nel confessare che e' stata una delle decisioni piu' sofferte della mia vita", ha scritto Scorza sul suo sito per motivare le dimissioni. Scorza era membro del collegio eletto in quota M5s (per questo l'indicazione del sostituto spetterebbe proprio al partito di Conte).
Come abbiamo raccontato oggi sul Foglio, le dimissioni dei componenti del collegio del Garante vengono considerate dalla maggioranza "uno scalpo" per Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Report che ha ingaggiato contro l'Autority una specie di campagna personale (la trasmissione Rai venne sanzionata dal Garante per aver trasmesso alcuni audio privati dell'allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano).
Già a novembre, sul Foglio, avevamo scritto dei possibili sostitui all'interno del collegio del Garante: i giuristi Ida Nicotra, Tommaso Frosini e Nicolò Zanon (nel frattempo diventato presidente del comitato "Sì separa" a favore del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo).
Il caso del Garante della Privacy si inserisce in un più complessivo ragionamento sulla tutela delle autorità indipendenti, su cui molto spesso nel corso degli anni si sono focalizzate le mire dei partiti.

C’è un filo conduttore tra I’evolversi degli eventi in Iran, Venezuela e Groenlandia? Umberto Pascali scommette di sì
L'articolo Umberto Pascali: “Evitata la guerra in Iran” proviene da Visione TV.








C’è una nuova cheesecake che gira sui social, ma non ha forno, non ha stampi a cerniera e soprattutto non ha bisogno di spiegazioni lunghe. Si fa con due ingredienti, yogurt e biscotti, ed è diventata, nel giro di poche settimane, uno dei food trend più replicati su Instagram e, per riflesso, su TikTok. I creator la presentano sempre allo stesso modo: «2-ingredient yogurt cheesecake, viral in Japan right now», come se la provenienza fosse parte integrante della ricetta. L’hashtag #japaneseyogurtcheesecake supera le centomila pubblicazioni su Instagram, mentre le varianti più generiche – #yogurtcheesecake, #2ingredientrecipe, #viraljapanesedessert – raccolgono milioni di visualizzazioni complessive. Non è un’esplosione isolata, ma una ripetizione costante dello stesso gesto: biscotti interi o sbriciolati, yogurt denso (di solito greco o colato), frigorifero. Fine.
A dare una cornice editoriale al fenomeno sono arrivati anche alcuni articoli, soprattutto in inglese e in giapponese. Il blog Okonomi Kitchen, molto seguito per la cucina casalinga giapponese, parla esplicitamente di una ricetta “diventata virale sui social in Giappone”, spiegando che la consistenza ricorda i dolci freddi a base di yogurt molto diffusi in Asia e che l’assenza di cottura è parte del suo successo. Nell’articolo si legge che si tratta di una preparazione “incredibilmente semplice, nata per essere condivisa e replicata”, più che per essere perfezionata. In altre parole, non è una cheesecake nel senso classico, ma una traduzione occidentale di un’abitudine già esistente, resa digeribile dal linguaggio dei Reels. Ci vogliono quattromila battute per raccontare questa preparazione, che ha l’unica difficoltà nel mettere i biscotti in verticale nello yogurt greco. Naturalmente, ci sono anche delle possibili varianti: «In Giappone si usano i biscotti sablé al cocco, ma poiché non sono facilmente reperibili all’estero, i biscotti Biscoff o gli Oreo sono ottimi! Sono leggermente dolci e perfetti per le basi di cheesecake senza cottura. Puoi anche usare altri biscotti secchi o biscotti sablé fatti in casa per un effetto simile».
Anche alcuni media giapponesi online dedicati alla cucina hanno intercettato il fenomeno. Cookpad News, una delle piattaforme più lette in Giappone, parla di una «ricetta diventata virale sui social», sottolineando come il punto non sia l’innovazione gastronomica ma la facilità estrema: per dimostrarlo, il sito propone la versione ancora più semplice e a prova di pigri. Aprite una confezione di yogurt greco, ficcateci i biscotti in verticale e se proprio siete in vena aggiungete del mango essiccato.
Un altro sito di settore, Food Media Tenpos, descrive il dolce come una sorta di “cheesecake magica” fatta con yogurt e biscotti, diventata popolare perché chiunque può rifarla senza competenze.
È il dolce come contenuto, prima ancora che come dessert. Più che una moda giapponese, è uno specchio piuttosto fedele del nostro tempo: un tempo in cui siamo così abituati ad avere un tutorial per tutto che, per mettere insieme yogurt e biscotti, sentiamo comunque il bisogno di vedere qualcuno farlo in video. Meglio se in verticale, meglio se in 30 secondi. Anche il cucchiaio, ormai, vuole la sua regia. Immaginatevi se mai assaggiassero un tiramisù.
L'articolo La cheesecake allo yogurt che nasce social proviene da Linkiesta.it.
Siamo andati ad un evento della gioventù del Partito Socialista Unito del Venezuela, dove i giovani attivisti chiedono la liberazione di Maduro. Abbiamo parlato con alcuni di loro, per capire cosa li spinge all’attività politica in questo momento difficile.
L'articolo Venezuela, cosa pensano i giovani a Caracas? proviene da Visione TV.


Può sembrare una storia piccola, e forse lo è, ma è la storia che probabilmente preoccupa di più il centrodestra italiano, referendum a parte. La storia riguarda lui, il generale Roberto Vannacci, colui su cui Matteo Salvini, un anno fa, ha scommesso per dare alla Lega, alle Europee, un po' di linfa, per evitare di vederla sprofondare nei consensi e alle elezioni. E la storia oggi ci dice che colui che doveva essere il simbolo di una riscossa della leadership di Salvini sta diventando lo specchio della fragilità di un leader e anche di un partito. I parlamentari vicino a Vannacci si sono resi protagonisti di un episodio poco edificante giovedì scorso alla Camera. I deputati Rossano Sasso e Edoardo Ziello, vicini al vicesegretario Roberto Vannacci, hanno votato contro la risoluzione di maggioranza relativa alla proroga dell'autorizzazione che il Parlamento dà al governo per inviare gli aiuti militari all'Ucraina e sono stati rimbrottati dal ministro Crosetto: "C'è chi si vergogna di aiutare l'Ucraina e c'è chi invece no, e io non mi vergogno". Il passaggio politico è interessante perché Vannacci sembra avere tutta l'intenzione di mettersi in proprio e di fondare un partito alternativo alla Lega. Per Salvini sarebbe naturalmente una sconfitta niente male. Ma lo scenario preoccupa il centrodestra per ragioni ulteriori: con un partito guidato da Vannacci fuori dalla Lega il centrodestra potrebbe permettersi di non allearsi un domani con questa destra estremista? E se dovesse allearsi un domani con un partito guidato da Vannacci, l'appeal del centrodestra aumenterebbe o diminuirebbe andando a vanificare i tentativi di un pezzo di centrodestra di presentarsi sulla scena politica con un profilo moderato? La scelta presente di Vannacci, sull'Ucraina, sarà importante per la Lega. Ma la scelta futura di Vannacci sarà importante per il centrodestra: può permettersi Meloni di andare sul palco un domani con il generale più filo russo d'Italia? Chissà.
Quello che avete letto è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis


Marco Rizzo e Francesco Toscano invitano tutti i cittadini a partecipare al Congresso nazionale di DSP che si terrà a Roma, hotel Ergife, il 31 Gennaio e l’1 Febbraio. “È il momento di agire. ”
L'articolo Marco Rizzo: “La politica deve tornare protagonista” proviene da Visione TV.
La settimana della moda maschile è forse l’unico momento dell’anno in cui gli uomini si riuniscono per fare la ruota ed esibire i colori che nella vita di tutti i giorni lasciano sepolti negli arma... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

TAKA TAKA TAKA TAKA
“Ma basta, non se ne può più, non sene’!”
“Sono due giorni che va avanti così. Sta lì blindato e tira, tira, tira”.

Un enigma grava (o, forse, gravava) sul cuore dell’Europa: la Germania, nazione in bilico tra occidente e oriente, industrialismo e fremiti mistici, liberalismo e tendenze autoritarie, catt... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

TAKA TAKA TAKA TAKA
“Ma basta, non se ne può più, non sene’!”
“Sono due giorni che va avanti così. Sta lì blindato e tira, tira, tira”.

Nei primi anni del Settecento, Venezia s’impone come una delle protagoniste della vita musicale europea. Nella città lagunare si incontrano compositori, interpreti e appassionati provenienti da tut... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Alla Galleria nazionale dell’Umbria, la personale di Mimmo Paladino si presenta come un esercizio di montaggio antologico.... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Roma. Stefano ‘o sarracino. E’ tutto pronto o quasi per l’appuntamento che a fine mese riunirà attorno al presidente del Pd alcuni tra i più pregiati sindaci e governatori democratici. Mare i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Chi sarà il prossimo doge? Da un anno a Venezia la chiamano “la stagione buona” – o almeno il centrosinistra, che così ha ribattezzato la larghissima coalizione intenta a riconquistare la città lagunare per il dopo-Brugnaro. Tirerebbe aria nuova, insomma. E il candidato sindaco indicato al tavolo delle trattative sembra ormai Andrea Martella: senatore, segretario regionale del Pd in Veneto. Un profilo di sicura esperienza amministrativa, ma anche “un uomo di partito”, dicono gli scettici: calato dall’alto, senza primarie, e non è nemmeno veneziano (è nato a Portogruaro). Eppure l’opzione resta calda e concreta: in questi giorni i dem consulteranno la base sul territorio e gli altri partiti – dal M5s alle liste civiche – scioglieranno le riserve sull’appoggio a Martella. Se tutto andrà liscio, la fumata bianca potrebbe arrivare già in settimana.
Ma è un se mica da poco. Le regionali – Venezia unica roccaforte rossa in terra leghista – hanno riacceso gli entusiasmi: la partita è aperta. Molti esponenti locali, dentro e soprattutto fuori dal Pd, temono però che la candidatura di Martella sia debole e strumentalizzabile agli occhi degli elettori. Lo spettro è quello del “Baretta bis”, il vecchio militante mandato al macello – cioè alle urne nel 2020 – come estremo rimedio, poi diventato assessore al Bilancio. Ma a Napoli: le vie dei dem sono infinite, e i veneziani hanno memoria lunga. E’ vero che sulla giunta Brugnaro pende il caos dell’inchiesta Palude, ma gli strascichi dello scandalo Mose che consegnarono la città al centrodestra scottano ancora.
Non è un caso se negli altri capoluoghi veneti la sinistra ha vinto sempre grazie alla formula atipica: un civico-calciatore (Tommasi a Verona), un imprenditore (Giordani a Padova), un giovanissimo (sia pure del Pd, Possamai a Vicenza). Insomma, la benedizione di partito è un rischio. Eppure il blocco progressista ha tutte le intenzioni di andare avanti, senza aspettare gli avversari.
Già, e dall’altra parte? Specularmente, il dato delle regionali spaventa. Per logiche romane il candidato spetterebbe a FdI: cioè a Raffaele Speranzon, che però in città non gode di particolare popolarità. Scalpita dunque Simone Venturini, assessore-delfino di Brugnaro, che sta facendo di tutto per proporsi come civico moderato – nonostante i trascorsi nell’Udc di Ugo Bergamo e l’intesa con Stefani e i meloniani. In ogni caso, così non ci sarebbe alcuna garanzia di vittoria.
La soluzione? Quella che spazzerebbe via tutte le altre: Luca Zaia. Il doge dal Veneto a Venezia. Il suo futuro è un rebus, spaccato fra territorio e capitale. L’ex governatore è affascinato dalla laguna, è affezionato ai suoi luoghi, sa che una piazza del genere potrebbe garantirgli prestigio internazionale e tenerlo politicamente libero. L’alternativa sarebbe guidare la campagna elettorale della Lega nel 2027, per poi ottenere un ruolo di primissimo piano: un ministero chiave o la presidenza di una delle due camere. Chi gli è vicino, racconta che Zaia va ripetendo questo: “Valuterò in base a dove potrei essere più utile ai veneti”. Ci pensa. Nei prossimi giorni incontrerà Salvini. E allora ne sapremo di più. Ma se la scelta ricadrà su Venezia, fine dei giochi. Lo sa anche il Pd.

Il centrosinistra si è impantanato, ma secondo un esperto come Gadi Luzzatto Voghera, direttore della Fondazione Ce... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L’Authority della privacy è finita allo spiedo e Meloni sente puzza di bruciato. Oltre alle bistecche del Garante, Stanzione, indagato per peculato, oltre ai titoli “spese pazze”, e le richie... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

“Ritengo che questa riforma sia un passo in avanti, che rende l’Italia più moderna, più europea e anche più sicura. Permetterà di rompere il potere del correntismo. Per questo voterò ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Per la settima volta, l’81enne Yoweri Museveni è stato eletto presidente dell’Uganda. Quando arrivò formalmente al potere nel 1996... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La nuova querelle intorno alla nave rigassificatrice Golar Tundra rischia di creare un pericoloso precedente a favore di tutti quei comitati che si oppongono pregiudizievolmente al... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Consiglio dei ministri ha approvato nei giorni scorsi un ddl delega che punta a ridisegnare il Ssn interv... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ieri Ahmed al Sharaa ha firmato un decreto storico, che concede ai curdi diritti mai goduti prima: cittadinanza, riconoscimento del curdo come lingua ufficiale, piena cittadinanza e istituisce quel... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il volume "La letteratura italiana dal 1895 a oggi. Una storia intermediale" a cura di Giuliana Benvenuti (Einaudi, pp. 513, euro 28) è costru... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Di Léo Delibes (1836-1891) i ballettomani conoscono Coppélia, gli operomani Lakmé e tutti il duetto “dei fiori” che ne è tratto, perché imperversa anche negli spot televisivi. Ovviamente da riscoprire c’è molto di più. Provvedono quei pazzi geniali del Palazzetto Bru Zane, il centro franco-veneziano per la musica romantica francese. Stavolta tocca allo sconosciutissimo Jean de Nivelle, un’opéra-comique del 1880 che all’epoca ebbe una discreta diffusione, anche internazionale, poi è desaparecida. Poiché c’è del metodo nella loro follia, i Bru Zane hanno ricostruito la partitura, ne hanno stabilito anche la versione con i dialoghi cantati e non recitati com’era d’uso per le opéra-comique esportate fuori dalla Francia (lo stesso destino di Carmen, insomma) e l’hanno eseguita mercoledì al Müpa di Budapest.
Ora, non è che dopo quasi tre ore di Jean de Nivelle la nostra vita sia cambiata e d’ora in avanti non se ne possa più fare a meno. Ma non è nemmeno un’altra tacca sul nostro Winchester di collezionisti di rarità. L’opera è piacevolissima, e se non ha funzionato, anzi se ha smesso presto di funzionare, la colpa è semmai di un libretto scombiccherato, con confusi intrighi amorosi e politici all’inizio del regno di Luigi XI, Quindicesimo secolo, e relativa guerra fra francesi e borgognoni. La musica è un resumé di mezzo secolo di teatro francese. I momenti teoricamente comici sembrano uscire da qualche opéra-comique romantica, tipo Hérold oppure Auber, poi si sente molto Gounod che diventa quasi Massenet, un finale del secondo atto che è puro Meyerbeer, insomma c’è un po’ di tutto ma niente è brutto. Delibes sembra un Bizet che non ce l’ha fatta. La scrittura è sempre raffinata anche quando è meno ispirata, con un’orchestrazione tipicamente francese, elegante e senza eccessi, e dire che nel 1880 con gli effetti orchestrali si iniziava a darci parecchio dentro: infatti Saint-Saëns la trovò “exquise”. Insomma, se è abbastanza improbabile che nel futuro prossimo ci sia una fioritura di Jean de Nivelle in giro per il mondo, questa botta e via di Delibes valeva il viaggio, nonostante la neve e i meno cinque. E per queste riesumazioni non succede sempre, anche con la bella stagione.
Sono casi, però, in cui conta non solo il “cosa” ma anche il “come”. L’opera è impegnativa, intanto perché è lunga e poi perché richiede accuratezza stilistica. Il vero modus cantandi dell’Opéra-comique, intesa sia come genere sia come istituzione, è oggi da considerare estinto, specie dopo la sciagurata fusione nella sua troupe con quella dell’Opéra perpetrata dalla Terza Repubblica. Però si è ascoltata, appunto, la versione “tutta cantata”, senza i temibili parlati; e l’intera compagnia era francese o francofona, e per fortuna perché i sopratitoli in ungherese, una lingua composta di sole consonanti, non aiutano. Esecuzione convincente, a partire dall’ottima prova dell’Orchestra filarmonica nazionale ungherese e del suo Coro e dalla direzione inappuntabile di György Vashegyi, e cantanti nel complesso ottimi. Ne segnalo in particolare tre. Una è Mélissa Petit, che inizia come soprano “à roulades” però nel terz’atto ha una deliziosissima aria lirica che è stata deliziosamente cantata. La seconda è Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, un mezzosoprano che fa Simone, una specie di Azucena da opéra-comique: la sua “ballade de la mandragore” è uno dei brani migliori del Jean de Nivelle. Infine, lui, il protagonista, ovviamente tenore in quanto un Montmorency (“i primi baroni della cristianità”) che si aggira incognito per la Borgogna al seguito di imprecisati screzi con l’Undicesimo. L’impressione è che ci vorrebbe una voce più cicciuta di quella di Cyrille Dubois, ma in ogni caso gli acuti riescono quasi tutti bene e il canto è pieno di finezze ed eleganze, compresi i trilli: e un tenore che trilla è più raro di un grillino che usa i congiuntivi. Grande successo. E adesso, per favore, vorremmo scoprire il Delibes operettista, perché i titoli promettono benissimo: L’asphyxie du bigorneau, La cour du Roi Pétaud e soprattutto L’omelette à la Follembuche.

Per chi ha interesse per la cultura pop giapponese, andare al Comiket (Comic Market) può rappresentare un’esperienza che vale la pena vivere. Da molti è infatti considerata una manifestazione «iconica» […]
The post Una giornata al Comiket first appeared on il manifesto.
Il muro a Berlino definiva le divisioni della guerra fredda, era insuperabile ma la musica a volte riusciva scavalcarlo. Circondava per 155 km la parte occidentale di Berlino e divideva […]
The post Il suono del muro a Berlino est first appeared on il manifesto.
«Potrei farlo anche per la Groenlandia». La conferenza alla Casa bianca riguardava i dazi imposti sui prodotti farmaceutici europei, ma il presidente Donald Trump ha ventilato la possibilità di ampliare […]
The post «Dazi a chi si oppone all’annessione». La minaccia di Trump first appeared on il manifesto.
Una nuova mozione di sfiducia attende la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, per la quarta volta nel giro di pochi mesi. Stavolta il capo d’accusa contro la popolare […]
The post Strasburgo, sfiducia a von der Leyen. Torna l’asse tra il Carroccio e M5s first appeared on il manifesto.
Primo dicembre 2018. Meng Wanzhou, figlia del fondatore e patron di Huawei, viene arrestata a Vancouver. È il vero punto di svolta delle relazioni tra Cina e Stati uniti, acceleratore […]
The post Canada in fuga dal protezionismo Usa. Con la Cina è «partnership strategica» first appeared on il manifesto.
Vladimir Putin: “Le Nazioni Unite svolgono il ruolo chiave e fondamentale negli affari mondiali, e questo ruolo va rafforzato. La NATO ha più volte ingannato la Russia, violando le proprie promesse pubbliche di non avanzamento ad Est, rappresentando la minaccia alla sicurezza del nostro stato. La Russia ha promosso delle iniziative per costruire una nuova, affidabile e giusta architettura europea e sicurezza globale, in base alle quali potrebbe risolversi pacificamente il conflitto in Ucraina. Kiev e le potenze occidentali, i suoi sostenitori, non sono pronti alla soluzione pacifica. Le relazioni con le potenze occidentali in generale, e con l’Italia in particolare, sono ai minimi storici. La Russia è pronta al ripristino delle relazioni con esse ai massimi livelli. Il compito degli ambasciatori, compreso quello dell’Italia, di contribuire proficuamente alla normalizzazione delle relazioni bilaterali.”
L'articolo Putin: “Pronti per una pace duratura in Ucraina con garanzie di sicurezza per tutti” proviene da Visione TV.
Insomma mercoledì sera intasamento di taxi e auto blu al Mattatoio di Roma per l’inaugurazione della mostra dedicata ai 50 anni di Repubblica, fondata appunto il 14 gennaio 1976. Da ieri aperta al ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Tra bandiere di vari colori e pannelli gialli con sopra scritto “shame”, in Piazza del Campidoglio aleggia la frase del presidente Sergio Ma... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Antonio Decaro parte e fa di testa sua: il nuovo monarca della Puglia ha formalizzato la sua giunta con un evento nell’agorà del Consiglio ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il campo largo prova a ricompattarsi per l'Iran. Tutti i leader dei partiti d'opposizione, meno Azione, si sono ritrovati oggi pomeriggio in Campidoglio, a Roma, per un sit-in in sostegno alla popolazione iraniana in protesta. La manifestazione si è svolta dopo una settimana segnata da incertezze e divisioni politiche sul tema, con il Movimento 5 stelle che si è sfilato dalla risoluzione unitaria approvata dal Senato per poi presentarne una propria, la quale è stata votata solo da Avs e (non tutto) il Partito Democratico.
Gli screzi parlamentari sembrano essersi appiattiti solo oggi, in piazza. Alla dimostrazione organizzata dall'associazione Donna, vita e libertà hanno partecipato Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Per Italia Viva c'era invece una delegazione di parlamentari. Quella di oggi è la prima manifestazione alla quale partecipano i leader politici da quando è in corso il massacro in Iran. Domani mattina, a Piramide a Roma, si terrà invece quella organizzata dal partito radicale. Lì andranno Carlo Calenda, Riccardo Magi, una delegazione di parlamentari Pd, ma non Avs e Movimento 5 stelle.

"L'invio dei contingenti in Groenlandia è un atto politico che dimostra la coerenza dei principi sanciti dal Trattato firmato nel 1949. Anche l'Italia dovrebbe farlo, rischiamo di rimanere ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L’influente consigliere del Cremlino Karaganov spiega la vera natura del conflitto in corso. “Non stiano combattendo contro l’Ucraina ma contro l’Europa. Il Presidente Putin è un uomo troppo cauto, ma è chiaro che a breve saremo costretti ad usare il nostro potenziale nucleare per punire Paesi come la Germania, luogo che troppo spesso ha partorito idee infami che hanno infettato il mondo”
L'articolo Karaganov intervistato da Tucker Carlson:”La guerra finirà solo con la sconfitta totale dell’Europa” proviene da Visione TV.



L'articolo capture 16 gennaio 2026 12 05 21 proviene da Visione TV.
“Consolidare il ruolo dell'Italia come paese non artico interessato all'Artico”. Ma non solo: anche “contribuire al mantenimento dell'area di stabilità, prevenendo dinamiche di escalation e sostenendo meccanismi multilaterali di dialogo e cooperazione”. Sono questi alcuni dei principali obiettivi del nuovo documento strategico italiano sull'Artico, intitolato “La Politica Artica Italiana, L'Italia e l'Artico: i valori della cooperazione in una regione in rapida trasaformazione”. Il documento è stato presentato dai ministri degli Esteri, della Difesa e dell'Università e della Ricerca Antonio Tajani, Guido Crosetto e Anna Maria Bernini a Roma, presso Villa Madama, nelle stesse ore in cui sette paesi europei, Francia, Regno Unito, Danimarca, Svezia, Norvegia, Canda e Olanda hanno deciso di inviare in Groenlandia piccoli contingenti militari per difendere Nuuk dalle mire espansionistiche di Donald Trump.
Il nuovo documento strategico, adottato a dieci anni di distanza dal primo, attualizza le politiche italiane alla fase di crescente rilevanza globale della regione e ha secondo il governo ha lo scopo di delineare una visione strategica, accompagnata da alcuni obiettivi di lungo periodo, come il rafforzamento della sicurezza collettiva euro-atlantica e l'attenzione alle possibili opportunità economiche, in grado di rafforzare l'impegno italiano nella regione. Le direttrici sono quelle della sicurezza, della ricerca scientifica e dello sviluppo economico mettendo insieme le diverse forze del paese ed è per questo motivo che alla conferenza hanno partecipato anche alcuni membri del Tavolo Artico ed esponeneti del mondo imprenditoriale.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha potuto partecipare fisicamente alla conferenza, perché impegnata in Giappone in una missione per rafforzare i rapporti strategici dell'Italia nell'Indo-Pacifico. La premier però ha inviato comunque un messaggio: "L'italia è perfettamente consapevole di quanto questa regione del mondo rappresenti un quadrante strategico negli equilibri globali, e intende continuare a fare la propria parte per preservare l'Artico come area di pace, cooperazione e prosperità". Meloni ha poi detto che l'Artico deve "essere sempre di più una priorità dell’Unione Europea e della Nato, e che l’Alleanza Atlantica debba cogliere l’opportunità di sviluppare nella regione una presenza coordinata e capace di prevenire tensioni, preservare la stabilità e rispondere alle ingerenze di altri attori"
Meloni ha voluto sottolineare che l'attenzione italiana per la regione artica non è stata dettata dalle ultime notizie: dalla base Dirigibile Italia alle Svalbard, passando per le campagne oceanografiche della Marina Militare, “la nostra nazione svolge da molto tempo un ruolo di primo piano per tutelare un'area che è molto fragile e per assicurare uno sviluppo equilibrato e rispettoso delle istanze dei diversi popoli che vivono questi territori”. E ha spiegato gli obiettivi della nuova strategia che “punta a rafforzare il ruolo dell'Italia come partner affidabile, capace di promuovere cooperazione, sostenibilità e innovazione. Perché siamo consapevoli che ciò che accade nel 'Grande Nord' non è qualcosa di distante o che rimane confinato in quella regione del mondo, ma riguarda il futuro di tutti noi, il nostro benessere, la nostra prosperità e la nostra sicurezza".
Sull'invio di soldati in Groenlandia Crosetto è tassativo: “Da tempo la Difesa si interessa dell'Artico, con la Marina, l'Aeronautica, l'Esercito con esercitazioni che non sono iniziate adesso e che non sono sicuramente 15 soldati mandati in Groenlandia, mi chiedo a fare cosa? Una gita?”. Si è domandato il ministro della Difesa, che poi ha aggiunto: “Immaginate, 15 italiani, 15 francesi, 15 tedeschi: mi sembra l'inizio di una barzelletta. Penso sia nostro interesse tenere insieme il mondo occidentale, pensando sempre in ottica Nato, Onu. Io sono per allargare, non frazionare in nazioni un mondo già troppo frazionato''. Però Crosetto ha lanciato un avvertimento sul prossimo futuro: “Il paese che più confina con questo nuovo pezzo di mondo è la Russia e ha la più grande presenza sull'Artico. Probabilmente, il giorno che finirà la guerra in Ucraina, gran parte delle risorse militari russe saranno spostate in questo settore, come sta facendo la Nato''. Il ministro ha poi evidenziato che anche la Nato si sta spostando: "Ha posto il comando a Norfolk - nell'Inghilterra orientale - e ha concentrato tutta la politica militare del nord sempre più vicino all'Artico".
Durante la conferenza, il ministro degli Esteri Tajani ha annunciato non solo che nelle prossime settimane sarà a Washington per parlare di materie prime con il segretario di stato americano Rubio e altri partner, ma che svolgerà anche "una missione imprenditoriale italiana per l'Artico". Il vicepremier ha infatti detto che si deve "dar vita a un tavolo imprenditoriale Artico con tutti i nostri principali gruppi industriali e piccole medie imprese in settori chiave, dobbiamo sostenerli ed essere e al loro fianco. Non possiamo non tenere conto dell'importanza delle materie prime e l'Artico è ricco di materie prime", ha aggiunto, ricordando la presenza di grandi aziende della difesa e della cantieristica – come per esempio Leonardo e Fincantieri – attive nella regione. "L'Artico non è una questione tattica, ma strategica: l'Italia ha una visione a 360 gradi e non può permettersi di non avere una strategia aggiornata", ha detto Tajani, sottolineando che "la centralità della regione oggi più che mai ci impone un'azione politica, economica e di ricerca" e ribandendo l'importanza della "stabilità dell'area di interesse geostrategico" e di una maggiore presenza dell'Unione europea e della Nato nell'area artica. Tajani inoltre ha ricordato l'importantanza dell'export italiano, che dipende anche dalla sicurezza delle rotte marine la cui tutela deve diventare "una priorità fondamentale". La sicurezza dell'occidente – secondo il vicepremier – dev'essere "garantita da un'azione politica forte, anche di sicurezza, non è questione di mandare 10 o 20 soldati, ma avere in testa una strategia. E noi una visione ce l'abbiamo".
"Gli studiosi dell'Artico sanno che, per sua natura, l'Artico è multidisciplinare. Quello che succede nell'Artico non rimane nell'Artico e quel che accade nel Mondo riguarda l'Artico", ha detto nel suo intervento la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. "Abbiamo una banca dati che è fra le migliori al Mondo", ha aggiunto. L'Italia è "in grande vantaggio" e opera "da grande protagonista" nell'Artico, ha spiegato la ministra, secondo cui il Sistema Italia "è stato unito nel creare delle piattaforme di eccellenza". Berini ha poi annunciato come "il 3-4 marzo organizzeremo una iniziativa con il ministero degli Esteri e della Difesa che si chiamerà 'Artic Circle Rome Forum - Polar Dialogue' su cui convergeranno imprenditori, imprenditori della difesa, scienziati, ricercatori e politici per parlare di Artico".

La questione salariale è tornata alla ribalta in Italia nel 2025. Nel 2026 si dovrà iniziare ad agire per migliorare la situazione: la legge delega al governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva potrebbe essere lo strumento per mettere ordine nel sistema. I fondi Pnrr hanno permesso di rendere più effettivo […]
L'articolo Il Punto proviene da Lavoce.info.
Una buona parte delle risorse per il diritto allo studio universitario è arrivata negli ultimi anni da fondi Pnrr. Si tratta per definizione di risorse temporanee. Intanto si è ampliata la platea dei possibili beneficiari. I rischi che si prospettano.
L'articolo Quando il diritto allo studio resta una promessa proviene da Lavoce.info.
Il pendolo Trump torna ad avvicinarsi alle posizioni di Putin lasciando sempre più nello sconforto l’oramai consunto Zelensky. Il Corriere della Sera prova a magnificare le parole del Ministro Crosetto oramai vicino ad accettare la sconfitta totale. La Repubblica commenta l’arrivo di una ventina di scalatori europei in Groenlandia con il compito di difendere l’isola dal possibile arrivo degli americani di Trump. Buona fortuna. Il Fatto sottolinea il doppiopesismo del Presidente Mattarella, silente sul massacro di Gaza ma deciso nel denunciare i presunti crimini iraniani
L'articolo Trump scarica Zelensky per l’ennesima volta – Il Controcanto – Rassegna stampa del 16 gennaio 2026 proviene da Visione TV.










All’opera i cantanti possono essere anche considerati un male necessario, ed è stato autorevolmente sostenuto che la loro difficoltà a ragionare derivi dal fatto che al posto del cervello hanno la ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ultimo fattaccio in cronaca il giovane uomo che, aggredito da rapinatori nella sua villetta nel Varesotto, nel corso della colluttazione ha ferito con un coltello uno dei ladri che poi i complici i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Rafforzare un legame storico e proiettarlo verso una cooperazione sempre più stretta su sicurezza, economia e innovazione. È il messaggio lanciato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel bilaterale con la prima ministra giapponese Sanea Takaichi al Kantei di Tokyo, in occasione del 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone.
“Sono estremamente contenta di essere qui dopo il nostro breve incontro a Johannesburg e i nostri dialoghi telefonici”, ha esordito Meloni, sottolineando il valore di una relazione costruita nel tempo. “Questa è la terza volta che vengo in Giappone in tre anni di governo e non è stato un caso, è stata una scelta”, ha spiegato, rimarcando come la frequenza delle visite rifletta una strategia politica precisa.
La premier ha chiarito il significato politico del viaggio: “Il messaggio di questa terza visita è che crediamo molto in questa alleanza, crediamo molto in questa cooperazione, crediamo molto in questa amicizia”. Un percorso scandito da tappe concrete: “La prima volta che sono venuta qui abbiamo elevato i nostri rapporti a partenariato strategico. La seconda, durante il G7 di Hiroshima, abbiamo definito un Piano d’azione triennale 2024-2027 con obiettivi chiari e scadenze che abbiamo rispettato”. Ora, con il nuovo incontro a Tokyo, Roma e Tokyo compiono un ulteriore passo avanti. “Torno qui per la terza volta – ha aggiunto Meloni – sono il primo leader europeo a visitare il Giappone da quando lei si è insediata, e cogliamo l’occasione per elevare ancora una volta le nostre relazioni a livello di partenariato strategico speciale”.
Un’intesa che affonda le radici nella storia ma guarda al futuro. “Il 160° anniversario delle nostre relazioni bilaterali racconta quanto siano profonde, quanto siano state durature e continuative”, ha concluso la presidente del Consiglio, ribadendo la volontà comune di rafforzare il coordinamento su dossier globali, dalla sicurezza internazionale alla cooperazione economica e tecnologica. Il vertice conferma così l’asse Roma-Tokyo come uno dei pilastri della politica estera italiana in Asia, nel segno di una partnership che entrambe le leader definiscono ormai “speciale”.
La visita della premier in Giappone e Corea del sud era prevista ad agosto scorso, nell’ambito di un viaggio più ampio nell’Indo-Pacifico che prevedeva tappe anche in Bangladesh, Singapore e Vietnam. Poi Palazzo Chigi aveva rinviato tutto per concentrarsi su questioni più urgenti, fra le quali i negoziati tra America, Russia e partner europei sulla pace in Ucraina – poi falliti. E quindi il viaggio nell’Indo-Pacifico è iniziato mercoledì 14 gennaio, ma con un programma ridotto a due soli paesi, Giappone e Corea del sud, e quindi senza la tappa a Dacca, cruciale per le politiche migratorie del governo.

Giorgia Meloni ha chiesto al ministro Matteo Piantedosi un cambio di passo sul tema della sicurezza, e il segnale è subito arrivato. Mer... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

I racconti e le poche immagini che escono dall’Iran disegnano un quadro terribile di repressione brutale. Ma la sinistra è apparsa timida rispetto alle precedenti mobilitazioni imponenti pe... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La Puglia, con la nomina nelle prossime ore della nuova giunta, passa da emirato di Michele Emiliano a monarchia assoluta di Antonio Decaro, regalando per... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Dice che “i temi della sicurezza sono un patrimonio della sinistra e del Pd”. E che “però, al contempo, vanno affrontati con serietà, con una differenza non solo di contenuti ma an... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

E’ il generale al contrario, il generale senza le truppe. Suona la tromba, chiama l’adunata. Ma al flash mob del team Vannacci, contro il decreto Ucraina, si presentano in nove. Uscendo da Montecitorio Stefano Candiani la definisce “una deriva macchiettistica. La Lega è un’altra cosa”. Da settimane il vicesegretario Roberto Vannacci, invita i parlamentari del Carroccio (e non solo) a schierarsi contro Zelensky. Ieri ha battibeccato pure con Tajani, che lo attaccava: “E’ suicida dirottare risorse agli italiani per darle a chi le spende in cessi d’oro, yacht e prostitute”. Ma lo seguono fino in fondo solo in due: Edoardo Ziello e Rossano Sasso. L’accampamento no Kyiv è convocato per le 10, davanti alla Camera. In Aula Crosetto spiega la ratio del decreto. S’è convinto dopo varie trattative (lessicali) pure Matteo Salvini.
I nove vannacciani si fanno attendere quasi un’ora, i giornalisti sono molti di più. C’è chi scherza: “Manco il 5 e 5 al calcetto possono organizzare”. Srotolano un triste striscione che riassume la vulgata del generale (che intanto è a Bruxelles): “Basta finanziamenti per le armi”. Sono guidati da Marco Pomarici, leader del Mac di Roma, con un passato da presidente dell’Assemblea capitolina ai tempi di Alemanno. E’ stato forzista, leghista, ma anche con Ncd di Alfano. Fino al ritorno nel Carroccio lo scorso giugno, con tanto di nota di benvenuto firmata proprio da Vannacci e dall’altro vice, Claudio Durigon. Pomarici spiega il senso dell’iniziativa, ripere le parole di Vannacci, “i cessi d’oro”. E va bene, ma il vostro generale è il vice di un partito che voterà la risoluzione (e poi il decreto). Vi sta bene? Deve uscire? “Ora è nella Lega. Da qui in avanti si vedrà”. Accanto a Pomarici c’è Guido Giacometti, presidente del movimento il Mondo al contrario. Tira comunque un’aria un po’ mesta, simpatizzanti del generale non se ne vedono.
E i parlamentari? Si aspettavano per esempio Emanuele Pozzolo – che più tardi voterà no. E’ considerato un quasi vannacciano. Esce dalla Camera quando ancora il flash mob non è iniziato e va per la sua strada. Ecco passare, forse una casualità, il senatore leghista Gianluca Cantalamessa, ma tira dritto. Così alla fine, timidamente, si fanno vedere Sasso e Ziello. Si fermano, salutano il team Vannacci. E’ il prologo di quello che accadrà poco dopo. Quando, con un po’ di travaglio, votano in dissenso dal gruppo. Ne fanno una questione di interesse nazionale, di coscienza e coerenza. Di acrobazie lessicali che non cambiano la sostanza. Lo spiegano sui social e alle agenzie. Entrambi sottolineano: “Anche Trump ha detto che Zelensky ostacola la pace”. Con Pozzolo, ex FdI e oggi nel Misto, la quota Vannacci arriva a tre. Al Senato non partecipa al voto sulla risoluzione Claudio Borghi, ma la sua è una storia a parte. Mentre alla Camera si registrano anche sei assenze leghiste. Tra queste Domenico Furgiuele, un altro considerato più o meno vicino a Vannacci, dicono sia in settimana bianca. Oltre a Bossi e Angelucci, non ci sono neppure Latini, Mele e Giacomi. Sasso ironizza: “Io a differenza di altri sono qui”.
Ieri mattina nella Lega qualche preoccupazione c’era, ma alla fine i deputati si danno di gomito: “Se questi sono i suoi soldati....”. Lo strappo tentato da Vannacci si è sgonfiato in Aula e fuori è andato peggio. Un boomerang. Dal Carroccio filtrano note, si spiega che tra Salvini e il generale “c’è totale serenità”. Si vedranno a giorni, forse anche per parlare della nuova passione teatrale di Vannacci. Fino a ieri sera Salvini non aveva commentato la scelta di Ziello e Sasso (che dichiarava di non voler lasciare il Carroccio), ci sarà probabilmente un chiarimento. Qualcuno ipotizza (difficili) procedimenti disciplinari, ma è anche vero che i dissidenti avevano la copertura di un vicesegretario. Resta comunque l’interrogativo: cosa vuole fare Vannacci? Una sua componente o se ne va? “Non troverà mai la forza di strappare con la Lega, lo conosco bene”, attacca Stefania Bardelli, la bersagliera, un tempo fedelissima del generale e a capo del Team di Varese. Il sit in? “Francamente ridicolo. Un teatrino stanco, costruito unicamente per far rumore. Il segreto è restare sospesi e ambigui. E’ il gioco che gli serve a galleggiare. Vannacci è coraggioso solo sulla carta”.

Pasquale Tridico, uno del quale dissero: “Toh” soltanto quando nacque, vuole farsi una sua corrente nel M5s. La notizia circola senza che sia necessario transennare le edicole o avvisare la protezione civile, ma ha un suo pur strambo interesse. Se non altro per il singolare scompiglio che sta creando a Roma nei gruppi parlamentari del Movimento. “Vuole fare il controcanto a Conte”, dicono. “Lo ha praticamente confessato lui stesso”, aggiungono. E raccontano: “Qualche settimana fa in una assemblea lo ha proprio detto. Ha detto che presenterà una sua lista personale alle prossime elezioni comunali in Calabria”. Lista Tridico. “Ad ascoltarlo c’erano pure Roberto Fico, Alessandra Todde. E anche Conte”. E che diceva Conte? “Faceva spallucce”. Insomma l’avevamo lasciato in Calabria, Tridico. Lì dove da candidato presidente aveva dato prova di profonda conoscenza del territorio. Comprimeva a tre le cinque province della Calabria e prometteva moltiplicazioni di guardie forestali, in una visione amministrativa che mescolava Pitagora e Cetto La Qualunque. Ora lo ritroviamo al centro di un intrigo romano. Addirittura. La fronda a Conte, nientemeno. Molti parlamentari del M5s si dicono preoccupati. “Se la fa col Pd”, spiegano. “Ha ambizioni”, precisano. Bum! Paola Taverna pare che sia furiosa (strano, di solito è pacata come un comizio in megafono). Sapete invece chi è l’unico che dorme, per così dire, tra due pochette? Giuseppe Conte. Come al solito, è l’unico che capisce tutto: Tridico non è una minaccia – pensa Conte – è un esercizio di immaginazione (la sua stessa). Uno che, se davvero volesse costruirsi un orticello politico, finirebbe per seminare in un vaso e dimenticarselo sul balcone. D’altra parte è pur sempre quello che si presentava a Cosenza con lo slogan sgrammaticato “la destra ha paura perché sanno che vinceremo noi”, e questo mentre il van del suo tour elettorale veniva fotografato in contromano e sulle strisce pedonali. E’ quello che si candidò a governatore dicendo poeticamente: “Resta. Torna. Crediamoci”. E ci “credeva” talmente tanto che invece di “tornare” in Calabria e “restare” a fare il consigliere regionale, dopo aver perso le elezioni filò dritto indietro a Bruxelles dove aveva il seggio al Parlamento europeo. L’altro giorno, per dire il carisma, ha mandato un messaggio nella chat che riunisce i consiglieri calabresi di opposizione. Ha proposto una manifestazione di piazza. Non gli ha risposto nessuno. Ecco. Schlein deve vedersela con Gentiloni, Guerini, Picierno, a volte pure con Franceschini. Conte ha Tridico. Talvolta la Appendino. Ora capite perché quell’uomo nemmeno suda.

La Puglia, con la nomina nelle prossime ore della nuova giunta, passa da emirato di Michele Emiliano a monarchia assoluta di Antonio Decaro, regalando per... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Quando Donald Trump è alle strette, come ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Alla cerimonia di presentazione delle credenziali dei nuovi ambasciatori stranieri in Russia, Vladimir Putin ha accolto i diplomatici, fra i quali sedeva anche l’ambasciatore italiano a Mo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

E’ stata ribattezzata “clausola Farage” la nuova postilla negoziale che l’Unione europea vuole inserire nel negoziato con il Regno Unito sul “reset” post Brexit. Secondo la ricostr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti


A Caracas abbiamo incontrato Ennio Di Marcantonio, cittadino venezuelano di origine italiana che ci ha dato una testimonianza sulla situazione che si vive in Venezuela. Ezequiel Suarez, abitante di Fuerte Tuja, una delle zone bombardate durante l’attacco americano contro la capitale venezuelana.
L'articolo Voci da Caracas proviene da Visione TV.

Il carcere, le sue regole, le sue persone e le loro storie, in mostra. In carcere. Ieri, 14 gennaio 2026, si è tenuta la presentazione della mostra "Un mondo alla rovescia", un lavoro realizzato dal progetto editoriale Hyperlocal e che ha portato il Nuovo complesso del penitenziario di Rebibbia, a Roma, a ospitare una vera e propria mostra fotografica al suo interno. All'interno del carcere, un gruppo di giornalisti, tra cui il Foglio, ha potuto visitare la mostra adibita nell'area verde, di fianco alla chiesa del Padre Nostro, dove Papa Francesco l'anno scorso ha aperto una delle porte sante del Giubileo appena concluso. Qui, sulle pareti del cortile esterno dedicato alle visite dei parenti dei detenuti, diversi pannelli mostrano le foto dei carcerati e raccontano le loro storie.
Lasciati fuori qualsiasi telefono e dispositivo di comunicazione, i responsabili della redazione di Hyperlocal hanno accolto la stampa e hanno spigato come è stato possibile realizzare il progetto. "Lavoriamo al tutto da un anno, proprio da quando Francesco ha deciso di aprire qui una delle porte sante del Giubileo", spiega Nicola Gerundino. La realtà di Hyperlocal esiste dal 2020 e si occupa di raccontare i quartieri di Italia e di altri paesi. "Abbiamo voluto raccontare il carcere, sia per chi ci vive sia per chi ce l'ha come vicino di casa", spiega al Foglio. La mostra si chiama "Un mondo alla rovescia" e racconta le storie di una ventina di detenuti. "Il titolo è esplicativo di cosa significa vivere in carcere. Qui abbiamo visto come molte cose sono rivalutate, non sono più date per scontate. Un esempio parte proprio dal cellulare, dal farsi i capelli, dal lavoro, dalla lettura. Una diversità nella somiglianza che genera continui cortocircuiti e impone riflessioni e domande".
Alessandro, il sociologo dottorando, Mohamed il calciatore, Antonio il meccanico. Una ventina di uomini, di detenuti, che attraverso due mesi di incontri con la redazione di Hyperlocal hanno raccontato il loro "dentro", la loro vita a Rebibbia, al fuori, al quartiere di Rebibbia. Le fotografie sono state realizzate da Stefano Lemon, Lavinia Parlamenti, Guido Gazzilli e Benedetta Ristori. I diversi pannelli ora affissi nell'area adiacente alla chiesa sono stati per tutta la seconda parte di dicembre all'esterno del carcere. "In questo modo i cittadini hanno potuto leggere le storie dei detenuti", spiega sempre Gerundino.
Nel corso della presentazione della mostra abbiamo potuto vedere una piccola parte del carcere, che è uno dei più grandi d'Europa. E dopo un giro tra i pannelli e le fotografie, i realizzatori ci hanno portato nel piccolo teatro del complesso, dove insieme ai detenuti protagonisti del racconto è stato mostrato un breve filmato della vita nel carcere, nello specifico nel complesso G8. "Rebibbia è una città nella città", dicono i detenuti nel video. Una città "con le sue regole", con la sua vita. "Qui il tempo si ferma" per questo l'importante "è tenersi occupati. Si arriva a combattere contro il tuo stesso carattere", affermano. Un filmato che racconta, sembra, un po' il "bello" di ciò che col tempo si è riusciti a costruire, ma, come dicono anche gli organizzatori del progetto, non tutto è rose e fiori: "La mostra è un primo passo, è difficile anche solo accedere qui e per noi questo è già un grande risultato".
Nella realizzazione del progetto, Hyperlocal si è interfacciato con la sezione educativa del carcere. Questa, come per ogni proposta di collaborazione, ha selezionato e fatto da tramite per realizzare sia le interviste che le fotografie. "C'è stato molto interesse tra i detenuti, tant'è che durante la creazione abbiamo ampliato la platea di carcerati, da dieci siamo arrivati a diciassette", spiega ancora Gerundino. I detenuti si sono presentati e hanno partecipato alla parte finale della mostra. E insieme a loro ha assistito alla presentazione anche il garante dei detenuti della regione Lazio Stefano Anastasia. "L'importanza di un progetto come questo è la restituzione di ciò che c'è dentro al mondo", ha detto nel suo breve intervento. "Prima o poi per fortuna le pene finiranno, tutti usciranno. E là fuori ci sarà un mondo che, si spera anche grazie a lavori del genere, non giudichi e dia opportunità a tutti". Primi passi, per la vera rieducazione.


Le tecnologie per la transizione verde sono mature, ma le emissioni continuano a crescere. Perché la diseguaglianza nella gestione delle catene globali del valore riduce gli incentivi alla decarbonizzazione e allontana gli obiettivi climatici.
L'articolo Transizione verde frenata dalle disuguaglianze proviene da Lavoce.info.


Il M5s si è astenuto, unico partito, sulla mozione in sostegno del popolo iraniano. Basterebbe questo a qualificarli, e non c’è nulla di strano che il Fatto quotidiano, consentaneo sempre ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Storicamente, le crisi politiche nei paesi produttori di petrolio sono associate a choc energetici. Non bisogna ritornare alle crisi petrolifere degli anni Settanta, prima in seguito alla ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Siamo dentro un’epoca di rottura e non di ricomposizione. Quest’ultima, anzi, sembra lontanissima. Siamo, per dirla con la fisica dell’acqua, nella fase dell’ebollizione, passaggio dallo st... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

A volte una clip dice tutto. Craig Guildford, capo della polizia delle West Midlands britanniche, si rivolge alla telecamera: “Salam alaikum”, disse alla comunità musulmana di Birmingham n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti


Lavoce in mezz’ora è il format di divulgazione di lavoce.info: due volte al mese, in mezz’ora di conversazione, affrontiamo temi centrali per il dibattito pubblico con esperte ed esperti. Con Marco Ventoruzzo discutiamo la riforma del TUF.
L'articolo La riforma del TUF era necessaria? proviene da Lavoce.info.
Questa mattina in Senato si è tenuta una conferenza stampa organizzata dal senatore del Pd Filippo Sensi dove sono intervenute due attiviste iraniane (e altri da remoto) per raccontare la rivolta e la repressione in corso. L’incontro, avvenuto in Sala Nassyria, ha raccolto la partecipazione di tutti i partiti d’opposizione, ma non della maggioranza. “Nessuno può immaginare la dimensione del massacro in corso, ad oggi le proteste si sono estese a oltre 500 città”, ha detto Shervin Haravi, la prima attivista a raccontare i fatti. “Fonti internazionali dicono che ci sono tra le 12 e le 20mila persone uccise, ma nonostante il sangue versato gli iraniani continuano a scendere in piazza. Perché siamo un popolo che ama la propria patria, che ha sempre convissuto nella pluralità”.
Rayhane Tabrizi, l’altra attivista presente, ha vissuto 29 anni in Iran prima di arrivare in Italia e porta con se il ricordo delle bombe tra Iran e Iraq, gli otto anni di guerra contro Saddam Hussein, dall'80 all'88. “Ora riusciremo ad abbattere il regime, che sta uccidendo il suo popolo”, dice con gli occhi lucidi.
Le due testimonianze vogliono essere un monito per il governo e le istituzioni affinché si mobilitino. “Chiediamo pressione sull’ambasciatore, chiediamo che venga convocato e che vengano chiuse tutte le associazioni che fanno propaganda iraniana in Italia”, dicono. L’appello è per tutti i partiti, perchè ci si mobiliti mettendo da parte le differenze. Dei parlamentari italiani si è contata la presenza di Susanna Camusso, Piero Fassino, Cecilia D'Elia, Riccardo Magi, segretario di +Europa, Tino Magni di Avs, Ivan Scalfarotto di Iv, Gisella Naturale del M5s e Marco Lombardo di Azione.
Ma se l’appello alla politica è quello di restare compatta, la politica non sembra ascoltare. Proprio stamattina il M5s si è astenuto su una risoluzione votata all'unanimità dalla commissione Esteri di Palazzo Madama “Non mi sorprende”, dice Tabrizi. “È il tempo dell’unità, ora, non delle differenze sulle mozioni”, è invece il commento di Sensi.

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato che la vede imputata a Milano per truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali "Pandoro Balocco Pink Christmas" (Natale 2022) e "Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate" (Pasqua 2021 e 2022)".
"Siamo tutti commossi. Ringrazio i miei avvocati e i miei follower che, per due anni, mi hanno sostenuta fino a qui", ha detto l'influencer subito dopo l'assoluzione. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Ilio Mannucci Pacini che ha dichiarato il "non luogo a procedere per accettazione di remissione di querele". L'esito è legato al mancato riconoscimento da parte del tribunale dell'aggravante. Il reato di truffa aggravata è infatti procedibile d'ufficio, mentre per quella semplice serve una querela (che però è stata ritirata in un secondo momento dall'associazione dei consumatori Codacons dopo l'accordo extragiudiziale sui risarcimenti con Ferragni). Il reato di truffa, dal punto di vista tecnico, è così stato dichiarato estinto e Ferragni è stata prosciolta con sentenza di non doversi procedere da parte del giudice.
Si chiude così il cosiddetto "Pandorogate", per lo meno a livello processuale. La procura di Milano, con l'aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli, aveva chiesto per Ferragni una condanna a un anno e otto mesi. Secondo l'accusa, l'imprenditrice digitale avrebbe ottenuto, tramite le due campagne commerciali tra il 2020 e il 2021, un presunto ingiusto profitto per circa 2,2 milioni di euro. L'imprenditrice della moda, assistita dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, si è sempre dichiarata innocente ed ha già effettuato risarcimenti e donazioni per 3,4 milioni di euro. Sono stati assolti sempre con la formula del "non luogo a procedere" anche il suo ex braccio destro, Fabio Damato, e Francesco Cannillo, presidente del cda di Cerealitalia. Per loro i pm avevano chiesto rispettivamente la condanna di un anno e otto mesi e di un anno.


Le retribuzioni reali sono ancora sotto i livelli del 2020-2021. Da questo punto di vista persino i record occupazionali non sono una buona notizia. La questione salariale è stata riscoperta nel 2025, nel 2026 si dovrà agire: l’occasione è la legge delega.
L'articolo È l’ora di pensare seriamente ai salari proviene da Lavoce.info.
Ieri c’è stato l’ennesimo sciopero dei taxi. Non protestano contro una riforma: chiedono più privilegi. A dispetto di innumerevoli tentativi di revisione, la legge che disciplina al settore risale al 1992: appena un anno dopo l’introduzione del protocollo http (la preistoria di internet), contemporaneamente al lancio del Nokia 1011 (il primo telefono cellulare Gsm disponibile in commercio) e quindici anni prima del primo iPhone. Nel frattempo è cambiato tutto, ma la legislazione sulle autopubbliche no. Infatti, i tassisti si oppongono a qualunque tentativo di aggiornarla. A parole, il loro nemico numero uno sono ancora le piattaforme (e in particolare Uber, che in Italia – diversamente dalla maggior parte degli altri paesi – consente solo di prenotare auto con conducente professionista, sia esso un tassista o un ncc). Lo stesso Loreno Bittarelli, presidente dell’Unione Radiotaxi d'Italia e del consorzio itTaxi, ha spiegato al Foglio che gli intermediari online non sono il nemico ma un’opportunità. La realtà è che i tassisti odiano le piattaforme perché temono che aprano le porte alla concorrenza degli ncc. Recentemente, la Corte costituzionale ha accolto il ricorso del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, contro l’obbligo per gli ncc di sostare almeno venti minuti tra una corsa e l’altra e quello di utilizzare una app del ministero per registrare i servizi. In ballo, dunque, non c’è la minaccia della liberalizzazione: c’è semmai la pretesa di forzare una legge obsoleta, contro il diritto e contro la storia, per renderla ancora più impermeabile al tempo che passa. I tassisti, che hanno cacciato da Piazza Colonna il segretario dei Radicali Matteo Halissey e il giornalista Ivan Grieco, hanno ottenuto una convocazione dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, il quale però difficilmente potrà accoglierne le richieste. Nessuna delle forze dell’attuale maggioranza, men che meno la Lega, è mai stata ostile ai tassisti. Avendoli abituati a vincere semplicemente alzando la voce (e occasionalmente menando le mani) oggi il centrodestra raccoglie ciò che ha seminato: non la gratitudine dei tassisti ma la loro prepotenza.

La sinistra che dice sì al referendum sulla giustizia è una specie di album di famiglia del progressismo liberale e garantista, che è stata la versione più interessante dell’evoluzione della sinistra post-comunista. L’ex presidente della Consulta, Augusto Barbera, ha espresso questo senso di continuità affermando che quella di Nordio “è una riforma liberale che per la sorte della storia è stata portata avanti, nell’ultimo tratto, da forze politiche che si richiamano a ‘legge e ordine’”, ma che esprime principi che “invece appartengono a un patrimonio della sinistra e del centrosinistra”. Il fatto stesso che sia una personalità che ha ottenuto la massima rappresentanza della sinistra nell’organo che vigila sull’osservanza della Carta costituzionale a pronunciarsi in questo modo rende evidente la strumentalità delle accuse rivolte alla legge Nordio di manipolare i principi costituzionali. Si tratta peraltro di argomenti già ampiamente illustrati da Stefano Ceccanti, professore di diritto costituzionale e leader del movimento Libertà Eguale, che da 25 anni sostiene la separazione delle carriere. Il punto di partenza di tutti è la riforma di Giuliano Vassalli, che trasforma il processo da inquisitorio in accusatorio, richiedendo la reciproca indipendenza di accusatori e giudicanti.
La sinistra per il sì aspira a ricoprire un ruolo simile a quello che a suo tempo fu esercitato dalla piccola ma storicamente decisiva pattuglia dei “cattolici per il no” all’abrogazione della legge sul divorzio. La sinistra per il sì, peraltro, non si presenta come una rottura: rivendica anzi la coerenza con la tradizione della sinistra italiana, persino con le sue proposte recenti contenute nel programma elettorale del Pd del 2022, che voleva togliere al Csm dominato dalle correnti la giurisdizione sui magistrati. Non si tratta di una rivincita dei sconfitti o del preannuncio di nuove scissioni: la sinistra per il sì resta a sinistra e voterà a sinistra alle elezioni, ma non vuole una sinistra accodata all’asse tra Conte e Landini. Su questo troverà spazio e consenso nella sinistra riformista anche dopo il referendum sulla giustizia.

Non è né popolare né sciolto come Angela Merkel, la cancelliera venuta dall’est, ma non passa neppure per un leader algido e ingessato come Olaf Scholz da Amburgo. Ogni leader tedesco ha i propri pregi e il renano Friedrich Merz, fra i suoi, conta il parlar chiaro. A volte anche troppo, come quando lo scorso ottobre ha creato un putiferio in patria affermando che il suo governo sta facendo molto in tema di migrazione “ma naturalmente abbiamo sempre questo problema nel paesaggio urbano e per questo lavoriamo a rimpatri su larga scala”. Ieri il cancelliere della Cdu si è espresso su un tema che gli riesce meglio: la politica internazionale. Da Bangalore, la Silicon Valley dell’India, dove è in visita, Merz ha parlato della leadership iraniana senza usare perifrasi: “Presumo che stiamo assistendo agli ultimi giorni e alle ultime settimane di questo regime”. Un’uscita che ha colpito per la schiettezza e i media tedeschi si sono domandati se il cancelliere abbia parlato così perché al corrente di qualcosa che i Herr e le Frau Müller ignorano. Ma il suo ragionamento attiene al meccanicismo. D’altronde, ha osservato, “se un regime resta al potere solo con la violenza, allora è di fatto alla fine”. Fra l’auspicio e la profezia, il cancelliere tedesco dimostra coerenza a se stesso – solo lunedì aveva condannato con forza la violenza “sproporzionata” e “brutale” delle forze di sicurezza iraniane a danno dei manifestanti – e al quadro di riferimento atlantico che ha instradato la sua intera carriera politica. Non è un caso che un imprevedibile Donald Trump sempre pronto a maltrattare ospiti e alleati lo abbia accolto da vero amico alla Casa Bianca. Lontano anni luce dagli sbandamenti ora terzomondisti ora sedicenti anticolonialisti o anti-islamofobi di troppi leader europei affetti da tafazzismo incurabile, Merz è lo stesso cancelliere che mesi fa disse ad alta voce quello che nessuno osava dire: combattendo contro il jihadismo “Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi”.

Non vi è alcun nesso di causalità tra l’espianto degli ulivi dal cantiere Tap e la loro morte. Lo ha stabilito il Tribunale di Lecce nella sentenza con cui ha assolto i 18 dirigenti Tap rimasti alla sbarra per sette anni. Sette i reati che venivano loro contestati: deturpamento di bellezze naturali, danneggiamento, violazione del testo unico in materia edilizia, inquinamento ambientale per i lavori di realizzazione del tratto terminale salentino del gasdotto. Ma il fatto non sussiste. La sentenza è chiara: quegli ulivi non sono morti per colpa di Tap (la Trans-Adriatic Pipeline, che passa dalla Puglia) ma della Xylella. Anche se il sindaco di Lecce e tutti i suoi colleghi del Salento non ci credevano e hanno fatto causa a Tap chiedendo risarcimenti, mentre proprio loro contribuivano a far diffondere la Xylella impugnando i decreti che imponevano l’abbattimento degli ulivi nelle zone infette.
Eppure alla sbarra ci sono finiti gli uomini che, costruendo Tap tra mille ostacoli, hanno salvato l’Italia consentendoci di liberarci dal gas di Putin. Per realizzare quest’opera spostarono gli ulivi, li conservarono in serre e poi li reimpiantarono. Non come sta facendo oggi Acquedotto Pugliese sul fiume Tara, dove per realizzare un dissalatore sono stati rasi al suolo migliaia di ulivi, agrumeti e vigneti. Dove sono oggi Michele Emiliano, gli ambientalisti e i matti che si incatenano agli ulivi? Il Tribunale, dopo sette anni, ha escluso l’illiceità della condotta, rilevando che le operazioni erano conformi alla normativa regionale in materia di tutela degli ulivi monumentali, in particolare alla legge della Regione Puglia e alla relativa deliberazione di Giunta. Assente, secondo i giudici, anche l’elemento soggettivo del dolo, in considerazione delle cautele adottate durante l’espianto e la successiva custodia degli alberi. Chi ha costruito Tap non ha commesso reati e non ha ucciso gli ulivi. Chi non ha fermato la Xylella, sì. Ma la procura ha perseguitato gli uni anziché gli altri.

"C’era un silenzio tremendo. I genitori erano tutti in una stanza, qualcuno sorseggiava una bevanda calda. Nessuno parlava. L’attesa era la cosa più straziante”. A parlare è la dot... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Non è una novità che in Svizzera i germanofoni guardino con sufficienza i francofoni. E non è una novita che i francofoni guardino con altrettanta sufficienza i germanofoni. Solo solo su una cosa si trovano d'accordo: guardare con sufficienza ancor maggiore gli italofoni. La strage di Crans-Montana però sta esasperando questa tendenza insita nell'animo elvetico, quello scontro culturale tra chi pensa in tedesco e chi pensa in francese.
È dalla notte di Capodanno che i media e la gran parte dei cittadini germanofoni guardano increduli quanto accaduto nel paese del Cantone Vallese. Contestano tre cose principalmente: lassismo, imperizia e omertà. Il sottotesto è semplice: da noi una cosa del genere non sarebbe potuta mai accadere. Sono stati criticati i soccorsi, i controlli mancati, la scelta di non arrestare immediatamente i due proprietari del Constellation.
Il Tages-Anzeiger, il Blick e il Neue Zürcher Zeitung hanno coperto la tragedia continuando a segnalare sottotraccia la differenza tra un loro, francofoni, e un noi, germanofoni, spesso arrivando a riprodurre la realtà in chiave grottesca negli editoriali.
"E questo è qualcosa di normale e sorprendete allo stesso tempo", dice al Foglio Antoni Pauli, storico delle relazioni intercantonali svizzere. "Perché nel caso della strage di Crans-Montana, che non poteva non sconvolgere l'intero paese, si è assistita una translocazione di tutti i pregiudizi che solitamente i cantoni tedeschi avevano sui ticinesi nei confronti della popolazione francofona: pressapochismo, faciloneria, omertà, mancanza di controllo del territorio, sono diventati in pochi giorni caratteristiche del popolo francofono, mentre per decenni queste esse venivano riscontrate prevalentemente e quasi esclusivamente tra le persone italiofone".
Lo studioso cita come esempio lampante l'articolo che il giornalista vallese di lingua tedesca Samuel Burgener ha scritto sulla Neue Zürcher Zeitung. Un articolo che parte da tutte le tragedie che hanno colpito la zona, quasi tutte naturali, come "valanghe di Reckingen ed Evolène, il crollo del ghiacciaio del bacino di Mattmark, le frane di Blatten e Randa, la frana di Gondo, tutte le inondazioni e le colate di fango, gli incidenti d'autobus a Sierre e Orsières, i devastanti incendi boschivi di Leuk, Visp e Bitche", per evidenziare come in buona parte di queste fosse emersa una preoccupante omertà di istituzioni e opinione pubblica, "una cultura del silenzio nella quale può diventare difficile stabilire una verità". Nel suo articolo, Burgener sottolinea come "il Vallese, come lo definì una volta lo scrittore Kurt Marti, è una valle del silenzio. O meglio: una valle dove il silenzio è obbligatorio. Il controllo sociale nei villaggi è efficace e l'ostracismo sociale incombe. È sempre stato così. La gente teneva la bocca chiusa, in parte per paura delle autorità. Rimaneva in silenzio quando gli insegnanti urlavano e picchiavano, e i preti predicavano e insultavano. Quando gli imprenditori edili insabbiavano e imbrogliavano, e i politici promettevano e mentivano".
Un atteggiamento che è diventato un modus operandi amministrativo, "perché nel Vallese, tutto ruota attorno al turismo, questa ancora di salvezza, e ai soldi che si devono guadagnare in poche settimane all'anno, durante l'alta stagione, frenetica e ubriaca. Non servono a nulla costose normative per le attività commerciali. Nessun rigido controllo all'ingresso per tenere i minorenni fuori dai bar. Nessun severo divieto di fuochi d'artificio. Champagne e soldi devono continuare a scorrere. Deve continuare, per giorni, settimane, generazioni".
"Omertà, imbrogli, corruzione e voglia di arricchirsi erano le caratteristiche degli italiani", spiega Pauli. Che queste siano ora traslate verso la popolazione francofona "è una novità recente, qualcosa che si è iniziata ad intravedere durante la pandemia di Covid, ma sottotraccia, diventata palese dopo i tragici eventi di Capodanno".

Possedere le più vaste riserve provate al mondo di petrolio e non essere riusciti a garantire crescita e stabilità economica al paese: è il paradosso del Venezuela. Che in larga parte si spiega con la parabola della compagnia petrolifera nazionale: fattori istituzionali, tecnologici e geopolitici hanno progressivamente eroso la sua capacità di trasformare un enorme […]
L'articolo Il Punto proviene da Lavoce.info.
Il Venezuela dimostra che l’abbondanza di petrolio non garantisce automaticamente crescita e stabilità. Anzi, la crisi della compagnia petrolifera statale evidenzia i limiti strutturali dei modelli di sviluppo basati sulla rendita delle risorse naturali.
L'articolo Petrolio e povertà: il paradosso del Venezuela proviene da Lavoce.info.
Secondo il “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi” del Mase, guidato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, il “diffe... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti
