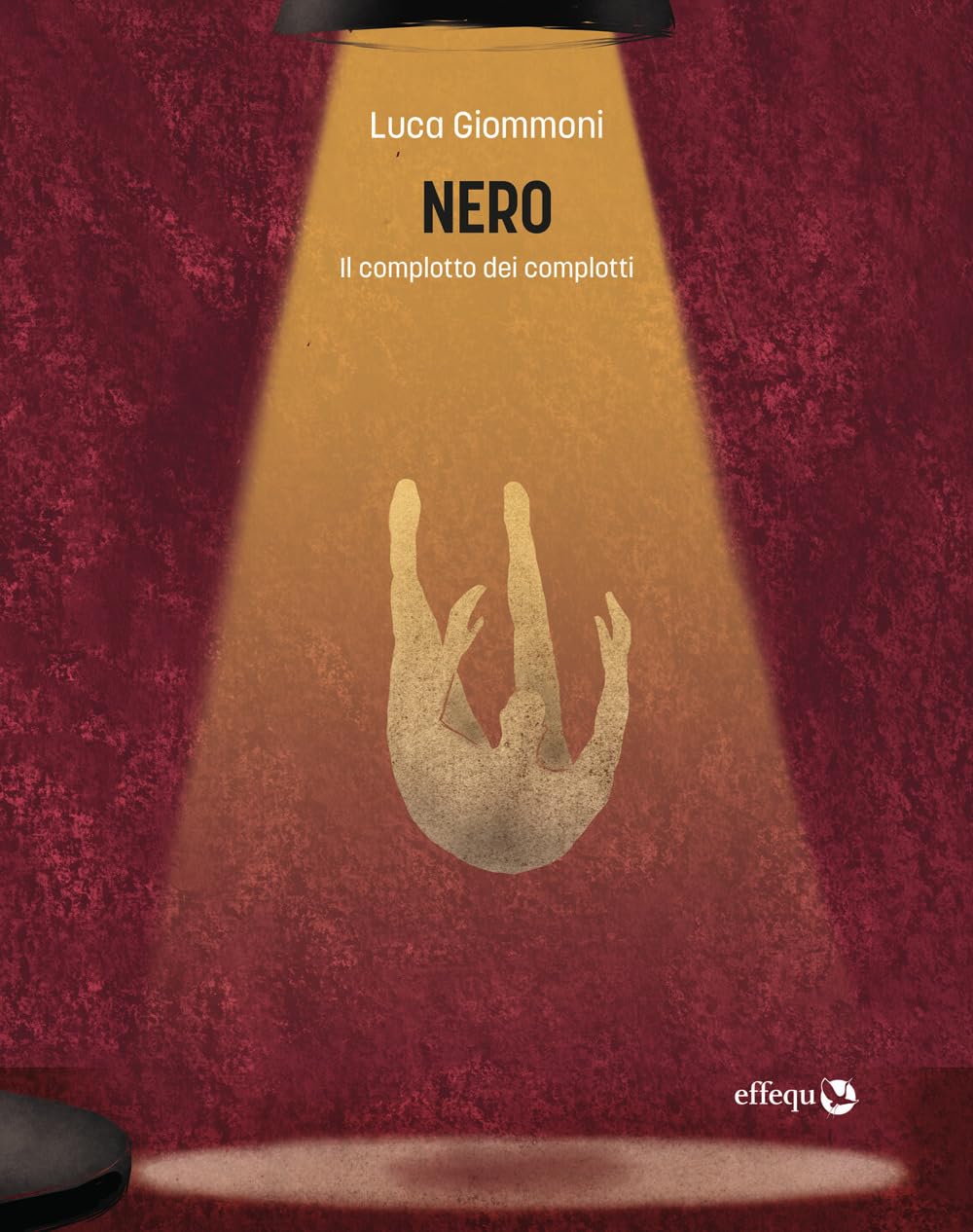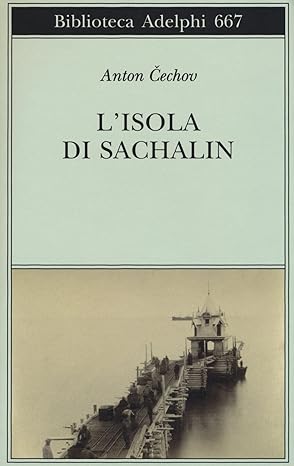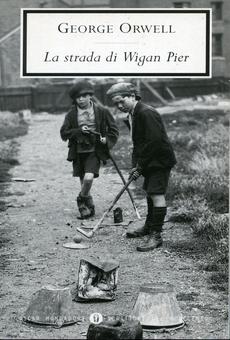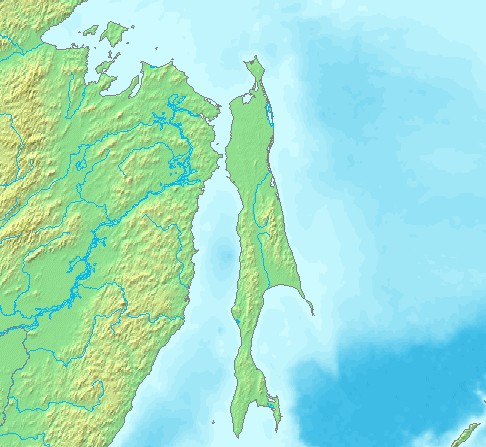Quando le fonti divergono. La profondità delle zone grigie. Intervista all’archeologo Andrea Augenti (parte uno)
di Valentina Cabiale
 Andrea Augenti è docente di Archeologia Medievale all’Università di Bologna dal 2000. Ha condotto indagini in molti siti d’Italia e ha diretto gli scavi del quartiere portuale e del complesso di San Severo a Classe (Ravenna). Attualmente dirige lo scavo della città abbandonata di Cervia Vecchia (RA). È membro della redazione della rivista Archeologia Medievale, della Società degli Archeologi Medievisti Italiani e della Society for Medieval Archaeology e Fellow della Society of Antiquaries of London. È autore di numerose pubblicazioni, tra le quali Archeologia dell’Italia medievale, Laterza, Roma-Bari 2016; A come Archeologia, Carocci, Roma 2018; Prima lezione di archeologia medievale, Laterza, Roma-Bari 2020; Scavare nel passato, Carocci, Roma 2020. Il suo ultimo libro è Archeologi. I maestri del passato, Carocci, Roma 2025.
Andrea Augenti è docente di Archeologia Medievale all’Università di Bologna dal 2000. Ha condotto indagini in molti siti d’Italia e ha diretto gli scavi del quartiere portuale e del complesso di San Severo a Classe (Ravenna). Attualmente dirige lo scavo della città abbandonata di Cervia Vecchia (RA). È membro della redazione della rivista Archeologia Medievale, della Società degli Archeologi Medievisti Italiani e della Society for Medieval Archaeology e Fellow della Society of Antiquaries of London. È autore di numerose pubblicazioni, tra le quali Archeologia dell’Italia medievale, Laterza, Roma-Bari 2016; A come Archeologia, Carocci, Roma 2018; Prima lezione di archeologia medievale, Laterza, Roma-Bari 2020; Scavare nel passato, Carocci, Roma 2020. Il suo ultimo libro è Archeologi. I maestri del passato, Carocci, Roma 2025.
Come racconteresti in breve la tua biografia professionale?
Ho studiato all’università La Sapienza a Roma ma tutto comincia da prima. Mio padre era un sindacalista della CGIL animato da varie passioni che in parte ho ereditato, come quelle per il jazz, la geologia e l’archeologia, e mia madre una storica dell’età contemporanea, Andreina De Clementi (dalla quale ho sicuramente preso la passione per la storia e per i libri). Un giorno mio padre è tornato a casa con la guida archeologica di Roma scritta da Filippo Coarelli mentre a un Natale mi ha regalato Civiltà sepolte di C.W. Ceram. Poi, al liceo, ho fatto un viaggio in Grecia e sono rimasto folgorato. In quegli anni, di mattina andavo a scuola, di sera mi allenavo a pallavolo e un pomeriggio a settimana andavo ad ascoltare le “lezioni planetarie” di Coarelli, al Planetario di piazza Esedra a Roma. Erano conferenze aperte al pubblico, che poi hanno costituito i nuclei dei suoi libri monografici sul Foro Boario, il Campo Marzio, ecc. Una grande scuola. Quando mi sono iscritto all’università avrei voluto fare l’egittologo. Ricordo ancora la prima lezione del professor Sergio Donadoni; era bravissimo, impressionante. Però, come faceva un po’ con tutti, mi sconsigliò di proseguire in quel campo. Sapeva che l’egittologia affascina tutti e se tu ti mostravi interessato, che so, ad Akhenaton, il padre di Tutankhamon, storceva il naso, perché era una figura troppo gettonata. Quando gli portai il piano di studi, per l’approvazione, Donadoni vide che avevo inserito l’esame di Metodologia della ricerca archeologica, che era stato appena introdotto all’università (siamo a metà degli anni Ottanta) e mi disse: “Guardi che se vuole fare l’egittologo le servirebbe molto di più un esame di montaggio e rimontaggio di una jeep, però mi sa che questo esame non c’è”. Iniziai a capire che l’egittologia non era la mia strada. Nello stesso momento un conoscente, archeologo mi disse che l’archeologia medievale era un campo interessante e in forte espansione. Dopo un anno di transizione durante il quale ho avuto la fortuna di seguire i corsi (Topografia antica, Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi, Urbanistica del mondo romano) di alcuni professori bravissimi (Ferdinando Castagnoli, Cairoli Fulvio Giuliani, Paolo Sommella) e poi di intellettuali davvero strepitosi come Armando Petrucci e Girolamo Arnaldi, ho sterzato verso il Medioevo. Mi sono laureato in archeologia medievale con Letizia Pani Ermini e poi sono andato a lavorare sul Palatino, a Roma, negli scavi di Andrea Carandini. Ero fuori contesto, in quello scavo di medievale c’era ben poco: Rodolfo Lanciani e soprattutto Giacomo Boni nelle indagini precedenti avevano asportato tutte le stratigrafie post-romane. Ma è stato un periodo importante, anche perché Carandini mi ha presentato a Riccardo Francovich, che insegnava archeologia medievale a Siena. Ho vinto un dottorato, poi ho avuto un insegnamento a contratto a Siena e subito dopo è partito il progetto di schedatura dei castelli della Toscana. Dopo aver perso svariati concorsi, mi sono detto: se allo scadere dei 36 anni, che cadevano nel 2000, non sarò entrato nell’università, cambio mestiere. Nell’aprile del 2000 ho vinto il concorso per entrare nell’università di Bologna.
Negli ultimi anni hai fatto diversi podcast per Rai Radio 3, su tematiche archeologiche: Dalla terra alla storia, Vite tra le rovine, Ritorno al passato, Mappe del tempo. Podcast che in parte sono diventati anche libri: A come archeologia (Carocci, 2018), Scavare nel passato. La grande avventura dell’archeologia (Carocci, 2020) e, ultimo, Archeologi. I mastri del passato (Carocci, 2025). Come sei arrivato alla radio e come ti sei trovato con un sistema di comunicazione puramente orale? L’archeologo si occupa di cultura materiale, le cose sono importanti e anche le immagini di quelle cose, che con questo media non puoi utilizzare.
 Sono un accanito ascoltatore di Radio 3 sin da quando ho iniziato l’università. La radio ha contato moltissimo nella mia formazione, e in particolare tutti i programmi della gestione di Marino Sinibaldi e quelli precedenti all’attuale Fahrenheit. L’atteggiamento analitico e critico nei confronti del cinema, della musica, della letteratura sono stati una grande scuola. A un certo punto c’era un programma di Monica d’Onofrio intitolato Museo Nazionale, da cui è poi scaturito il libro omonimo, che raccontava singole opere d’arte e monumenti. Monica alcuni anni fa si è rivolta a me per registrare un paio di puntate, durante una delle feste di Radio Tre a Forlì. Dopo, le ho proposto di fare qualcosa insieme, dato che non avevano ancora mai pensato a un programma di archeologia. Ho mandato un progetto a lei e a Sinibaldi e hanno accettato: così è partito tutto.
Sono un accanito ascoltatore di Radio 3 sin da quando ho iniziato l’università. La radio ha contato moltissimo nella mia formazione, e in particolare tutti i programmi della gestione di Marino Sinibaldi e quelli precedenti all’attuale Fahrenheit. L’atteggiamento analitico e critico nei confronti del cinema, della musica, della letteratura sono stati una grande scuola. A un certo punto c’era un programma di Monica d’Onofrio intitolato Museo Nazionale, da cui è poi scaturito il libro omonimo, che raccontava singole opere d’arte e monumenti. Monica alcuni anni fa si è rivolta a me per registrare un paio di puntate, durante una delle feste di Radio Tre a Forlì. Dopo, le ho proposto di fare qualcosa insieme, dato che non avevano ancora mai pensato a un programma di archeologia. Ho mandato un progetto a lei e a Sinibaldi e hanno accettato: così è partito tutto.
Sicuramente è strano parlare in studio, con un muro e al massimo un tecnico del suono davanti, così come farlo in casa, da solo. Stranissimo non poter usare le immagini e descrivere oggetti che non si vedono. In questo campo il maestro è stato Neil Mc Gregor, ex-direttore del British Museum, con La storia del mondo in 100 oggetti (Adelphi, 2015), libro nato a partire proprio da un podcast. È uno dei libri più belli nell’ambito della comunicazione storico-archeologica. A forza di fare podcast, ora mi vengono naturali e la mia scrittura è cambiata. A un certo punto hanno iniziato a starmi stretta la scrittura accademica e tutti gli arcaismi terminologici e sintattici, nella costruzione di una frase. Ho lavorato per arrivare a un discorso più diretto, tanto che adesso non riesco più a scrivere nel modo di prima neanche per le riviste specialistiche. Non a caso di recente un articolo mi è stato rimandato indietro con la motivazione che era scritto in maniera troppo colloquiale. Ma io ormai scrivo così, prendere o lasciare.
D’altra parte si possono dire cose complesse anche con un linguaggio molto semplice.
Assolutamente sì. In questo gli anglofoni sono maestri. Credo che la radio sia stata una grande palestra. Quando rileggo mi accorgo sempre che ci sono troppi incisi o parentesi che interrompono il discorso. Meglio spezzare la frase in due parti. L’altra peculiarità del lavorare in radio è che le reazioni del pubblico sono rare. Ogni tanto mi arrivano delle mail. Una volta una signora di Napoli mi ha scritto che ha ascoltato una mia puntata sulla città antica di Pompei mentre cucinava il sugo, e si è messa a piangere. Due ragazzi, invece, mi hanno scritto dall’Islanda ringraziandomi perché mi ascoltavano tutte le mattine con le cuffie facendo jogging tra i ghiacci. Quest’anno per la prima volta nella mia vita ho aperto un profilo Facebook, ho toccato con mano che esiste un folto pubblico di appassionati e ho letto commenti positivi e lusinghieri. Quindi la cosa funziona. Il motivo principale per cui ho pensato a questo programma è che sono stufo di vedere la divulgazione fatta come se non richiedesse uno specialismo. A me Alberto Angela (di formazione paleontologo) che una sera fa una puntata su Collasso (Einaudi, 2014) di Jared Diamond e la settimana successiva sulle pitture della cappella Sistina, lascia perplesso. Veicola l’idea che la cultura sia tutta uguale. Non voglio fare una petizione banale del tipo “l’archeologia agli archeologi”, però se parli di una cosa devi conoscerla. C’è un pensiero di sottofondo che l’archeologia sia di tutti, il che è anche vero, ma se la vuoi raccontare non puoi improvvisarti. In ogni puntata tento di mostrare che l’archeologia è radicata nel mondo che la circonda, non è un microcosmo a parte. Cerco di spiegare qual è stata l’impostazione della ricerca, il metodo, e il retrobottega della scoperta. A volte riesco a raccontare meglio un’idea se ancoro l’attenzione sul personaggio che l’ha avuta, e questo è stato il format del Podcast Vite tra le rovine, che poi è diventato il libro Archeologi.
Volevo porti una domanda riguardo al pubblico delle tue trasmissioni radiofoniche. Tra l’altro, quando penso alla divulgazione in archeologia e al pubblico “indifferenziato” a cui immaginiamo che questa divulgazione sia rivolta, mi viene sempre in mente una cosa che sentii dire dal professor Guido Vannini, tuo collega in archeologia medievale. Disse una volta che il pubblico indifferenziato non esiste. Di fronte puoi avere un falegname, una parrucchiera, una business manager, un muratore, uno studente, ovvero un pubblico composto da individui ciascuno con le sue specializzazioni e competenze. È una visione che mi piace perché è orizzontale e non verticale e pone l’attenzione sul fatto che ciascuna delle persone di quel pubblico è portatrice di un sapere. I riscontri che ricevi ti permettono di ipotizzare approssimativamente da quali persone è composto il tuo pubblico; esso coincide con quello che desideri?
Il mio pubblico è composto da persone che probabilmente hanno una cultura abbastanza elevata, ma in realtà ne so ben poco; credo che in media abbiano tra i 50 e gli 80 anni. Se riesco a spiegare alla signora a cui piace Gustav Mahler che Giacomo Boni è uno di coloro che hanno introdotto il metodo stratigrafico in archeologia in Italia, a inizio Novecento, sento di aver fatto qualcosa di importante. Però mi piacerebbe che il pubblico fosse anagraficamente più trasversale e che ci fossero più giovani, ma forse c’è un problema strutturale di base: la maggior parte dei giovani non ascolta la radio e non conosce la piattaforma RaiPlay Sound.
Gli archeologi ti ascoltano?
Pochissimi mi testimoniano interesse e stima per questa cosa; alcuni me ne parlano e dimostrano attenzione ma soltanto quando li incontro; e poi ci sono quelli che non mi dicono nulla. Diciamo che non ho un riscontro ampio da parte della comunità degli archeologi. Ma forse dipende dal fatto che molti non ascoltano la radio, oppure discende da quella sorta di freno che impedisce a tanti di fare complimenti o osservazioni ai colleghi. Io, spesso, se leggo una cosa che mi piace tanto, telefono o scrivo all’autore. La reazione di solito è sbigottita. In Italia non c’è questa abitudine, diversa è la situazione tra gli archeologi all’estero, con i quali ho sempre avuto un legame preferenziale. Tra di loro c’è meno difficoltà a riconoscere il valore degli altri o semplicemente l’exploit occasionale.
Hai scritto che la scoperta della tomba di Tutankhamon nel 1922, molto nota anche ai non addetti ai lavori, è stato l’evento che ha segnato la “perdita dell’innocenza dell’archeologia”, nel senso che gli archeologi si sono resi conto che l’archeologia aveva un grande appeal che poteva essere sfruttato. Lord Carnarvon, il finanziatore dello scopritore Howard Carter, vende l’esclusiva della scoperta al Times. C’è una foto famosa con i due affiancati, prima che Carter entri nella tomba. In realtà questa immagine è falsa, costruita a tavolino, dopo che Carter era già entrato.
Ma di false immagini nella storia dell’archeologia ce ne sono altre e la più nota è forse quella di Sofia Enkastrōmenou, la moglie di Heinrich Schliemann, che indossa i gioielli del c.d. Tesoro di Priamo rinvenuto a Troia nel 1873. È stato dimostrato che la moglie non era presente sullo scavo al momento del ritrovamento, diversamente da quanto Schliemann raccontò nella storia della scoperta. Come mai vedi la “perdita dell’innocenza” dell’archeologia proprio nel 1922?
 Beh, intanto tra Schliemann e Carter ci sono alcune differenze. Quella della scoperta di Troia è una storia veramente al limite del losco. Schliemann ha dei meriti, però era un terribile bugiardo e il suo comportamento nei confronti di Frank Calvert, il primo ad aver ipotizzato di poter trovare i resti della città di Troia sulla collina di Hissarlik, è stato molto scorretto. Si è impadronito del sito, aveva i mezzi economici per farlo. Ma secondo me c’è stata una perdita dell’innocenza maggiore nel caso della scoperta della tomba di Tutankhamon per la sistematicità della messinscena, per l’operazione messa in atto non solo da parte del finanziatore Lord Carnarvon, ma anche di Carter, che era un archeologo (a differenza di Schliemann). Poi, per carità, Carter ha lavorato duramente, ha trascorso tutta la vita a catalogare gli oggetti della tomba pur non riuscendo a completare la pubblicazione, però ha contribuito a tingere di artificio la storia della scoperta. Questo è stato fatto talmente bene che ne è venuta fuori una Tut-mania, mentre non c’è mai stata una Troy-mania. Forse la cosa ha funzionato proprio perché aveva un’anima forte di scientificità; solo in seguito è arrivata la faccenda della maledizione, si è cominciato a scrivere romanzi sulla mummia e via dicendo. Carter ha incarnato alla perfezione il principale topos identitario dell’archeologo, ovvero il disturbatore di morti, che è una figura più affascinante dell’archeologo che scopre siti. Troia è ovviamente intrigante perché si interseca con la narrazione di Omero, però non c’è paragone, mancano tutti gli spunti per le derive horror e splatter. Questa idea dell’archeologo che sta sul crinale tra la vita e la morte, alle prese con un cadavere e con una civiltà lontana ma vicina, africana ma quasi europea, è troppo attraente. Un altro archeologo che ha contribuito alla perdita dell’innocenza dell’archeologia, e siamo di nuovo a metà degli anni Venti, è Mortimer Wheeler, che si mette a vendere dei sassi provenienti dal sito dell’età del Ferro di Maiden Castle. Lo fa per finanziarsi lo scavo, ma certo è un gioco ardito e discutibile. Dopo si è scoperto che molte di quelle pietre non provenivano neppure da Maiden Castle. Anche Wheeler aveva intuito che l’archeologia attira il pubblico, e che questo si può sfruttare.
Beh, intanto tra Schliemann e Carter ci sono alcune differenze. Quella della scoperta di Troia è una storia veramente al limite del losco. Schliemann ha dei meriti, però era un terribile bugiardo e il suo comportamento nei confronti di Frank Calvert, il primo ad aver ipotizzato di poter trovare i resti della città di Troia sulla collina di Hissarlik, è stato molto scorretto. Si è impadronito del sito, aveva i mezzi economici per farlo. Ma secondo me c’è stata una perdita dell’innocenza maggiore nel caso della scoperta della tomba di Tutankhamon per la sistematicità della messinscena, per l’operazione messa in atto non solo da parte del finanziatore Lord Carnarvon, ma anche di Carter, che era un archeologo (a differenza di Schliemann). Poi, per carità, Carter ha lavorato duramente, ha trascorso tutta la vita a catalogare gli oggetti della tomba pur non riuscendo a completare la pubblicazione, però ha contribuito a tingere di artificio la storia della scoperta. Questo è stato fatto talmente bene che ne è venuta fuori una Tut-mania, mentre non c’è mai stata una Troy-mania. Forse la cosa ha funzionato proprio perché aveva un’anima forte di scientificità; solo in seguito è arrivata la faccenda della maledizione, si è cominciato a scrivere romanzi sulla mummia e via dicendo. Carter ha incarnato alla perfezione il principale topos identitario dell’archeologo, ovvero il disturbatore di morti, che è una figura più affascinante dell’archeologo che scopre siti. Troia è ovviamente intrigante perché si interseca con la narrazione di Omero, però non c’è paragone, mancano tutti gli spunti per le derive horror e splatter. Questa idea dell’archeologo che sta sul crinale tra la vita e la morte, alle prese con un cadavere e con una civiltà lontana ma vicina, africana ma quasi europea, è troppo attraente. Un altro archeologo che ha contribuito alla perdita dell’innocenza dell’archeologia, e siamo di nuovo a metà degli anni Venti, è Mortimer Wheeler, che si mette a vendere dei sassi provenienti dal sito dell’età del Ferro di Maiden Castle. Lo fa per finanziarsi lo scavo, ma certo è un gioco ardito e discutibile. Dopo si è scoperto che molte di quelle pietre non provenivano neppure da Maiden Castle. Anche Wheeler aveva intuito che l’archeologia attira il pubblico, e che questo si può sfruttare.
Pensi realmente che ci sia stata una fase in cui l’archeologia è stata innocente?
 Mah, se ci pensi, ad esempio in Italia Rodolfo Lanciani è stato uno che ha puntato molto e in modo assolutamente pulito sull’archeologia, scriveva abitualmente su quotidiani italiani e inglesi raccontando le scoperte a Roma. Però tutto sommato faceva il cronista, non c’era una idea di mercificazione. Carnarvon invece vende l’esclusiva al Times per rientrare delle spese messe in campo per le ricerche di Carter. E quindi poi lui e Carter devono costruire un racconto che consenta quel ritorno economico. Non storco il naso, però è evidente che quello è il momento in cui l’archeologia sfonda il muro dello specialismo che fino a quel momento ne aveva impedito la diffusione massiccia nei media.
Mah, se ci pensi, ad esempio in Italia Rodolfo Lanciani è stato uno che ha puntato molto e in modo assolutamente pulito sull’archeologia, scriveva abitualmente su quotidiani italiani e inglesi raccontando le scoperte a Roma. Però tutto sommato faceva il cronista, non c’era una idea di mercificazione. Carnarvon invece vende l’esclusiva al Times per rientrare delle spese messe in campo per le ricerche di Carter. E quindi poi lui e Carter devono costruire un racconto che consenta quel ritorno economico. Non storco il naso, però è evidente che quello è il momento in cui l’archeologia sfonda il muro dello specialismo che fino a quel momento ne aveva impedito la diffusione massiccia nei media.
E da quel momento, forse, gli archeologi sono condannati a fingere sempre l’istante della scoperta. È qualcosa che c’è un po’ in tutti i livelli della divulgazione archeologica e che rischia di mistificare il processo della ricerca, riducendolo al momento in cui qualcosa riappare. Il discorso oggi è ancora più interessante se pensiamo alle possibilità tecnologiche di produrre immagini-fake. Nel 2022 è stata diffusa al pubblico la scoperta archeologica del santuario di età etrusco-romana di San Casciano ai Bagni, in provincia di Siena, e in particolare dei moltissimi reperti, tra cui numerose statue in bronzo, rinvenute nel riempimento di una vasca sacra. La scoperta ha avuto un grande impatto mediatico e la diffusione di molte fotografie delle statue nel momento e nel contesto di ritrovamento. A un certo punto sui social è diventata virale la foto di una statua di adolescente, che emergeva dal fango. Un’immagine presto smascherata dagli addetti ai lavori perché presentava forme e dettagli incongruenti (tra cui anche una mano con sette dita). Era stata prodotta con intelligenza artificiale dall’artista Fabrizio Ajello, che ne ha poi scritto su Art Tribune, dicendo che aveva voluto sperimentare le potenzialità dell’applicazione Midjourney. Un progetto artistico per indagare le dinamiche di interpolazione e diffusione delle immagini sui social. L’immagine non era accompagnata da un esplicito riferimento ai ritrovamenti di San Casciano, che però con ogni evidenza erano stati la sua ispirazione. Secondo te gli archeologi sono più attratti da queste possibilità di generare rappresentazioni verosimili, se non fake, o più preoccupati?
Sto cominciando a vedere l’uso dell’intelligenza artificiale nelle ricostruzioni archeologiche. Di recente ho scritto un articolo sulla pratica delle ricostruzioni (nel primo numero della rivista Evomedio: Oltre la prova. Quello che l’archeologia non dice e come provare a dirlo), che secondo me è utilissima perché ti porta a ragionare in maniera analitica sui dettagli, dall’abbigliamento delle persone ai modi di trattare le figure umane, la forma di un edificio, di un ambiente. Più vado avanti in questo mestiere più credo che il disegno sia essenziale. Quando le planimetrie di uno scavo sono disegnate bene, sono pulite e leggibili, significa che lo scavo è stato fatto bene. Quando vedi pastrocchi vuol dire che qualcosa non è stato capito fino in fondo. Il disegno ti costringe a sostare davanti all’oggetto. L’AI ha un vantaggio enorme perché è veloce, si basa su banche dati immense, però in questo modo si perde l’esercizio del disegno e il risultato è un po’ freddo. Anche perché con l’AI si tende a produrre immagini che sembrano delle fotografie scattate all’epoca. A volte questo accade anche con il disegno. Ad esempio trovo che le ricostruzioni più in voga, quelle dello studio Inklink, siano esteticamente bellissime ma molto assertive. Sono talmente pulite e complete che sembra dicano “è andata proprio così”. Forse si possono studiare altri modi per far capire che non possiamo giurare al 100 % su quello che proponiamo. Il dato esiste ma la ricostruzione nel dettaglio è sempre ipotetica. Sheila Gibson disegnava le figure umane come semplici sagome, dei fantasmini funzionali ad animare la scena e a dare la scala metrica. Non dico che tutti i disegni debbano essere fatti così, ma preferisco questa tendenza ad accennare. Probabilmente dipende anche dall’uso di certe tecniche piuttosto che di altre. Quelli di Inklink usano molto l’aerografo che rende tutto molto naturalistico. Però un conto è la ricostruzione di un luogo tuttora esistente, ad esempio Piazza del Campo a Siena, nel XIV secolo; un altro è quando la base di partenza è uno scavo archeologico. In questo secondo caso un dettaglio preciso secondo me non è onesto intellettualmente. Vicino a Cervia è stata ritrovata una chiesa: ne restano tre pilastri e un muro, per il resto le uniche tracce dell’edificio sono le fosse di spoliazione delle strutture, grazie alle quali possiamo ricostruire l’attacco di un’abside e un transetto. Ci sono almeno tre gradi diversi rappresentabili nella ricostruzione: il grado due (il muro ritrovato, per quanto solo in parte), il grado uno (il negativo del muro) e il grado zero (il muro ipotizzato). Ho fatto disegnare la ricostruzione di quella chiesa distinguendo con colori diversi le parti ritrovate per davvero, le parti ricostruite a partire dalle tracce, le strutture ipotizzate per chiudere in qualche modo la forma architettonica ma che non sono state ritrovate.
Meglio rinunciare al realismo ma essere più onesti, quindi…
Nelle ricostruzioni non possiamo essere realistici. Capisco che sia necessario comunicare in modo chiaro ma vorrei anche che ci fosse una gradazione tra ricostruzioni volte al pubblico e ricostruzioni per gli addetti ai lavori. Oppure cercare altre modalità di rappresentazione. Ad esempio a Ravenna, nel Museo Classis di cui ho redatto il progetto scientifico, abbiamo prodotto tre ipotesi diverse di ricostruzione della Porta Aurea, la porta urbana più importante della città romana, costruita per il ritorno dell’imperatore Claudio dopo la conquista della Britannia nel 43 d.C. Questa porta ha due torri circolari ma non sappiamo se esse siano state aggiunte nella Tarda Antichità, cosa per la quale ci sarebbero vari confronti, o se ci fossero fin dall’inizio, ipotesi per la quale ci sono altri confronti. Credo che ogni tanto l’archeologo debba ammettere di saperne solo fino a un certo punto. Poi dipende sempre da cosa uno vuole veicolare attraverso le immagini.
Questo si aggancia a un’altra cosa che volevo chiederti. È una divagazione. Qualche mese fa su Instagram ho letto un post su Alan Kurdi, il bambino siriano di cui tutti nel 2015 abbiamo visto la foto del corpo disteso prono su una spiaggia lungo la costa turca nei pressi di Bodrum. Un bambino morto in una naufragio. In questo post (“ThePeriod”) si dice che dieci anni fa fummo scioccati da questa fotografia, mentre oggi possiamo vedere centinaia di immagini di questo tipo con minore clamore, molti di noi sono come anestetizzati. Quello è stato il momento, secondo gli autori del post, in cui abbiamo sostituito l’emozione all’azione. In conclusione c’è una domanda: “Vogliamo davvero vedere, o vogliamo solo aver visto?”
Mi rendo conto che partire da questa riflessione e tornare a parlare di archeologia può apparire poco opportuno. Ma lo sguardo è sempre trasversale, e le stesse persone che hanno guardato la foto di Alan Kurdi, che oggi guardano le foto dei bambini e degli adulti ammazzati a Gaza, hanno guardato anche molto altro. E i produttori delle icone false lo sanno bene. La foto della falsa statua di San Casciano citata prima era, non a caso, relativa a un adolescente, non a un vecchio. Con le tue competenze di archeologo, sulla base di quello che pensi e senti, ti poni il problema di come stimolare la responsabilità dello sguardo? Una visione critica del passato come del presente, che provochi la riflessione attiva e non solo l’osservazione.
Al di là delle immagini mi sembra che, se restiamo nel campo dell’archeologia, il discorso sia molto ampio. La cosidetta “rivoluzione stratigrafica” dell’archeologia è stata fondamentale per rinnovare la disciplina però ha anche frammentato moltissimo l’informazione. Questo ha avuto effetti in parte disastrosi, ad esempio nella produzione dei testi archeologici, perché le pubblicazioni e in generale l’informazione archeologica è diventata analitica e catalogica, cioè molto più di dettaglio che in passato. Oggi sembra quasi che il valore di uno studio sia nel suo essere catalogico, per cui ci sono edizioni di scavo con 100 pagine di testo e 400 di tabelle. Tutto questo è ovviamente collegato alle ricostruzioni di cui parlavano prima e quindi con le rappresentazioni del passato che offriamo al pubblico. La frammentazione e il pensiero iper-analitico sono corretti ma generano mostri e non aiutano la comunicazione in archeologia e in generale la riflessione sui problemi. Il punto è come si usano i dati di uno scavo archeologico [si veda: Storia e archeologia: è questa la strada del dialogo? | Reti Medievali Rivista]. Spesso vengono selezionati per costruire la narrazione che si vuole portare, o gonfiati. L’ho presa un po’ alla lontana, ma quella frammentazione equivale a una mole enorme di documentazione (ogni coccio una scheda, ecc.) e questa impostazione analitica ha creato molti archeografi e pochi archeologi. Molti si limitano a dire che in uno scavo hanno trovato questo o quello, ma poi? Noi archeologi siamo storici, se non ricostruiamo la storia con uno sguardo critico e riflessivo, a cosa serviamo?
Non credi che questo abbia anche un po’ isolato la disciplina, rendendola poco accessibile dai colleghi delle altre discipline? Lo storico dell’arte, Ernst H. Gombrich, nella prefazione a una raccolta di saggi di inizio anni Sessanta (A cavallo di un manico di scopa. Saggi di teoria dell’arte, Einaudi 1971) si poneva il problema di come infrangere l’isolamento della storia dell’arte e realizzare un “ideale di cooperazione intellettuale”, in modo che gli altri potessero ricavare dalla storia dell’arte qualcosa di utile alla propria disciplina. Traslando il discorso all’archeologia, gli altri (antropologi, storici, …) prendono cose da questa disciplina?
Molto poco, anche perché tra gli archeologi ci sono poche personalità che possono fare da ponte. Da qualche anno sono coordinatore di un dottorato che si chiama “Scienze storiche e archeologiche”, quindi per me l’interazione con gli storici e far capire loro il peso potenziale dell’archeologia sono passaggi fondamentali. Ma dall’altra parte non c’è tutta questa ricettività. Si contano sulle dita di due mani gli storici che vogliono discutere con noi, rispetto al Medioevo ma anche all’Antichità. Quantomeno in Italia, per la maggior parte degli storici la materialità è una quinta scenografica di fronte alla quale succedono cose più importanti, ovvero le interazioni tra persone tramandate dalla parola scritta. Poi, noi probabilmente non siamo troppo bravi a comunicare con i colleghi di altre discipline, e pochi cercano di farlo.
Forse molti restano nella propria nicchia anche perché interessati principalmente al proprio piccolo esercizio di potere.
Questa è un’altra parola chiave. È molto una questione di potere. Per quanto poco potere si possa gestire con l’archeologia.
 Nel tuo ultimo libro citi i placemakers, cioè quegli archeologi che si sono dedicati per buona parte della vita a un singolo sito: Schliemann a Troia, ad esempio. Ti senti un placemaker con il sito di Ravenna-Classe?
Nel tuo ultimo libro citi i placemakers, cioè quegli archeologi che si sono dedicati per buona parte della vita a un singolo sito: Schliemann a Troia, ad esempio. Ti senti un placemaker con il sito di Ravenna-Classe?
Mi metti in imbarazzo, mi farebbe piacere se qualcuno lo dicesse ma non me la sento di farlo io. Il concetto di placemaking è stato elaborato da Richard Hodges, il quale diceva che Riccardo Francovich era uno di questi placemakers. È vero perché Riccardo è stato capace di far diventare Montarrenti e San Silvestro, due piccoli siti della Toscana, l’epicentro di una revisione drastica sul tema dell’incastellamento. Hodges stesso è stato placemaker a San Vincenzo al Volturno, un sito che ha una dimensione potenzialmente europea, e poi a Butrinto in Albania. Io ci sto provando con Cervia: è un luogo che non ha una forte tradizione archeologica, mentre noi abbiamo trovato la città vecchia e un enorme complesso ecclesiastico che quasi sicuramente è la prima cattedrale.
Vorresti fermarti lì?
Mah, questo non lo so; però di sicuro a Cervia c’è lavoro per due-tre generazioni di archeologi. Non ho mai avuto la spinta a cercare l’archeologia fuori dall’Italia. Ho lavorato per due anni a Samarcanda, in Uzbekistan, insieme a Maurizio Tosi, personaggio moto intelligente ma complesso. Però il fatto di non dominare la lingua antica del posto, e neanche quella moderna, e quindi non poter leggere le fonti scritte in prima persona, per me era un grande handicap. Per questo dopo poco me ne sono andato. Ho lavorato molto a Roma, in Toscana, a Ravenna e oggi a Cervia.
Sei policentrico?
Sì, abbastanza.
E invece non avresti voglia di concentrarti su una persona, più che su un luogo, e scriverne la biografia? Una pratica che, nel mondo dell’archeologia italiana, è stata poco frequentata (con alcune importante eccezioni, come il libro di Marcello Barbanera su Ranuccio Bianchi Bandinelli); come mai, secondo te?
Dedicarmi a una persona sola, non so. Avevo accarezzato un progetto di questo tipo sui viventi, o comunque sui miei maestri. Penso ad Andrea Carandini, Filippo Coarelli, Riccardo Francovich. Chissà, forse Perché non c’è questa tradizione in Italia? Qualcosa si è mosso con la biografia di Domenico Palombi su Rodolfo Lanciani e con quella di Marcello Barbanera su Bandinelli. Ma credo che la risposta stia nel fatto che siamo di nuovo in una zona che sta a cavallo tra una analisi di tipo scientifico, storico-culturale, e la divulgazione. Un libro come il mio ultimo per Carocci nella VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca) nelle istituzioni italiane viene valutato zero, o comunque molto poco, proprio perché è considerato divulgazione. I giovani non sono invogliati ad occuparsene perché non fa fare carriera. Infatti non ci sono corsi di divulgazione archeologica nelle università.
La seconda parte dell’intervista di Valentina Cabiale ad Andrea Augenti sarà pubblicata su Carmilla il giorno 11 febbraio 2026.