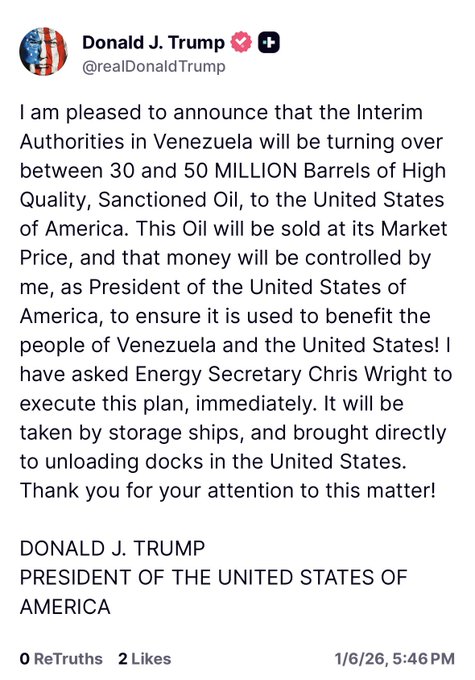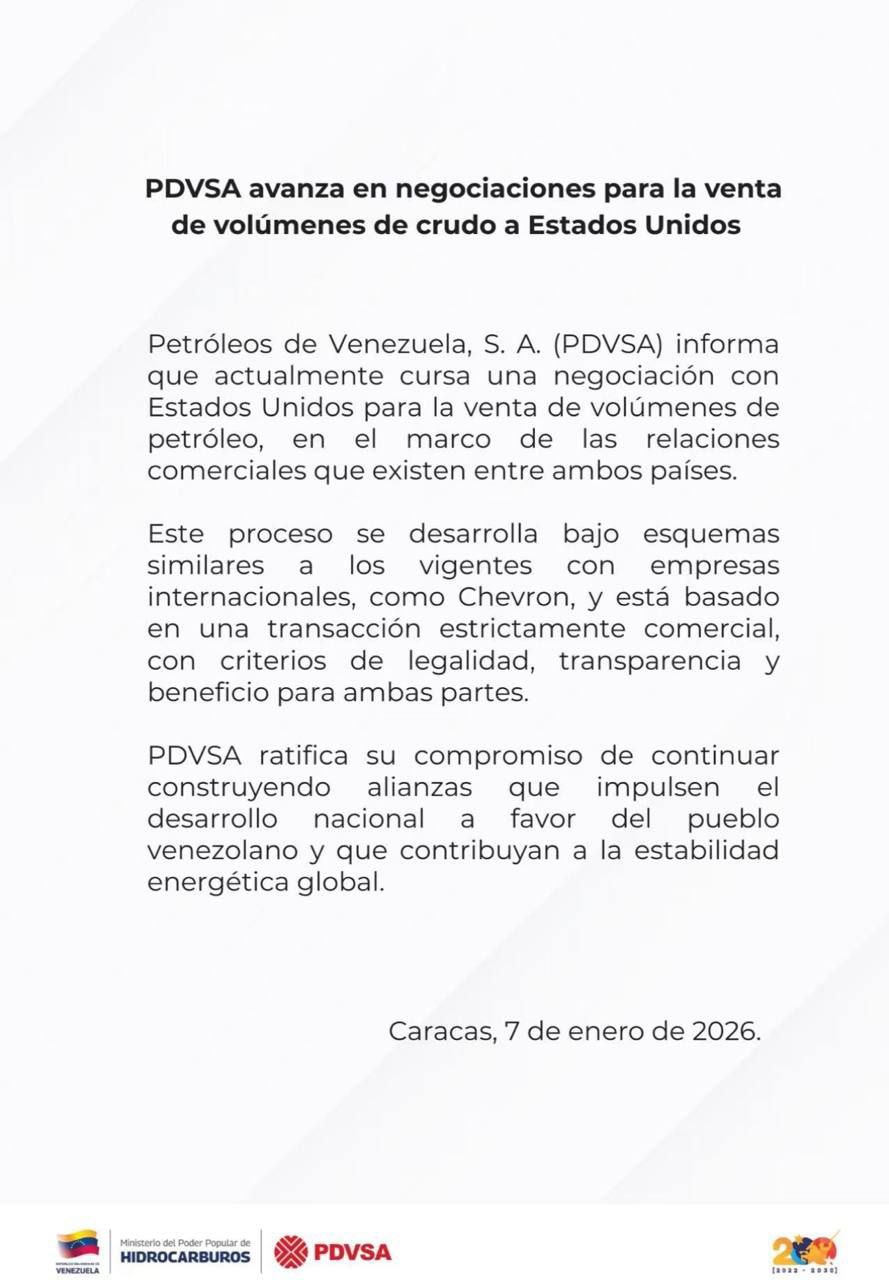Un fischio, poi un altro e un altro ancora: l’ICE è arrivata. Poi arriva la lunga esplosione: fiuuuuuuuu! L’ICE ha preso qualcuno.
Questi sono i codici che i gruppi di pronto intervento a sostegno degli immigrati stanno usando per avvisare i loro vicini e colleghi quando viene avvistata l’ICE e quest’ultima rapisce qualcuno.
Gli agenti federali sono armati in modo militare. Contro di loro, la gente comune ha fischietti, coraggio sconfinato e l’acronimo S.A.L.U.T.E. per le informazioni da raccogliere: le dimensioni (Size) degli schieramenti di agenti federali, le azioni (Actions) che stanno intraprendendo, la posizione (Location) specifica, le uniformi che indossano, il tempo e l’equipaggiamento, o il tipo di armi.
Durante i corsi di formazione organizzati in tutto il Paese, i soccorritori simulano come dimostrare solidarietà agli immigrati e superare la paura per sfidare il terrore. L’attivismo dal basso e l’azione diretta hanno giocato un ruolo fondamentale nella storia popolare degli Stati Uniti, una storia di lotte che hanno portato all’abolizione della schiavitù, assicurato la libertà di organizzazione sindacale e conquistato libertà civili.
La trentasettenne Renee Nicole Good era una paladina della solidarietà e della lotta per la libertà. Come moltissimi altri statunitensi provenienti da ogni ceto sociale, fungeva da occhi e orecchie dei suoi vicini latini e somali, avvisandoli della presenza dell’ICE e di altri agenti federali.
Good, madre di tre figli, faceva parte di un gruppo informale di pronto intervento, ICE Watch, composto dai genitori della scuola paritaria frequentata da suo figlio. “È stata addestrata su come comportarsi con questi agenti dell’ICE: cosa fare, cosa non fare, è un addestramento molto approfondito”, ha detto un genitore al New York Post, un tabloid conservatore che ha cercato di dare un’immagine negativa del suo attivismo. “Ascoltare i segnali, conoscere i propri diritti, fischiare quando si vede un agente dell’ICE”.
L’amministrazione Trump ha descritto Renee Nicole Good come una “terrorista interna”. Ma le persone che conoscevano Good la hanno descritta come una cristiana dichiarata, vedova di un veterano, una donna queer, una cantante e una poeta. “Quello che ho visto nel suo lavoro è stata una scrittrice che stava cercando di illuminare la vita degli altri”, ha detto un’insegnante, descrivendo il suo interesse per la vita degli anziani, dei veterani e di persone provenienti da diversi paesi ed epoche.
Come molti di noi che hanno una vita frenetica ma trovano il tempo per stare accanto agli altri, aveva accompagnato il figlio di sei anni a scuola poco prima che l’ICE la uccidesse. L’analisi delle riprese video da tre angolazioni effettuata dal New York Times mostra che Good sembra allontanare il suo SUV dagli agenti federali mentre l’agente dell’ICE Jonathan Ross cammina davanti al veicolo. Quindi quest’ultimo spara tre colpi a bruciapelo contro il veicolo, uccidendola in pieno giorno non lontano dalla sua abitazione, come si vede nelle riprese.
La sua compagna era sulla scena con lei. “Mercoledì, 7 gennaio, ci siamo fermate per aiutare i nostri vicini. Avevamo dei fischi. Avevano le pistole”, ha detto Rebecca Good in una dichiarazione venerdì. “Abbiamo cresciuto nostro figlio insegnandogli che, indipendentemente dalla propria provenienza o dal proprio aspetto fisico, tutti meritano compassione e gentilezza”.
Lo scorso settembre, il cuoco Silverio Villegas-Gonzalez è stato ucciso a colpi di pistola durante un controllo stradale a Chicago, poco dopo aver accompagnato i suoi due figli all’asilo, mentre presumibilmente tentava di fuggire. Il bracciante agricolo Jaime Alanís García si è rotto il collo a luglio, quando è caduto dal tetto di una serra nella contea di Ventura, in California, mentre tentava di sfuggire alla caccia degli agenti dell’ICE, ed è morto dopo il ricovero in ospedale. Trentadue persone sono morte mentre erano sotto la custodia dell’ICE nel 2025 – l’anno più letale per l’agenzia, ormai trasformata in una forza paramilitare, dalla sua fondazione nel 2003.
A differenza di Villegas-Gonzalez e Garcia, entrambi lavoratori immigrati provenienti dall’America Latina, Good era una cittadina statunitense bianca. Non avrebbe dovuto essere nella lista delle persone che l’ICE ha brutalizzato impunemente a causa della loro origine o del loro status di immigrati. Ma lei si è rifiutata di rimanere a guardare l’ingiustizia e ha protetto i suoi vicini. Non era tenuta a schierarsi, ma lo ha fatto. In realtà, alcuni membri della sua famiglia avrebbero preferito che non lo facesse.
Spesso diciamo che la solidarietà è una pratica molto importante, e Good ha agito, esercitando i diritti che tutti noi abbiamo, indipendentemente dallo status di immigrati, di documentare l’attività violenta della polizia e di esprimere la propria opinione.
Un attivista sindacale ha collegato la sua azione solidale alle lotte operaie. “Nel nostro sindacato abbiamo la tradizione di indossare abiti rossi ogni giovedì per onorare un membro molto speciale della CWA (Communications Workers of America), Gerry Horgan, ucciso mentre esercitava il suo diritto fondamentale di scioperare e partecipare a un picchetto. Proprio come Gerry, Renee Nicole Good è stata uccisa mentre esercitava il suo diritto di esprimersi e di essere solidale con la sua comunità, diritto che dovrebbe essere protetto dalla Costituzione”.
Noi siamo ciò che facciamo. Se la scelta che dobbiamo affrontare è tra Good e ICE, la popolazione di Minneapolis sceglie Good. Si stima che circa 10.000 persone abbiano partecipato a una veglia a lume di candela il 7 gennaio per onorare la sua vita.
La violenza scatenata dall’amministrazione Trump sul suolo statunitense non riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi dichiarati.
Nessun personaggio nell’amministrazione USA ha mai avuto tanto potere come Stephen Miller, il consigliere per la sicurezza interna di Trump. Esercita una straordinaria autorità su una fascia insolitamente ampia delle branche di governo, dall’immigrazione alla giustizia penale fino anche alle operazioni militari sul suolo americano. Gran parte di ciò che caratterizza l’era Trump – rapimenti mascherati per le strade degli Stati Uniti, scontri tra gli scagnozzi dell’ICE e i manifestanti, pattuglie militari per le strade degli Stati Uniti – è stato creato da Miller.
Eppure, ora che siamo a un anno dall’inizio del secondo mandato del presidente Trump, è chiaro che, sotto molti aspetti importanti, Miller non sta riuscendo a realizzare i suoi piani autoritari più elaborati. Le espulsioni sono molto indietro rispetto alle sue aspettative. Non è riuscito a convincere Trump a esercitare il potere dittatoriale che tanto desidera vedere. E ha scatenato un movimento culturale in difesa degli immigrati che è più potente di quanto avesse previsto.
Il sogno di Miller di 3.000 arresti giornalieri rimane questo: un sogno. Miller spera di deportare un milione di persone all’anno, ma con il tasso attuale non si avvicinerà a questo. Mentre l’amministrazione sta ancora aumentando il personale dell’ICE, e le deportazioni potrebbero aumentare, molti esperti si aspettano che Miller resti molto al di sotto dell’obiettivo di un milione di deportazioni all’anno nel corso dell’intero mandato di Donald Trump.
Ma l’obiettivo del governo USA va oltre il numero delle deportazioni.
Molti settori produttivi sarebbero nei guai se il governo andasse davvero avanti con le sue deportazioni di massa annunciate. La caccia ai migranti e il modo brutale e arbitrario in cui viene effettuata (gli arresti dei migranti sono fatti davanti alle telecamere come per pubblicizzare la loro pericolosità) sembra progettata per diffondere la paura e per dividere la classe operaia. La paura (dei migranti, del crimine, della violenza, delle minoranze, dei poveri, del decadimento morale e altro) è costantemente alimentata e giustapposta all’immagine rassicurante del potente leader fiducioso e della sua squadra di guerrieri senza paura. L’amministrazione Trump diffonde paura ovunque. Nella popolazione in genere per creare la paura dell’estraneo infiltrato all’interno della comunità nazionale, che farà la fine del capro espiatorio, e perseguitando questo capro espiatorio la maggioranza della popolazione viene compattata dalla paura su un terreno comune. Così si forma una falsa comunità e si evita il pericolo di una classe operaia unificata.
L’esperienza del nazismo in Germania ci mostra quanto sia importante il processo di esclusione di un capro espiatorio interno nel forgiare la volksgemeinschaft, la comunità del popolo. Quella che sta combattendo l’amministrazione Trump è una una battaglia ideologica per creare una comunità nazionale, una “volksgemeinschaft” che è disposta a combattere e morire per il capitale. Si tratta di un attacco alle spinte verso l’unità e l’autonomia della classe operaia, un elemento fondamentale della preparazione alla guerra, che non è solo preparazione militare, ma soprattutto attacco alle forze antimilitariste e internazionaliste.
Di fronte all’arroganza dell’amministrazione e alla marcia verso la guerra, è incoraggiante vedere quanto rapidamente siano apparse reazioni spontanee e intense contro i raid dell’ICE a Los Angeles, New York e Chicago. Anche l’organizzazione di quartiere (allertando una rete di attivisti solidali quando agenti dell’ICE entrano in un’area) si è diffusa nelle città. Lo stesso assassinio di Renee Good è frutto della reazione governativa a questa mobilitazione dal basso, mentre le reazioni che ha provocato in tante città americane testimonia la profondità del movimento.
Il governo Trump usa qualsiasi pretesto per espandere i suoi mezzi repressivi e per abituare la popolazione alla presenza dei militari nelle strade. Anche questa è la preparazione alla guerra. Trump ha detto che le grandi città sarebbero un buon campo di addestramento per i militari. È convinto che una terribile repressione entusiasmerà il suo esercito MAGA e intimidirà i suoi avversari. È la costruzione della nazione per salvare la civiltà occidentale. Nel frattempo quella civiltà produce la bolla dell’IA, la bolla delle criptovalute, il banking ombra e molti altri fenomeni che portano all’abisso. Trump potrebbe essere l’Hoover, il presidente repubblicano della crisi del 1929, dei nostri giorni. Ma è stato il successore “progressista” di Hoover, il democratico Franklin Delano Roosevelt che si è rivelato il più grande ostacolo alla crescita della coscienza di classe autonoma del proletariato.
Avis Everhard
L'articolo Corsa verso l’abisso. L’uccisione di Renee Good: il volto del trumpismo proviene da .