Le prime immagini dei soccorsi ai due treni deragliati in Andalusia


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


La missione asiatica di Giorgia Meloni in Oman, Giappone e Corea del Sud si inserisce in una traiettoria strategica chiara. L’Italia sceglie di collocarsi in modo stabile nel nuovo baricentro globale dell’Indo-Pacifico, rafforzando la propria proiezione internazionale in sintonia con Washington e con i partner del G7. In questo percorso, la tappa coreana assume un ruolo centrale perché condensa alcune delle principali dinamiche del sistema internazionale contemporaneo. Il rapporto con la Cina, il de-risking tecnologico europeo e la riorganizzazione della sicurezza in Asia nord-orientale trovano qui un punto di convergenza strategica.
A Tokyo, nel corso della sua terza visita in Giappone da quando è alla guida del governo, la Presidente Meloni incontra per la prima volta in un vertice bilaterale la premier giapponese Sanae Takaichi, diventando il primo leader europeo a visitare il Paese dopo il suo insediamento. La visita si colloca nel contesto del centosessantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche, un passaggio simbolico scelto per elevare il rapporto bilaterale a partenariato strategico speciale e per dare impulso al Piano d’Azione Italia-Giappone 2024-2027, definito in occasione del G7 di Hiroshima.
Il linguaggio adottato dai due governi riflette una visione condivisa. Al centro vi sono l’idea di un Indo-Pacifico libero e aperto, il rispetto dello stato di diritto, la sicurezza delle catene di approvvigionamento e una crescente interoperabilità in ambito difensivo. In questo quadro, Italia e Giappone sviluppa una convergenza anche su Africa e Mediterraneo allargato. Tokyo riconosce in Roma un ponte verso l’Europa e il Nord Africa, mentre Roma individua nel Giappone un partner capace di rafforzare le proprie capacità industriali e tecnologiche in settori chiave come spazio, cyber e difesa.
A Seoul il contesto assume caratteristiche differenti. Per Meloni questa è la prima visita a Seoul, mentre per il presidente Lee Jae-myung rappresenta una delle prime visite ufficiali di un leader straniero dall’avvio del ritorno della presidenza alla Blue House, una scelta simbolica volta a marcare una discontinuità politica rispetto al predecessore Yoon Suk-yeol. Lee esprime una leadership progressista, caratterizzata da una diplomazia pragmatica e orientata all’equilibrio. Il recente dialogo di Seul con Pechino segnala una volontà di riaffermare un ruolo centrale della presidenza nella definizione della politica estera e di gestire con maggiore flessibilità le dinamiche regionali, con la consapevlozze di cercare spazi di maggiore autonomia.
Sul piano strategico, la Corea del Sud valorizza un equilibrio calibrato. L’alleanza militare con gli Stati Uniti resta un pilastro, anche nel quadro della deterrenza verso Pyongyang, mentre il mantenimento di un canale politico con la Cina contribuisce alla stabilità regionale, e completa a livello diplomatico la gestione del dossier nordcoreano.
L’attenzione di Seul verso la Cina si inserisce in una strategia volta a favorire la stabilità nella penisola coreana e a mantenere margini negoziali ampi. Con una Corea del Sud più cauta rispetto agli orientamenti normativi del Free and Open Indo-Pacific (FOIP), l’Italia considera il fattore cinese come una variabile da gestire con pragmatismo. In questo contesto, il lessico adottato privilegia il riferimento alla cooperazione regionale e a un approccio graduale, capace di tenere insieme sicurezza e stabilità economica.
La cooperazione economica tra Italia e Corea del Sud poggia su basi solide. Nel 2024 l’interscambio ha raggiunto circa 11,4 miliardi di euro, all’interno del quadro regolatorio dell’Accordo di Libero Scambio UE-Corea in vigore dal 2011. Seul rappresenta oggi il primo partner asiatico dell’Italia in termini pro capite, con catene del valore particolarmente integrate nei settori dell’automotive, della meccanica di precisione, della chimica fine, della moda e dell’agroalimentare di alta gamma.
La visita è accompagnata dalla definizione di una dichiarazione congiunta su commercio, investimenti e partenariati industriali, affiancata da intese operative su protezione civile e tutela del patrimonio culturale. Questi ambiti rafforzano la dimensione bilaterale e contribuiscono a proiettare l’immagine dell’Italia come partner tecnologicamente affidabile e culturalmente attrattivo, capace di coniugare competenze industriali e soft power.
Semiconduttori e de-risking, perché Seul conta
Tuttavia, il baricentro politico del vertice riguarda principalmente la cooperazione tecnologica avanzata, in particolare nel settore dei semiconduttori. L’Italia guarda con interesse alla Corea del Sud come attore di primo piano nella produzione di chip di memoria e negli impianti di nuova generazione. In un contesto europeo orientato al de-risking, Roma individua in Seoul un partner affidabile per diversificare fornitori e rafforzare la resilienza delle filiere industriali strategiche.
Questa cooperazione si inserisce in modo coerente nel perimetro euro-atlantico e risulta compatibile con le dinamiche della Chip 4 Alliance, che riunisce Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e Taiwan. Per Seoul, un rafforzamento strutturato dei rapporti con l’Italia favorisce l’accesso ai mercati europei e accresce il peso politico a Bruxelles. Per Roma, la partnership contribuisce a consolidare la competitività industriale e la sicurezza tecnologica in settori strategici.
Accanto alla dimensione tecnologica civile, la cooperazione in ambito difesa si afferma come un vettore strutturale di convergenza tra Italia e Asia orientale. L’esperienza maturata dall’Italia nel Global Combat Air Programme (GCAP), sviluppato insieme a Giappone e Regno Unito, ha rafforzato in modo significativo il posizionamento nazionale nel segmento più avanzato dell’industria aerospaziale e militare. Il GCAP è un programma congiunto per lo sviluppo di un sistema di combattimento aereo di nuova generazione, centrato su una piattaforma di sesta generazione integrata con droni, sensori avanzati, intelligenza artificiale, capacità di comando e controllo multi-dominio e architetture digitali aperte. Si tratta di un ecosistema tecnologico che connette difesa, spazio, cyber e manifattura avanzata.
La partecipazione italiana al GCAP ha accresciuto la credibilità del Paese come partner tecnologico di lungo periodo. Questo posizionamento ha suscitato un interesse crescente anche in Asia, dove il modello di cooperazione trilaterale viene osservato come riferimento per nuove forme di partenariato industriale e tecnologico.
In questo contesto si inserisce il dialogo con la Corea del Sud, che dispone di un’industria della difesa dinamica e fortemente orientata all’export, con competenze consolidate nei settori aerospaziale, navale e dei sistemi avanzati. Con Seul si esplorano possibili collaborazioni industriali in ambito aerospaziale e navale, con particolare attenzione ai sistemi anti-drone, ai sensori di nuova generazione, alle piattaforme a duplice uso e all’integrazione tra componenti hardware e software ad alta intensità digitale. La complementarità tra le capacità italiane nei sistemi, nell’elettronica avanzata e nella cantieristica navale, le tecnologie europee in ambito missilistico e di comando e controllo, e le competenze coreane nella produzione, nell’automazione e nella scalabilità industriale apre spazi concreti per iniziative congiunte.
Questa sinergia offre prospettive operative non limitate al perimetro bilaterale. La possibilità di sviluppare soluzioni integrate e competitive consente di guardare a mercati terzi in modo strutturato, valorizzando una presenza industriale congiunta.
Tutto mentre “Mediterraneo globale”, per usare un’espressione di Meloni, Africa e Indo-Pacifico emergono come aree coerenti con la proiezione marittima e industriale di lungo periodo dell’Italia, dove la domanda di sicurezza, sorveglianza, protezione delle infrastrutture critiche e controllo degli spazi marittimi è in costante crescita.
Pertanto, la cooperazione in ambito difesa assume una valenza che va oltre la dimensione industriale. Essa contribuisce a rafforzare l’autonomia strategica dell’Italia all’interno del quadro euro-atlantico, consolida relazioni di fiducia con partner tecnologicamente avanzati e proietta il sistema industriale nazionale in una rete indo-pacifica sempre più centrale negli equilibri globali di sicurezza.
La relazione italo-coreana si fonda quindi su interessi convergenti e risultati tangibili. Commercio, investimenti, tecnologie critiche, difesa e resilienza delle catene di approvvigionamento costituiscono un terreno comune solido.
Proprio questa dimensione pragmatica rafforza la credibilità della partnership. Per l’Italia rappresenta uno strumento efficace di ancoraggio all’Indo-Pacifico e di rafforzamento dell’autonomia strategica all’interno del quadro euro-atlantico. Per la Corea del Sud costituisce una leva per ampliare la propria presenza in Europa, diversificare le relazioni economiche e accrescere il peso nei grandi dossier globali di sicurezza economica e tecnologica.
© RaiNews
Mentre la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, arrivava a Mascate per una visita ufficiale, la capitale omanita accoglieva con una cerimonia solenne anche l’INSV Kaundinya, al termine di uno storico viaggio di 18 giorni dal Gujarat all’Oman. Due arrivi paralleli, due traiettorie diverse — una politica, l’altra marittima — che si sono incrociate nello stesso luogo e nello stesso momento, proiettando sull’Oceano Indiano una narrazione che unisce passato e futuro, memoria e strategia.
L’India guarda all’Indo-Mediterraneo e a rotte come il Corridoio Economico India–Medio Oriente–Europa non soltanto attraverso infrastrutture moderne e corsie di navigazione contemporanee. Esiste anche una dimensione culturale e simbolica che affonda le radici nella storia antica e contribuisce a dare profondità strategica alle scelte del presente. L’INSV Kaundinya si colloca esattamente in questo spazio: non una semplice unità navale, ma una ricostruzione vivente della tradizione marinara indiana.
Ispirata alle navi a fasciame cucito raffigurate nei murali del V secolo delle grotte di Ajanta, l’imbarcazione è stata concepita come un ponte tra l’India contemporanea e il suo passato oceanico, ben precedente all’era dei motori e degli scafi in acciaio. A promuovere il progetto è stato Sanjeev Sanyal, economista e storico, oggi membro del Consiglio Economico Consultivo del Primo Ministro, con l’obiettivo dichiarato di restituire visibilità a una civiltà marittima spesso sottovalutata nella narrazione globale.
A differenza delle navi moderne, l’INSV Kaundinya è stata costruita senza l’impiego di chiodi o componenti metallici. Le tavole di legno sono state cucite a mano con corde di fibra naturale di cocco e sigillate con resine organiche, seguendo tecniche tradizionali tramandate nei secoli e ancora vive in alcune aree costiere dell’India, in particolare nel Kerala. Un sapere artigianale antico, integrato con competenze ingegneristiche moderne, che restituisce un’idea di continuità più che di nostalgia.
Il progetto è nato da una collaborazione tripartita tra il Ministero della Cultura indiano, la Marina e il cantiere navale di Goa Hodi Innovations (OPC) Pvt Ltd. La posa della chiglia nel settembre 2023 ha dato avvio a quasi due anni di lavoro, resi ancora più complessi dall’assenza di progetti tecnici originali. Il team ha dovuto affidarsi a fonti iconografiche, testi storici e test idrodinamici condotti presso l’IIT di Madras per garantire la navigabilità oceanica dell’imbarcazione.
Dopo il varo nel febbraio 2025, la nave è stata ufficialmente incorporata nella Marina indiana il 21 maggio 2025 presso la base di Karwar, nel Karnataka. Il nome Kaundinya richiama l’antico navigatore che, secondo la tradizione, avrebbe raggiunto il Sud-Est asiatico creando legami culturali duraturi: un riferimento che rafforza il messaggio di lungo periodo insito nell’intera iniziativa.
Il primo viaggio internazionale ha preso il via il 29 dicembre 2025 da Porbandar, in Gujarat, con destinazione Mascate. Una rotta che ricalca gli antichi itinerari commerciali tra il subcontinente indiano e la Penisola Arabica, molto prima che la navigazione coloniale ridefinisse i flussi globali. Porbandar è anche la città natale di Mohandas Karamchand Gandhi, ulteriore elemento simbolico in un percorso che intreccia storia, identità e diplomazia.
Durante la traversata del Mar Arabico, Sanyal ha condiviso aggiornamenti regolari sui social, raccontando i ritmi lenti della navigazione a vela, l’influenza dei venti e le sfide quotidiane di una traversata che riecheggia le esperienze dei marinai di oltre duemila anni fa. In uno dei passaggi più evocativi, ha descritto l’avvistamento lontano di una moderna portaerei: un contrasto che rende visibile, nello stesso orizzonte, la stratificazione del potere marittimo nel tempo.
L’approdo a Mascate, inaugurato ufficialmente alla presenza delle autorità locali e diplomatiche, ha assunto così un valore che va oltre la celebrazione storica. L’Oman è da secoli un nodo centrale delle reti dell’Oceano Indiano e oggi si conferma spazio di incontro tra diplomazia, commercio e sicurezza marittima. In questo contesto, la concomitante visita di Giorgia Meloni ha aggiunto una dimensione ulteriore.
Se la Kaundinya rappresenta la storia millenaria dell’India come civiltà marittima, Meloni incarna il futuro dell’Italia: prima donna a guidare il Paese come Presidente del Consiglio, ha riportato Roma a rivendicare un ruolo più assertivo in Europa e nel Mediterraneo allargato, con uno sguardo crescente verso l’Indo-Pacifico. In Oman, India e Italia si sono ritrovate simbolicamente riunite come due pilastri complementari dell’Indo-Mediterraneo, uno spazio che non è più soltanto geografico, ma strategico.
Questa convergenza non è frutto di una coreografia studiata, ma di una serendipità significativa. In un momento di forte instabilità globale, il viaggio della Kaundinya ricorda che i mari — un tempo ponti di scambio e connessione — continuano a modellare le relazioni internazionali. Tra memoria storica e proiezione strategica, l’Indo-Mediterraneo torna così a raccontare una storia antica, ma sorprendentemente attuale.
(Foto: X, @sanjeevsanal)


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews
Come nel resto del mondo anche l’Italia è stata colta di sorpresa dall’invasione russa del febbraio 2022, ma rispetto ad altri paesi ha seguito un percorso più lungo per elaborare una strategia sull’Ucraina, anche perché sei mesi dopo lo scoppio del conflitto, ci sono state le elezioni politiche con il passaggio di governo da Mario Draghi a Giorgia Meloni.
La definizione di una strategia nazionale italiana per l’Ucraina è stata complessa anche per ragioni storiche. Francia e Germania erano state coinvolte direttamente fin dal 2014 nei negoziati di pace tra Russia e Ucraina, a seguito dell’occupazione militare russa della Crimea e del Donbas,attraverso il “Normandy Format”, cioè un tavolo a 4 con i due contendenti. Questo significa che sia a Parigi che a Berlino(come naturalmente a Washington) c’era già un “dossier Ucraina” sul tavolo con risorse diplomatiche dedicate. Altri paesi come il Regno Unito, i Paesi scandinavi e quelli Baltici hanno adottato subito una posizione di sostegno aperto all’Ucraina, perché storicamente più sensibili e preoccupatidall’aggressività militare russa fin dalla nascita dell’Unione Sovietica.
A differenza di oggi, l’Ucraina non era una priorità per la politica estera italiana. Kiev è sempre stata per i diplomatici italiani una destinazione meno prestigiosa e con meno risorse rispetto a Mosca, che era molto importante anche per l’export delle aziende italiane. Questo ha creato un dissidio interioremolto rilevante per la politica estera italiana, perché la scelta di sostenere attivamente l’indipendenza dell’Ucraina ha comportato il deterioramento della lunga relazione amichevole con la Russia.
Come spesso succede, ci sono dei fattori esterni che fungono da catalizzatori del cambiamento. E questi furono uno stranoinciampo diplomatico a Lugano e un attacco drammatico aOdessa.
Agli inizi di luglio 2022, pochi giorni prima delle dimissioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi, si tenne la conferenza di Lugano per la ricostruzione dell’Ucraina, con l’illusione che la guerra sarebbe finita presto. A questo incontro il Primo Ministro ucraino Denis Shmigal presentò al pubblico di esperti internazionali una grande mappa con le regioni e le grandi città dell’Ucraina contrassegnate da bandierine dei paesi che avrebbero dovuto prendersi la responsabilità dei progetti nei vari territori. Praticamente, era una proposta di lottizzazione della ricostruzione in base agli interessi nazionali.
La cosa che lasciò gli addetti ai lavori italiani a bocca aperta fu l’assegnazione all’Italia di Rivne, una piccola città vicino al confine con la Bielorussia, e di Donetsk, nel Donbas. Se non era chiaro quale potesse essere l’interesse dell’Italia per Rivne, per Donetsk si trattava di un’ipotesi del tutto irreale, data l’occupazione russa dal 2014. Sulle città più importanticome Kiev, Odessa, Dnipro, Leopoli, Zaporizhzja e Karkhiv, sventolavano altre bandiere nazionali. Curiosamente, su Odessa, città nota per il legame con l’Italia, c’erano labandierina svizzera e quella francese.
Questa concessione all’Italia delle ultime caselle vuote e, in particolare, di una città non disponibile, era il segno di una scarsa considerazione del ruolo economico e diplomatico dell’Italia, e della priorità data agli altri Paesi (USA, UK, Germania, Francia, Svizzera, Canada, Polonia e Turchia). La poco esperta diplomazia ucraina aveva elaborato uno strumento di indirizzo non privo di stimoli intellettuali, ma senza un vero approfondimento preliminare con tutti i paesicoinvolti.
Ma la mancata attribuzione di Odessa all’Italia, era piuttostoimbarazzante, se si tiene conto non solo del legame storico-culturale, ma anche delle eccellenze italiane in settori come la cantieristica, la logistica marittima e le infrastrutture portuali, che non erano state considerate dal piano ucraino.
Per sanare questo schiaffo diplomatico si mosse l’ambasciatore a Kiev Pierfrancesco Zazo, che si era guadagnato l’ammirazione degli ucraini per essere stato l’ultimo capo diplomatico europeo ad abbandonare una Kiev semicircondata dai Russi. Inoltre, nell’aprile 2022, fu uno dei primi a riaprire un’ambasciata nella capitale ucraina. Fu lui a sensibilizzare il Governo ucraino sulle grandi opportunità che offriva una partnership italo-ucraina con perno sulla città di Odessa. Nel 2023, a sottolineare questo legame tra il porto del Mar Nero e l’Italia, fu inaugurata la sede del nuovo Console onorario italiano. Era dalla Seconda Guerra Mondiale che mancava un consolato dell’Italia a Odessa.
Il secondo fatto catalizzatore avvenne il 23 luglio del 2023: l’attacco missilistico notturno alla Cattedrale ortodossa della Trasfigurazione di Odessa, che distrusse il tetto e gli internidell’edificio. A poche ore dall’evento che traumatizzò tutta la città, sia il Presidente del Consiglio Meloni che il Ministro degli Esteri Tajani dichiararono che l’Italia si sarebbe occupata del restauro della chiesa. Curiosamente proprio quel giorno era in visita a Odessa una delegazione di Deputati italiani della Commissione Esteri della Camera, che furonotestimoni oculari delle macerie fumanti dopo l’attacco.
Da quella decisione del Governo italiano, nata da un moto di solidarietà, è partito un percorso che ha portato alla definizione di una strategia più strutturata sull’Ucraina. Nel settembre del 2023 ci fu a Odessa la prima visita dell’inviato speciale per l’Ucraina Davide La Cecilia, già ambasciatore a Kiev fino al 2020, insieme alla responsabile dell’UNESCO a Kiev Chiara Dezzi Bardeschi, e due esponenti della cultura italiana: il presidente del Museo MAXXI di Roma Alessandro Giuli (oggi Ministro italiano della Cultura) e il presidente del Museo La Triennale di Milano arch. Stefano Boeri.
Dal quel primo incontro partì il processo di definizione del piano che approdò l’11 giugno 2024 a Berlino alla firma del Memorandum sul “Patronage italiano per la ricostruzione di Odessa e della sua regione” tra il Ministro degli esteri Antonio Tajani e il Ministro ucraino per lo Sviluppo delle Infrastrutture Vasyl Shkurakov, alla presenza del sindaco diOdessa, Gennadiy Trukhanov. Qualche mese prima di quella firma era stato aperto l’ufficio a Kiev dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo (AICS), per coordinare gli aiuti umanitari in Ucraina e controllarne l’efficacia.
Il MoU delineava la nuova strategia italiana in Ucraina, che oltre agli aiuti militari, comprendeva un programma articolato di progetti umanitari, culturali e di sviluppo economicofocalizzati su Odessa e la sua regione. La finalità complessiva di questo piano era la creazione di un ecosistema favorevole agli investimenti italiani e alle partnership industriali per la ricostruzione nel dopoguerra.
Parallelamente a questo sviluppo della politica estera italiana, cresceva la relazione Italia-Ucraina, come testimoniato dalle crescenti visite a Roma di Zelensky per incontrare Giorgia Meloni, Sergio Mattarella e i due Papi Francesco e Leone XIV. Inoltre, se l’ex Ministro degli Esteri ucraino Kuleba aveva vissuto per anni in Italia, tuttora nell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina alcuni responsabili sono stati nell’ambasciata a Roma e sono esperti nelle relazioni diplomatiche con l’Italia.
L’Italia è divenuta per l’Ucraina un paese di riferimento stabile, in confronto alle continue crisi di governo in Francia, Germania e Regno Unito. Inoltre, le relazioni molto amichevoli tra il governo Meloni e la nuova amministrazione Trump offre all’Italia un ruolo di moderatore nelle difficili relazioni ucraino-americane. Inoltre, è importante notare che gli ambasciatori dei Paesi del G7 a Kiev svolgono un ruolo rilevante nel processo di riforme per modernizzare e stabilizzare l’Ucraina. Infatti hanno incontri regolari con i ministri ucraini e monitorano i provvedimenti legislativi con il diritto di parola. Un caso unico al mondo di influenza del G7, e quindi anche dell’Italia, in una crisi internazionale.
Dopo il mandato di Pierfrancesco Zazo, a luglio 2024 l’Italia ha nominato nel luglio 2024 a Kiev l’ambasciatore Carlo Formosa, un diplomatico con esperienza di servizio in paesi difficili come l’Iran e l’Afghanistan, e in passatovicepresidente del gruppo Leonardo, il cluster italiano della difesa. Una competenza utile per la partnership militare italiana con l’Ucraina.
La scelta di Odessa è stata ispirata da un riferimento storico-culturale. La città fu fondata nel 1794 dal comandante napoletano Josè de Ribas al servizio di Caterina La Grande, e gli immigrati italiani del Regno delle Due Sicilie furono la prima classe dirigente della città. Le maggiori realizzazioni architettoniche della città portano la firma di architetti italiani.
Ma la scelta della capitale marittima dell’Ucraina è spinta anche dagli interessi nazionali italiani. L’importanza di Odessa, obiettivo prioritario della strategia militare russa, è data da molte ragioni:
Economia. I 7 porti della regione di Odessa sono il cancello del 90% dell’export ucraino. Chi controlla Odessa ha il controllo dell’economia ucraina. L’Italia è un importatore di materiali ferrosi e candidata a diventare la prima porta d’ingresso per l’export dell’acciaio “verde” ucraino. Inoltre ci sono diversi settori italiani che dipendono dalle importazioni di derrate alimentari ucraine. Durante il blocco navale russo dei porti ucraini nel 2022, il settore dell’allevamento (zootecnia) fu colpito duramente dalla mancanza di mais ucraino usato nell’alimentazione degli animali, come l’arresto delle importazioni di grano dall’Ucraina penalizzò i produttoridi pasta italiana.
Cultura. Odessa è la città ucraina più famosa al mondo grazie al cinema, alla letteratura, alla musica e all’arte contemporanea. La parola “Odessa” è un potente brand usato nel design e nel marketing industriale. Tra tutte le città ucraine Odessa è un palcoscenico di grande visibilità internazionale.
Politica. Dalla sua fondazione Odessa è la città della tolleranza culturale e linguistica. Rappresenta il modello multiculturale di sviluppo dell’Ucraina, contrapposto al modello nazionalistico mono-linguistico. Il luogo ideale del dialogo per la ricostruzione non solo fisica, ma anche morale del Paese.
Sicurezza. La proiezione militare ucraina sul mare per proteggere il traffico maritimo ha reso Odessa il guardiano del Mar Nero, obliterando il ruolo Sebastopoli, che è stata abbandonata dalla flotta russa. La città è oggi il laboratorio più avanzato al mondo di nuove tecnologie militari navali.
Carriera marittima e arte militare: grazie a Odessa l’Ucraina impara a navigare e a combattere. Le sue accademie navali formano la più alta percentuale al mondo di ufficiali di marina mercantile di etnia europea. Inoltre, alla scuola militare di Odessa si sono diplomati in generali Zaluzhny e Budanov.
“L’Italia ha scelto di occuparsi di alcuni dei simboli dei luoghi che compongono il mosaico identitario della Nazione ucraina: quel luogo è Odessa”. Così disse Giorgia Meloni all’apertura della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina. Per l’Italia la diplomazia culturale e della cooperazione non profit svolge un ruolo importante per aprire la strada alle imprese nazionali. In effetti, alcuni campioni industriali nazionali presero parte al gioco.
Durante la URC2025 a Roma la Fincantieri, il più grande gruppo europeo di cantieristica navale, annunciò un progetto pilota per la difesa del porto di Odessa con tecnologie innovative, sia di superficie che subacquee. Un progetto in linea con l’importanza della città nella sicurezza del Mar Neroe con le ambizioni industriali navali dell’Italia. È utile menzionare che proprio nel gennaio del 2025, Fincantieri aveva acquisito dal gruppo Leonardo la società UAS Underwater Business per la protezione di infrastrutture portuali da sottomarini, droni navali e siluri.
Il più grande costruttore italiano Webuild, firmò tre accordi: 1) 2 miliardi con Automagistral, azienda di Odessa specializzata nella costruzione di strade; 2) 600 milioni con l’azienda Ukrhydroenergo per produzione di energia; 3)cooperazione con l’Agenzia ucraina per la ricostruzione e le infrastrutture.
Ma l’Italia arriva in una piazza già in parte occupata da altri investimenti esteri, che si concentrano in prossimità dei suoi maggiori porti (Odessa, Chornomorsk e Yuzhny). Ecco i paesi protagonisti:
Germania. Il più grande investimento infrastrutturale tedescoin Ucraina è il CTO-Container Terminal Odessa, del gruppo HHLA, il principale operatore portuale tedesco, la cui azionista di maggioranza è il Comune di Amburgo. HHLA ha anche un terminal nei porti di Tallinn e Trieste.
Dubai. Il campione della logistica portuale degli Emirati Arabi Uniti (Dubai) DP World controlla TIS Group, il maggiore operatore privato del primo porto dell’Ucraina, Yuzhny (a nord di Odessa).
Usa. Il maggiore investimento logistico statunitense (150 milioni di dollari) è il Neptune Grain Terminal del gruppoCargill di Minneapolis, completato nel 2018 dentro il porto di Yuzhny.
Cina. Uno dei primi partner commerciali dell’Ucraina. Primoimportatore di mais e orzo ucraino (20% dell’esportazione totale nel 2021) e il secondo di olio di girasole (15%), dopo l’India (30%). È anche il principale esportatore in Ucraina di prodotti di largo consumo (USD 8,25 miliardi nel 2020).
Svizzera. La Confederazione elvetica vanta in Odessa la presenza di due grandi aziende: Risoil S.A., holding agroindustriale e principale operatore del porto di Chornomorsk; e la Mediterranean Shipping Company (MSCS.A.), la più grande compagnia di shipping al mondo. Le due società hanno sede legale a Ginevra (anche se in entrambe i capitali non sono svizzeri).
Italia: il maggiore investimento italiano diretto è l’azienda di comunicazione unificata Wildix, anche se la sopra menzionata MSC appartiene alla famiglia napoletana Aponte.
Singapore. Il principale investimento diretto della città-stato asiatica è Delta Wilmar Group, una società ucraina parte della multinazionale agroindustriale Wilmar International. Il gruppo comprende due stabilimenti nella regione di Odessa per la lavorazione di semi oleosi e oli tropicali.
Paesi Bassi. La Louis Dreyfus Company (LDC) possiede un grande terminal nel porto storico di Odessa. L’antica holding mercantile francese, che si occupa di agricoltura, finanza,trasformazione alimentare e spedizioni internazionali, ha sede ad Amsterdam e un ufficio operativo a Rotterdam. Inoltre, la Dutch Entrepreneurial Development Bank (controllata al 51% dallo Stato olandese) ha una quota nella Alseeds Black Sea, uno dei più grandi esportatori privati di olio di girasole in Ucraina, che gestisce un nuovissimo terminal di carico di olio vegetale nel porto Yuzhny.
La strategia elaborata dall’Italia sull’Ucraina mostra un cambiamento rispetto alle consuetudini della sua politica estera. Innanzitutto, non ha paura di esplicitare gli interessi nazionali, mobilitando grandi aziende. Questo nuovo stile della diplomazia italiana è coerente con il nuovo “Piano d’azione per l’export italiano nei mercati extra-Ue” varato a maggio 2025. L’Ucraina rientra in questa categoria.
In secondo luogo, la scelta di un territorio come la città/regione di Odessa, rappresenta qualcosa di nuovo, dai tempi lontani in cui le potenze europee prendevano in concessione città in altri paesi (come Tientsin in Cina per l’Italia). L’aspetto interessante è che Odessa, per la sua posizione geografica e il suo ambiente economico-sociale, offre alla diplomazia dei progetti culturali e degli aiuti umanitari, combinata con gli interessi nazionali, le condizioni ideali per gli obiettivi strategici dell’Italia.
Prima la visita di Giorgia Meloni al cimitero di Seul che onora i soldati caduti per la Nazione, in particolare durante la Guerra di Corea. Poi un punto stampa sul tema della Groenlandia e quindi l’incontro con le imprese italiane, in attesa del bilaterale con il presidente Lee Jae Myung. Dopo 19 anni un premier italiano torna a Seoul, a dimostrazione di una spiccata attenzione verso l’Indopacifico, per una serie di ragioni geopolitiche, economiche, commerciali (e anche personali).
Non è una novità il fatto che Giappone e Corea del Sud nelle logiche di Palazzo Chigi siano visti come due attori non solo affidabili, ma con cui rafforzare il livello delle relazioni di medio-lungo periodo. Si tratta ovviamente di un fazzoletto di mondo gravido di sfide e opportunità: accanto al macro tema geopolitica rappresentato dalle mire cinesi su Taiwan, spicca il link tra Mare Cinese e Mediterraneo e la questione delle terre rare accanto a chip e semiconduttori. Un paniere di temi altamente strategici che il capo del governo intende affrontare di petto, a maggior ragione dopo l’uscita dell’Italia dalla Via della Seta, senza dimenticare un elemento di supporto oggettivo: le società giapponesi e sudcoreane presentano numerose affinità con l’Italia sotto molteplici punti di vista (economici, commerciali e demografici), oltre a condividere i medesimi valori.
LO SHOWROOM HIGH STREET ITALIA
Il made in Italy a quelle latitudini è particolarmente apprezzato, ciò si trasforma in potenziali nuove opportunità legate al nostro export che può contare su questo valore aggiunto rispetto alla produzione di altri paesi. Le filiere interessate sono la moda, la pelletteria, il calzaturiero, il settore alimentare e vitivinicolo, senza dimenticare l’interior design. A proposito di prodotti e fiere, a Seoul nel 2019 ha visto la luce l’High Street Italia, uno showroom di quattro piani aperto in una delle zone più frequentate dello shopping della capitale, nella Garosu-gil, che rappresenta una vetrina per le aziende italiane che qui possono presentare la vasta gamma dei propri prodotti al mercato coreano. Realizzato dall’ICE col supporto del Ministero dello Sviluppo Economico e in collaborazione con l’ambasciata d’Italia, l’iniziativa rientra nel piano più generale della promozione straordinaria del Made in Italy nella Corea del Sud, che include anche della diffusione di cultura e lifestyle italiani
Le relazioni tra Roma e Seoul sono iniziate nel 1884 e hanno visto da poco il 140° anniversario, celebrato con un Anno dello Scambio Culturale. A tal fine infatti lo scorso 26 giugno l’ambasciata in Italia della Corea del Sud ha illuminato il Colosseo per celebrare le relazioni diplomatiche con Italia.
IL RUOLO DELLA COREA DEL SUD
Oltre a essere un player mondiale nel campo dell’innovazione tecnologica, la Corea è famosa in tutto il mondo anche per la cultura popolare legata a videogiochi, gruppi musicali e film. Settori spesso sottovalutati ma che possono contribuire, in nome della soft diplomacy, a rafforzare intese e cooperazioni. Cultura, conoscenza e qualità sono i tratti in comune tra i due paesi. La Corea del Sud incamera l’1% dell’export italiano per un valore di oltre 5 miliardi di euro, è il terzo mercato in Asia.
Corea del Sud fa rima con semiconduttori, per questa ragione il governo pensa di fare un ulteriore passo in avanti con la costruzione di una fonderia da 3 miliardi di dollari per incrementare la produzione e quindi confermare la propria posizione di leader globale nel settore dei chip grazie a marchi come Samsung Electronics e SK Hynix.
(Foto: Governo.it)
“L’Italia è perfettamente consapevole di quanto questa regione del mondo rappresenti un quadrante strategico negli equilibri globali, e intende continuare a fare la propria parte per preservare l’Artico come area di pace, cooperazione e prosperità”. Questo il punto centrale del messaggio inviato dalla premier Giorgia Meloni alla conferenza di presentazione del documento dedicato alla Politica Artica Italiana in cui si indicano le linee strategiche che il nostro Paese intende seguire, come osservatore nel Consiglio Artico, sostenitore del diritto internazionale del mare e membro della Ue e della Nato.
La posizione italiana ha radici antiche che risalgono alle missioni di esplorazione scientifica del secolo scorso ed all’adesione al Trattato delle Svalbard. L’accordo del 1920 contiene infatti clausole che, nel riconoscere la sovranità della Norvegia, stabiliscono il suo impegno a preservare l’ambiente naturale, non installare basi navali e fortificazioni, favorire la ricerca scientifica, consentire la presenza delle Parti contraenti.
Il regime di smilitarizzazione delle Svalbard è ritornato di attualità ora che la Russia ne pretende il rispetto. Esso va però inteso nella sua giusta accezione: non rinuncia ad esercitare difesa e deterrenza nell’Arcipelago da parte della Norvegia (e della Nato) ma impegno a non farne un uso offensivo. Questa è proprio la chiave per comprendere il senso della politica italiana che considera l’Artico “regione strategica, dove si intrecciano economia, ambiente, ricerca, energia e – oggi più che mai – sicurezza e difesa”. Ma l’aderenza della visione del nostro Paese alla realtà del Grande Nord è confermato da altri elementi.
Mentre per il territorio antartico esiste uno specifico trattato che ne stabilisce l’uso per fini pacifici proibendo appropriazioni di aree, installazioni e manovre militari, l’Artico non è governato da alcuno specifico accordo. Ad esso, si applica infatti l’ordinario diritto del mare come specifica la Dichiarazione di Ilulissat (Groenlandia) del 2008: il testo esprime la visione dei Paesi fondatori del Consiglio Artico, Canada, Danimarca, Norvegia, Russia e Stati Uniti (da notare che la Cina strumentalmente si definisce “Near-Arctic State”).
Nell’Oceano Artico gli Stati costieri sono quindi titolari di diritti nelle aree di piattaforma continentale e Zee come accade in altri regioni marine; sotto i ghiacci del Polo ci sono invece spazi di mare libero. I Paesi artici e quelli come l’Italia che hanno lo status di “osservatori” nel Consiglio si sono tuttavia impegnati a cooperare tra loro per la protezione del fragile ecosistema marino.
Ecco quindi che considerare l’Artico una zona di pace è un’esigenza connessa alla tutela degli habitat, ad evitare i rischi di inquinamento della navigazione commerciale e dello sfruttamento incontrollato delle risorse. Questo, in linea con la Convenzione del diritto del mare del 1982 che stabilisce l’uso pacifico dei mari come bene comune.
Non a caso l’Italia vede nella Norvegia il suo partner ideale per realizzare la sua strategia (come dichiarato anche da Eni): Oslo interpreta infatti al meglio i principi di cooperazione pacifica nel campo ambientale, scientifico ed economico che dovrebbero garantire la tutela degli spazi artici.
Ma che dire della Russia che sin dal tempo degli Zar considera l’Artico uno spazio che le appartiene sino al Polo come prolungamento delle terre emerse? E come non temere la sua massiccia militarizzazione delle coste e dei mari adiacenti o il controllo navale della Rotta a Nord Est (ora Northern Sea Route) che attraversa la sua Zee? Naturale quindi che Il sostegno italiano alla presenza della Nato nell’Artico vada visto come misura per “prevenire tensioni, preservare la stabilità e rispondere alle ingerenze di altri attori”.
La minaccia militare russa nell’Artico è una realtà incontestabile, non foss’altro perché Mosca deve difendere nel Circolo Polare Artico un enorme sviluppo costiero di circa 25.000 km. con risorse naturali ricchissime. È bene ricordare che nel momento in cui l’ex Urss si stava dissolvendo, Gorbashev lanciò nel 1987, con la Murmansk Initiative, una serie di proposte per fare dell’Artico una zona denuclearizzata e demilitarizzata. Non si trattava però di un piano di pace. A Mosca interessava soltanto allontanare dalle regioni polari le Forze occidentali sì da farne un proprio mare chiuso.
Con lo scioglimento dei ghiacci le zone polari si stanno ora aprendo alla navigazione internazionale ed alla competizione energetica: tra non molto sarà inevitabile per l’Occidente confrontarsi con la Russia per l’uso pacifico e condiviso dell’Artico.


© RaiNews
Pragmatismo è, anche o soprattutto, capire i tempi della politica e delle crisi in atto. Quando Giorgia Meloni da Seoul dice che solo senza escalation si va (tutti) a dama in Groenlandia, chiede in primis di abbassare i toni, avviare una discussione “tra di noi” e usare il “luogo” della Nato al fine di lavorare insieme per rispondere a una preoccupazione che “ci coinvolge tutti”. Ovvero che attori ostili possano avere la meglio su un interesse comune.
In questo senso va letta, secondo la presidente del Consiglio, la volontà di alcuni Paesi europei di essere parte attiva all’interno di un progetto che miri ad una maggiore sicurezza in Artico, anche con l’invio di truppe. Inoltre dice chiaramente ciò che pensa sui dazi (“un errore”). Ma su questo secondo elemento secondo Meloni c’è stato un problema di comprensione e di comunicazione. Per cui il primo messaggio che giunge dalla Corea del Sud è fermare tutte quelle azioni che potrebbero innescare un quadro di altissima tensione e, piuttosto, avviare un dialogo costruttivo per meglio comprendere i parametri di analisi e di azioni. Il tutto tenendo ben presente un passaggio che, secondo Meloni, è nevralgico: da parte americana c’è la preoccupazione per l’eccessiva ingerenza esterna su una zona strategica e, al contempo, da parte europea vi è la volontà di contribuire ad affrontare questo problema. Per cui, è il sunto dell’analisi, si può e si deve trovare un punto di incontro tra Ue e Usa.
Un problema che investe, gioco forza, i destini europei per una serie di ragioni geopolitiche come emerso due giorni fa dalla presentazione da parte del governo di Roma del corposo documento programmatico sull’Artico, che vuole definire un percorso progettuale tramite il rafforzamento dell’impegno italiano nella regione. Sull’ipotesi di una possibile partecipazione militare italiana come segnale di unità con gli europei alla missione nell’isola Meloni fuga ogni dubbio: “Ora è prematuro parlarne perché sto lavorando per cercare di abbassare la tensione e di tornare al dialogo”.
Per questa ragione la premier ha parlato al telefono con Donald Trump (“al quale ho detto quello che penso”) e ho con il segretario generale della Nato (“che mi conferma un lavoro che l’Alleanza Atlantica sta iniziando a fare da questo punto di vista”). Ma non finisce qui, dal momento che ci sarà anche un contatto tra leader europei in occasione di una riunione a livello di Coreper dell’Unione europea. C’è anche spazio per una precisazione a uso interno quando Meloni spiega per l’ennesima volta che non c’è un problema politico con la Lega sui nuovi dazi annunciati da Trump contro i Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia.
Meloni cita la postura del premier finlandese, Alexander Stubb, che ha specificato come tra alleati serva dialogo e non pressioni. Il riferimento è alla necessità di un’azione coordinata dagli alleati al fine di ribadire “i principi dell’integrità territoriale e della sovranità”. La costante del ragionamento di Meloni tocca un caposaldo della strategia euro-atlantica, ovvero il ruolo della Nato: è solo quello “il luogo nel quale noi dobbiamo cercare di organizzare insieme strumenti di deterrenza verso ingerenze che possono essere ostili”. Il fatto che la Nato abbia cominciato a lavorare in tale direzione è certamente una buona notizia.
“Ho sentito il presidente americano Donald Trump ed ho espresso le mie perplessità”, dice questa mattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un momento di particolare tensione nelle relazioni tra Stati Uniti ed Europa attorno al dossier “Groenlandia”. Il messaggio, che arriva dalla Corea del Sud, chiede di evitare l’escalation abbassando i toni. Un lavora che l’Italia sta cercando di spingere anche in sede Ue.
La convocazione di una riunione straordinaria degli ambasciatori dell’Unione Europea nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 18 gennaio, per valutare una risposta coordinata all’annuncio statunitense di nuove tariffe contro alcuni Paesi membri, segna l’ingresso della crisi sulla Groenlandia in una nuova fase. Non più soltanto uno scontro retorico o una disputa diplomatica, ma un dossier che incrocia commercio, sicurezza economico (e non solo) e coesione transatlantica, costringendo Bruxelles a una risposta “intelligente, coordinata e possibilmente non ulteriormente incendiaria” a Washington, dice una fonte dai corridoio europei.
Il detonatore è stato l’annuncio di Trump, che sabato ha fatto sapere che nuovi dazi colpiranno una serie di Paesi alleati – tra cui Francia, Germania, Danimarca e Regno Unito – accusati di aver rafforzato la propria presenza militare in Groenlandia come forma di deterrenza contro gli Stati Uniti. Una misura che riapre una frattura commerciale che l’Europa riteneva superata dopo la tornata di dazi di inizio presidenza, e che collega esplicitamente il terreno economico a quello strategico, nel momento in cui l’Artico torna a essere uno spazio di competizione crescente e la Groenlandia gioca un ruolo per l’asse transatlantico e per il Western Hemisphere che Trump intende proteggere come missione identitaria della “sua” National Security Strategy.
Da Bruxelles, il presidente del Consiglio europeo, António Costa, ha parlato della necessità di una risposta comune, ribadendo che l’Unione europea difenderà il diritto internazionale e l’integrità territoriale dei suoi Stati membri – nel caso la Danimarca, che p sovrana sulla Groenlandia. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha avvertito che una spirale tariffaria rischia di danneggiare la prosperità condivisa e di indebolire il fronte occidentale, messaggio arrivato anche della Hr/Vp Kaja Kallas, che ha citato esplicitamente Cina e Russia come i favoriti dalle divisioni transatlantiche. Diversi leader europei hanno sottolineato come la sicurezza della Groenlandia possa e debba essere affrontata all’interno dei meccanismi Nato, che racchiude sia gli Usa che diversi Paesi europei.
Il dato politico, tuttavia, va oltre la contingenza. La riunione degli ambasciatori segnala che la questione groenlandese non è più un tema periferico, ma un banco di prova per la capacità dell’Occidente di gestire divergenze strategiche senza trasformarle in crisi sistemiche. È su questo crinale – tra deterrenza, dialogo e interessi divergenti – che si gioca ora la partita più delicata.
Sul piano analitico, la narrativa che giustifica un cambio di status dell’isola regge poco. Come ha osservato Richard Fontaine, Ceo del Anas, la Groenlandia non è un dossier intrinsecamente complesso: lo diventa solo se lo si carica di obiettivi che esulano dalla realtà dei fatti. Gli Stati Uniti dispongono già, grazie agli accordi con la Danimarca, di ampi margini operativi in termini di basi, tra radar e presenza militare di ogni possibile genere. La difesa dell’Artico e il monitoraggio delle attività di Cina e Russia possono essere rafforzati senza bisogno di “possedere” il territorio, spiega l‘esperto americano. L’idea che la sicurezza richieda l’annessione statunitense, o che la deterrenza passi dall’invio simbolico di piccoli contingenti multinazionali come quelli europei, finisce per produrre l’effetto opposto: politicizzare e radicalizzare un dossier che potrebbe essere gestito in modo pragmatico.
Anche l’argomento secondo cui la Groenlandia rischierebbe di “cadere” sotto l’influenza di potenze rivali appare debole se non accompagnato da scelte coerenti. Secondo Fontaine, se davvero Mosca e Pechino rappresentassero una minaccia imminente, la risposta più lineare sarebbe rafforzare i dispositivi esistenti e il coordinamento Nato, non aprire un contenzioso politico con Copenaghen e con gli alleati europei. Le alleanze, ragiona, si fondano proprio sulla difesa reciproca di territori che non si possiedono: è questa la logica che ha retto l’ordine post-1945 e che continua a garantire stabilità.
Un’ulteriore chiave di lettura arriva dall’intervista pubblicata sabato dal Corriere della Sera con protagonista l’ex ambasciatrice statunitense in Danimarca Carla Sands. Sands, forte della sua esperienza diretta sul dossier groenlandese e attualmente nel team dell’America First Policy Institute, ha ricordato come l’interesse americano sia legato soprattutto alla sicurezza e alle risorse strategiche, non a una conquista formale. Le sue parole aiutano a distinguere tra l’obiettivo sostanziale – evitare che l’isola finisca sotto un’influenza ostile di Cina o Russia – e la retorica che rischia di irrigidire le posizioni. In questo senso, l’accento posto sul possibile percorso di lungo periodo verso una maggiore autonomia groenlandese suggerisce che il nodo non sia “a chi appartiene” il territorio, ma come garantirne stabilità e sviluppo senza forzature.
È in questo spazio che si inserisce la posizione italiana, improntata a responsabilità e controllo, con le perplessità espresse da Meloni. Durante la presentazione del Documento strategico sull’Artico, il 16 gennaio 2026, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha messo in guardia contro approcci frammentati e simbolici, osservando che l’idea di piccoli contingenti europei dispiegati sull’isola non somiglia a una strategia credibile. Il punto, ha sottolineato, è tenere unito il mondo occidentale e preservare il quadro di cooperazione. A posteriori, quelle parole suonano quasi profetiche: il giorno dopo, l’annuncio dei dazi americani contro quei contingenti ha mostrato quanto rapidamente una gestione muscolare possa produrre contraccolpi politici ed economici.
Il paradosso è che entrambe le strade estreme – l’idea di “conquistare” la Groenlandia e quella di usarla come palcoscenico per segnali di deterrenza – finiscono per alimentarsi a vicenda. Il rischio è che l’una legittimi l’altra, in una dinamica che favorisce solo gli attori interessati a dividere l’Occidente. Fonti diplomatiche spiegano che la via d’uscita è più sottile, ma anche più realistica: un dialogo strutturato che consenta a Washington di rivendicare un rafforzamento della sicurezza artica, e a Trump di ottenere “qualcosa che possa essere raccontato come una vittoria”, e all’Europa di mantenere lo status quo, garantendo al tempo stesso che l’isola resti saldamente ancorata allo spazio euro-atlantico.
In quest’ottica, il compromesso non è una resa, ma uno strumento politico. Permette a Trump di presentare un risultato tangibile al proprio elettorato – maggiore attenzione all’Artico, più investimenti in sicurezza, tagliare fuori i rivali dell’emisfero occidentale – e agli europei di evitare una deriva che metterebbe in discussione sovranità e alleanze cruciali come quella con gli Usa. La Groenlandia è strategica, e proprio per questo va sottratta alla logica della provocazione. Meno benzina sul fuoco, più diplomazia: è l’unico modo per spegnere una scintilla prima che diventi crisi.
Il rischio del confronto è anche racchiuso nel messaggio che emerge da alcuni recenti sondaggi, come quello di Ecfr. Gli scontri – verbali, postulali, pratici – legati alle posizioni complicate prese da Trump rischiano di allontanare le opinioni pubbliche europee dagli Stati Uniti, con un riflesso ancora più problematico: creare spazi dove la narrazione e la disinformazione cinese si nuove per piegare gli europei e altri alleati statunitense verso Pechino.
La politica estera è spesso complessa, stratificata, ambigua. La Groenlandia, no. È da questa premessa che parte Richard Fontaine, Ceo del Center for New American Security di Washington, analizzando punto per punto le argomentazioni circolate a Washington e Bruxelles sull’idea che gli Stati Uniti debbano prendere il controllo dell’isola artica. Non per minimizzare la sua importanza strategica, ma proprio per ricondurla a una dimensione realistica, la lettura di Fontaine è lucida e soprattutto aggiornata con le discussioni sia a DC che tra i corridoio Ue.
Il primo nodo riguarda la difesa americana. Secondo Fontaine, è innegabile che la Groenlandia sia rilevante per la sicurezza degli Stati Uniti: radar, basi, sistemi di allerta precoce e, oggi, anche l’architettura di difesa missilistica rientrano pienamente nell’equazione. Ma da qui a sostenere che Washington debba possedere il territorio, il salto logico è enorme. Gli Stati Uniti, ricorda, possono già fare praticamente tutto ciò che desiderano sul piano militare senza esercitare alcuna sovranità diretta. L’accordo di difesa firmato con la Danimarca nel 1951 – e aggiornato nel 2004 – consente presenza militare, infrastrutture e operazioni. La sicurezza, dunque, non richiede annessione.
La seconda argomentazione che Fontaine contesta è quella dell’urgenza geopolitica: la Groenlandia sarebbe sul punto di cadere sotto l’influenza di Russia o Cina, e gli Stati Uniti dovrebbero intervenire prima che sia troppo tardi. Qui l’analisi diventa quasi banale nella sua semplicità. Se davvero esistesse una minaccia imminente – ipotesi che Fontaine giudica infondata – la risposta più logica sarebbe rafforzare la presenza americana. Un tempo, sull’isola stazionavano fino a 10.000 soldati statunitensi; oggi sono circa 200. Se la preoccupazione è reale, perché non partire da lì?
Il terzo punto riguarda la dimensione marittima. Se navi russe e cinesi stessero realmente “brulicando” intorno alla Groenlandia, osserva Fontaine, la Marina statunitense avrebbe piena capacità di pattugliare l’area in modo massiccio e immediato. Non lo sta facendo. Anche questo dato suggerisce che la narrativa dell’assedio non corrisponde ai fatti operativi.
Segue poi uno degli argomenti più evocativi, ma anche più fragili: “Non si difendono i territori che si affittano”. L’idea è che, anche concedendo pieno accesso militare, esisterebbe una differenza qualitativa tra possesso e uso. Fontaine liquida questa impostazione come una versione caricaturale delle relazioni internazionali – la teoria secondo cui “nessuno lava un’auto a noleggio”. Nella realtà, spiega, gli Stati Uniti difendono costantemente territori che non possiedono. È il senso stesso delle alleanze. Washington ha appena difeso Israele; difende Paesi Nato; nessuno di questi è territorio americano.
Il quinto passaggio è forse il più delicato sul piano politico: l’idea che la Danimarca sia un cattivo alleato e che, per questo, dovrebbe cedere la Groenlandia. Fontaine ribalta completamente la prospettiva. La Danimarca, ricorda, è stata un alleato esemplare. In Afghanistan, in proporzione alla popolazione, ha subito perdite superiori a quelle di molti altri partner. In altre parole, i danesi hanno combattuto per la sicurezza americana, pur non possedendo alcun territorio degli Stati Uniti.
C’è poi la dimensione ideologica, quella che richiama un nuovo “destino manifesto”. L’idea di un’America naturalmente espansiva, destinata ad allargarsi incorporando nuovi territori. Qui Fontaine richiama un principio cardine dell’ordine internazionale post-1945: il divieto di acquisizione territoriale tramite coercizione. L’Iraq non può prendersi il Kuwait, la Russia non può avere l’Ucraina, il Canada non diventa il 51° Stato. E, allo stesso modo, gli Stati Uniti non possono costringere la Groenlandia a entrare nella propria orbita sovrana. Il mondo in cui la conquista è la norma, avverte, è il mondo della legge della giungla.
Infine, l’ultima ipotesi: tutto questo non sarebbe reale, ma semplice trolling politico nei confronti di alleati europei eccessivamente nervosi. Anche questa lettura viene respinta. Anche se fosse solo provocazione, resta una distrazione significativa dai dossier che dovrebbero occupare il centro dell’agenda transatlantica: Russia, Ucraina, Iran, Cina. E soprattutto mina un bene strategico fondamentale: la fiducia degli alleati nella parola e nelle intenzioni americane.
Fontaine torna così al punto di partenza. Molte questioni di politica estera sono difficili. La Groenlandia non lo è. È diventata tale solo perché è stata trasformata artificialmente in una crisi. E, conclude, prima questa crisi costruita svanisce, meglio è per tutti.


© RaiNews
La Cina è economicamente e geopoliticamente debole, ma le sue capacità di pianificazione restano robuste. Gli Stati Uniti sono finanziariamente e geopoliticamente più forti, ma rapporti tesi con gli alleati e la mancanza di piani a lungo termine creano spazi di intervento. Pechino potrebbe essere nel mezzo di correzioni politiche.
L’economia cinese può essere descritta con una serie di stime approssimative. C’è quasi il 50% di disoccupazione giovanile. Circa 200 milioni di persone sono nell’economia dei lavoretti (gig economy), cioè circa il 40% dei lavoratori urbani è sottoccupato. Probabilmente ci sono 100 milioni di appartamenti invenduti. C’è sovrapproduzione di tutto. La gente risparmia su tutto perché non esiste uno stato sociale e teme eventi improvvisi e imprevedibili come le epidemie di Covid del 2020-2023, quando il Paese è stato in lockdown per quasi quattro anni. Gli impiegati hanno solo il 40% di reddito disponibile rispetto all’80% dei Paesi sviluppati. Per questo il consumo interno non riparte abbastanza in fretta. Tutti i tipi di sussidio, inclusi quelli di governo centrale, amministrazioni locali e imprese statali (Soe), potrebbe costituire il 15% del debito del bilancio statale. La crescita economica lo scorso anno è stata di circa il 5%; perciò, nel 2025, il rapporto debito/Pil potrebbe essere aumentato del 10% annuo. A questo ritmo, in 4-5 anni il debito totale della Cina potrebbe superare il Pil globale. Per annullarlo, la Cina avrebbe bisogno di crescita e inflazione, ma l’inflazione renderebbe i poveri ancora più poveri, aumentando la volatilità sociale e la propensione alle proteste.
Eppure, il Paese registra un avanzo commerciale annuo di mille miliardi di dollari, insostenibile per il commercio mondiale. È l’unica fonte di soldi/crescita reali. Dopo le recenti epurazioni, quando decine di alti ufficiali sono stati messi sotto indagine, non è chiaro se l’Esercito Popolare di Liberazione sia affidabile o capace di svolgere i suoi compiti. Ma dispone scorte di armi sufficienti a dimostrare una capacità di deterrenza. Le manovre recenti, che hanno mobilitato 1.200 e 2.000 grandi imbarcazioni da pesca in una linea di 500 km davanti al Giappone, hanno dimostrato che una flotta civile può essere mobilitata per obiettivi militari. I vascelli, talvolta grandi quanto fregate, potrebbero proteggere la propria marina militare confondendo attacchi con siluri o missili o speronando navi nemiche. In questo quadro, la guerra russa in Ucraina può essere necessaria per tenere gli Stati Uniti in guardia. Tutto ciò aumenta l’instabilità potenziale.
I dati potrebbero far sembrare che la Cina sia sul punto di esplodere. Ma Pechino mantiene un controllo saldo. Esistono massicci controlli della popolazione. L’apparato di partito sa che senza il leader supremo verrebbe delegittimato, quindi lo sostiene, pur temendolo. E lui li tiene sotto stretta sorveglianza. Molti cittadini stanno abbastanza bene, anche se non hanno più la speranza di arricchirsi come decenni fa. C’è sicurezza pubblica, e pochissima criminalità. La maggior parte ha una posizione di riserva in campagna, con una casa e un piccolo podere, e senza tasse per la prima volta in migliaia di anni.
La Cina detiene un quasi-monopolio sugli elementi delle terre rare (Ree). Su molti prodotti ha un vantaggio prezzo-qualità che gli Usa difficilmente potrebbero recuperare senza costi elevati. Centinaia o migliaia di produzioni sono in questa nicchia. La Cina è indispensabile per gli altri ma non ha una vera dipendenza dall’esterno. Potrebbe chiudersi in uno stile semi Corea del Nord, come fece la dinastia Qing prima della Prima Guerra dell’Oppio del 1840.
La Cina non ha bisogno di una vittoria a breve termine; ha bisogno di resistere. Gli Usa hanno bisogno di una strategia a lungo termine per riconquistare il mondo e vincere. Pertanto, data la struttura delle due società, aperta negli Usa e chiusa in Cina, se la Cina interrompesse le esportazioni verso gli Usa, gli Stati Uniti soffrirebbero, si lamenterebbero e protesterebbero. Se lo facessero gli Usa con la Cina, la Cina potrebbe soffrire anche di più, ma non urlerebbe né protesterebbe. La Cina può quindi chiudersi lentamente in stile “Corea del Nord”.
Tuttavia, la chiusura può durare solo per un certo tempo. Se la Cina dovesse andare in modalità “Corea del Nord” per più di un decennio, il presidente Xi Jinping, allora sopra gli 80 anni, potrebbe avere difficoltà a mantenere il Paese unito, e tutto potrebbe disgregarsi dopo la sua scomparsa. Deve trovare una soluzione relativamente presto. Il suo orizzonte, in ogni caso, non è di mesi; è di anni. Può permettersi, e potrebbe essere comodo, di aspettare di vedere come si muoveranno realmente gli Usa dopo il mandato di Donald Trump.
Pertanto, gli Stati Uniti hanno bisogno di una strategia a lungo termine per affrontare la Cina. Senza di essa, gli errori di valutazione sarebbero più probabili e il pericolo crescerebbe in modo esponenziale. La Cina ha destabilizzato l’ordine che gli Usa e i loro alleati avevano stabilito nel 1945 in una parte del mondo, estendendolo poi globalmente dopo la fine della Guerra Fredda nel 1989. Ora è una corsa a chi per primo svilupperà nuove regole per il gioco globale. Il vincitore deve essere complessivamente più forte ma anche offrire regole migliori per includere tutti in un ordine differente.
Gli Usa devono reindustrializzarsi e mettere in ordine la propria società e i conti. Non è impossibile; non è nemmeno difficile. Richiede volontà politica a lungo termine e determinazione. Gli Usa stanno meglio perché dovrebbero solo ritoccare l’ordine esistente per tornare in cima. Ma ora sono nel mezzo di una crisi esistenziale; perciò potrebbero non esserne capaci. Pechino non sa come governare il mondo. Attualmente il suo modello sembra essere una ristrutturazione totale e quindi difficoltoso. Sa solo come governare la Repubblica Popolare Cinese (Prc) con il sistema presente, che teme di cambiare. Gli Usa hanno Venezuela, Iran e in parte la Russia dalla loro parte. Sono riusciti a cambiare la leadership in Venezuela, stanno scuotendo l’albero iraniano e hanno messo la Russia alle corde.
Queste sono minacce geopolitiche che potrebbero tradursi in punti di pressione per materie prime ed esportazioni di petrolio. La Cina possiede tutti i vantaggi essenziali nella sua industria d’esportazione. Pertanto, il vertice Trump-Xi di aprile potrebbe essere una pausa: geopolitica contro commercio. Ma alla fine, la Cina può fare a meno della sua geopolitica — pur potendo spingersi alla follia — mentre l’America potrebbe soffrire di più rinunciando alla catena di approvvigionamento cinese.
La Cina ha un piano a breve termine ma obiettivi a lungo termine vaghi. Gli Usa hanno il vantaggio ma mancano di un piano a breve termine, e l’uscita a lungo termine è poco chiara. Gli Usa devono rafforzare la loro economia. Ma se lo fanno a costo di lacerare alleanze e relazioni internazionali, offrono enormi vantaggi che la Cina può sfruttare. I recenti accordi cinesi con Canada ed Ue ne sono un’indicazione. Si sono sentiti sotto pressione e hanno trovato il modo di rivitalizzare il commercio con la Cina, mentre gli Usa si erano fatti più avversari.
Il Financial Times ha sostenuto che le mosse Usa rendono la Cina un modello. I dati sulle esportazioni cinesi del 2025 rappresentano chiaramente questo. Il suo avanzo commerciale ha raggiunto un record di 1,2 trilioni di dollari, nonostante una riduzione del 20% del surplus con gli Usa. Cioè, lo squilibrio commerciale globale con la Cina è peggiorato nonostante i miglioramenti statunitensi. Questo degrada la posizione complessiva degli Usa nel mondo e migliora quella della Cina.
Negli ultimi 50 anni la Cina ha avuto una crescita e uno sviluppo senza precedenti. Il popolo cinese ha lavorato duramente, il governo ha contribuito, ma il motore principale sono stati gli Stati Uniti. Dagli anni ’70 e poi dagli anni ’80, questi hanno concesso basse tariffe alle esportazioni cinesi verso gli Usa, massicci trasferimenti tecnologici e indirizzo economico tramite consigli della Banca Mondiale. Dopo la repressione di Piazza Tiananmen nel 1989 e poi di nuovo, un decennio dopo, nonostante amare controversie sulla proprietà intellettuale, l’America rifiutò di voltare le spalle alla Cina, accelerando la diffusione della ricchezza e la creazione per la prima volta di una grande classe media cinese. Questo ha cambiato il contesto di ogni rivalità cinese.
Cinesi più ricchi e meno numerosi (a causa del drastico calo delle nascite) sono meno inclini a fare guerra. Sono diventati diversi dai vicini nordcoreani, che hanno mandato volentieri circa 50.000 volontari a morire per la Russia in Ucraina. La contrapposizione della Cina con gli Usa e i vicini cresce, ma una guerra totale sembra per ora improbabile, anche grazie al benessere accumulato negli ultimi 50 anni. In questa pausa, gli Usa avrebbero tempo per rimodellare l’ordine mondiale con piccoli aggiustamenti.
La ristrutturazione globale cinese richiederebbe uno sforzo molto maggiore. Potrebbe riuscirci o fallire, in contrasto inverso con il successo o il fallimento degli Usa. Intanto, fra un decennio circa, cinesi più poveri e più numerosi, liberati dalla politica del figlio unico e con un Paese più potente, potrebbero sentirsi diversamente riguardo alla guerra. Sarebbe il periodo in cui Xi, sugli 80 anni, potrebbe perdere presa sul potere. Il mix potrebbe diventare altamente infiammabile.
I problemi economici cinesi hanno radici politiche. Ma è difficile affrontarli nella situazione attuale. Potrebbe esserci uno stallo tra Xi e la struttura del partito. Xi ha più potere di qualsiasi leader del partito nella Prc prima di lui. Tuttavia, il suo potere non è assoluto; dipende dalla struttura del partito, e il potere della struttura dipende dal leader supremo. C’è quindi un equilibrio di distruzione reciproca assicurata. Qui, nessuno può permettersi di apparire debole verso l’America, perché l’altra parte attaccherebbe immediatamente, accusando i deboli di tradimento. Attualmente, Xi non avrebbe potere senza la struttura, e viceversa.
Tuttavia, l’equilibrio di potere non è assoluto. Anche in teoria, la struttura non può fare a meno di un leader supremo; quindi, la loro unica via d’uscita sarebbe sostituire Xi con qualcun altro, ma non è facile. In teoria, Xi potrebbe, in parallelo, fare a meno della struttura presente e raggiungere il potere assoluto, come teorizzato da Hanfeizi (filosofo del III secolo a.C.). Non sarebbe facile, ma meno difficile in pratica che sostituire Xi.
Tuttavia, il “potere assoluto” di Hanfeizi va di pari passo con il wu wei, la non-azione — il non-intervento dell’imperatore, che stabilisce la direzione principale dell’impero ma lascia la gestione ai ministri. Hanfeizi fornì infatti il primo commento al Tao Te Ching (Dao De Jing) di Laozi, che teorizzò per primo il wu wei politico.
Ora è impossibile replicare lo schema antico di Hanfeizi, ma la riforma politica e una democrazia moderna potrebbero spezzare l’impasse politico. La struttura del partito dovrebbe essere ulteriormente destrutturata e perdere ancora più potere. Venti o trent’anni fa, quando la Cina era meno importante a livello globale e godeva di simpatia internazionale, Pechino avrebbe potuto promuovere questo tipo di riforme da sola.
Ora che il Paese è diventato più critico in un clima di sfiducia e tensioni globali, possibili cambiamenti interni cinesi impattano l’ordine mondiale e, se condotti da soli, potrebbero spaventare metà del mondo più delle riforme di fatto di Trump negli Usa. Pertanto, Pechino dovrebbe discutere il contenuto delle sue riforme con gli Usa e altri Paesi interessati. Ma al momento non c’è alcuna mossa in questa direzione a Pechino, e il punto morto persiste in mezzo a crescenti tensioni interne.


© RaiNews



© RaiNews




© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews


© RaiNews






La lettera inviata da Donald Trump al presidente egiziano Abdel Fattah al‑Sisi il 16 gennaio 2026 va letta come qualcosa di più di un ringraziamento formale per la mediazione sul cessate il fuoco a Gaza. Il testo rivela una precisa intenzione strategica: inserire il ruolo dell’Egitto nella crisi israelo‑palestinese dentro una più ampia architettura regionale, che oggi ruota attorno a tre dossier intrecciati — la tenuta della tregua a Gaza, la stabilizzazione del Mar Rosso e la crisi in corso nel Corno d’Africa. Dal Cairo, e dal contatto statunitese, passa anche il messagging strategico che Washington sta mandando all’Arabia Saudita, impegnata in un attivo riposizionamento geopolitico orientato alla costruzione di un’architettura di sicurezza regionale che coinvolge Turchia e Pakistan, ma pensa anche all’Egitto.
Nel messaggio, Trump riconosce esplicitamente la leadership egiziana nella mediazione tra Israele e Hamas dopo il sanguinoso attacco terroristisco palestinese del 7 ottobre 2023, che ha aperto la stagione di guerra e la risposta brutale israeliana. Trump collegando correttamente la guerra israeliana a Gaza alla stabilità dell’intera regione. Questo passaggio assume particolare rilievo nel momento in cui Washington ha deciso di lanciare la “fase due” del cessate il fuoco, prevista dal cosiddetto “Trump Plan”. Ora l’obiettivo è passare dalla tregua e auspicata demilitarizzazione, alla governance tecnocratica e all’avvio della ricostruzione.
In questo schema, l’Egitto ha il ruolo cruciale del facilitatore diplomatico, perché è un attore strutturale: controlla uno dei principali accessi alla Striscia, il valico di Rafah, mantiene canali aperti con le diverse fazioni palestinesi (anche per interessi nazionali diretti al mantenimento dell’equilibrio) ed è in grado di offrire una cornice regionale alla fragile transizione post‑bellica. Il sostegno politico americano a Il Cairo risponde quindi a un’esigenza di continuità: senza l’Egitto, la “fase due” rischia di restare un esercizio di ingegneria istituzionale privo di ancoraggio sul terreno.
Da qui, si apre a una contropartita. Il passaggio più significativo della lettera è infatti quello in cui Trump si dice pronto a riavviare la mediazione statunitense tra Egitto ed Etiopia sulla condivisione delle acque del Nilo e sulla diga Gerd. La questione è esistenziale: le acque del Nilo sono storicamente, da secoli, considerate fonte di vita dall’Egitto, e pensare a un taglio dell’aliquota portata dal fiume identitario – per un’infrastruttura che beneficerà la prosperità etiope – è da sempre una red-line per Il Cairo. Il riferimento al rischio di un conflitto militare esplicita come Washington percepisca questo dossier non come una disputa tecnica, ma come una minaccia potenziale alla stabilità africana e medio‑orientale.
Gaza fornisce all’Egitto capitale politico e centralità diplomatica; il Nilo rappresenta invece il cuore della sicurezza nazionale egiziana. Mettere i due piani nello stesso documento significa, da parte americana, riconoscere e rafforzare il ruolo regionale del Cairo, ma anche vincolarlo a una cornice multilaterale e negoziale, evitando soluzioni unilaterali. Ossia, mandare un segnale chiaro: Washington solo può avere modo di mediare, gli altri player rischiano destabilizzazione ulteriore.
“Il mio team e io comprendiamo il profondo significato del fiume Nilo per l’Egitto e per il suo popolo, e desidero aiutarvi a raggiungere un esito che garantisca i fabbisogni idrici dell’Egitto, della Repubblica del Sudan e dell’Etiopia nel lungo periodo”, dice Trump, sottolineando che gli Stati Uniti affermano che “nessuno Stato della regione dovrebbe controllare unilateralmente le preziose risorse del Nilo, penalizzando nel processo i Paesi vicini”.
Ancor: “Ritengo che, con il giusto apporto di competenze tecniche, negoziati equi e trasparenti e un ruolo forte degli Stati Uniti nel monitoraggio e nel coordinamento tra le parti, sia possibile raggiungere un accordo duraturo per tutti i Paesi del bacino del Nilo”. Di più: “Un approccio di successo garantirebbe rilasci idrici prevedibili durante i periodi di siccità e negli anni di prolungata scarsità per l’Egitto e il Sudan, consentendo al contempo all’Etiopia di produrre quantità molto rilevanti di energia elettrica, parte della quale potrebbe essere ceduta o venduta all’Egitto e/o al Sudan”.
La lettera va letta anche alla luce di quel tentativo saudita di promuovere una nuova architettura di sicurezza in Medio Oriente, anche attraverso un rafforzamento dei legami con Egitto e Somalia. L’iniziativa di Riyadh risponde a una duplice esigenza: contenere l’instabilità lungo le rotte marittime strategiche e riequilibrare il peso degli Emirati Arabi Uniti in Yemen e Corno d’Africa. Vedere Sudan: Nel conflitto in Sudan, la tradizionale alleanza tra Riyadh e Abu Dhabi si è trasformata in una linea di frattura geopolitica, con l’Arabia Saudita che sostiene le Forze Armate Sudanesi e spinge per un approccio più statale alla stabilizzazione, mentre gli Emirati sono stati associati a un più marcato appoggio alle Rapid Support Forces tramite reti paramilitari e finanziarie, accentuando così le divergenze tra i due Paesi su visioni e strumenti di influenza regionale.
In questo contesto, l’Egitto diventa un partner naturale per l’Arabia Saudita: per prossimità geografica, per capacità militari e per il ruolo storico nel mondo arabo. Il sostegno saudita all’integrità territoriale somala e la crescente cooperazione con Il Cairo indicano la volontà di costruire una coalizione selettiva, meno ideologica e più funzionale, centrata su sicurezza marittima, intelligence e deterrenza regionale. Allo stesso tempo, l’Egitto mantiene solidi canali politici, economici e di sicurezza anche con Abu Dhabi, collocandosi in una posizione di cerniera strategica tra due fronti solo apparentemente contrapposti: una frattura reale sul piano operativo, ma potenzialmente ricomponibile in qualsiasi momento, data l’elevata fluidità degli attuali equilibri regionali.
Trump non appare in disaccordo con questo orientamento. Al contrario, la presenza in copia nella lettera di leader sauditi ed emiratini segnala che Washington segue e, in parte, cerca di controllare il processo. Il tono del messaggio suggerisce un limite chiaro: gli Stati Uniti non intendono avallare un assetto regionale che possa produrre nuove fratture o escalation incontrollate.
Il richiamo al principio secondo cui nessuno Stato dovrebbe controllare unilateralmente risorse strategiche come il Nilo è indicativo di questa impostazione. Trump sembra accettare l’idea di una coalizione regionale guidata da attori arabi, ma vuole mantenerla compatibile con l’equilibrio complessivo, evitando che si trasformi in un blocco rigido o in un fattore di destabilizzazione, soprattutto in Africa orientale.
Gaza, il Mar Rosso e il Corno d’Africa non sono più dossier separati. La lettera a al‑Sisi mostra come l’amministrazione Trump stia cercando di gestirli come parti di un’unica scacchiera, in cui l’Egitto funge da snodo tra Medio Oriente e Africa, e l’Arabia Saudita da architetto di una nuova cooperazione regionale.
In questo quadro, la mediazione su Gaza diventa il banco di prova di un disegno più ampio: se la “fase due” reggerà, rafforzerà non solo la tregua nella Striscia, ma anche la credibilità di un assetto regionale in cui Washington resta arbitro esterno, pronto a sostenere le iniziative dei partner, ma attento a impedirne le derive.

Il lungo viaggio di Giorgia Meloni in Oman, Giappone e Corea del Sud è un tentativo, ben costruito e determinato, di ancorare l’Italia globale a reti geopolitiche e a reti economiche affidabili. Questo a tutto beneficio del sistema Paese. Lo dice a Formiche.net Gabriele Checchia, esperto diplomatico, già ambasciatore in Libano, presso la Nato, vicedirettore dell’Unità Russia e Paesi dell’area ex-sovietica alla Direzione Generale Affari Politici e Consigliere Diplomatico di vari ministri, che identifica un preciso filo conduttore dell’azione della premier tra Muscat, Tokyo e Seul: ovvero voler diversificare le partnership e rafforzare il ruolo italiano come principale collegamento tra Europa, Golfo e Asia. Roma mostra la volontà di tenere insieme i singoli teatri perché le catene si sono accorciate: Indopacifico, Mediterraneo e Italia sono contigue.
Politica, geopolitica e relazioni commerciali: tra Oman, Giappone e Corea del Sud quale il bilancio della missione di Giorgia Meloni?
Direi che è un bilancio positivo per una serie di motivi. Il primo è che si tratta di una missione che si è collocata nell’ambito di una riflessione geopolitica da parte della presidente del Consiglio, del nostro governo e del ministro degli Esteri. Cioè non una missione di cosmetica o di puro cerimoniale, ma una missione che riflette un mondo in rapida evoluzione, nel quale l’instabilità e l’ interconnessione tra i mercati e le aree geografiche è diventata centrale. Per esempio, la tappa in Oman è una testimonianza del fatto che l’instabilità del Medio Oriente (e l’Oman è un partner affidabile in quella regione del mondo) ha implicazioni dirette per il transito navale per i flussi di energia.
Lo stesso dicasi per la tappa in Giappone e Corea?
Sì, poiché sappiamo quanto conta l’Indopacifico per l’approvvigionamento europeo ma anche per le tensioni intorno a Taiwan. Non è un caso che la presidente Meloni e il primo ministro giapponese ne abbiano posto l’accento ripetutamente anche nel loro editoriale sul Corriere della Sera e sul quotidiano giapponese Nikkei: ovvero la necessità di un Indopacifico aperto e libero nonché direi sulla connessione tra l’Indopacifico e il Mediterraneo allargato. Mi sembrano tutti segnali della consapevolezza di una crescente interdipendenza tra le varie aree geografiche e del fatto che Italia e Giappone sono due paesi legati all’Occidente, ma sempre con una politica estera responsabile e attenta agli equilibri complessivi. Questo consentirebbe anche di rafforzare la sicurezza economica di entrambi.
Perché il fronte asiatico e dell’Indopacifico è così strategico per l’Italia?
Cito un virgolettato nella parte finale di quell’editoriale a firma congiunta che lo spiega. Un elemento distintivo di questa visione comune tra Italia e Giappone è la volontà di impegnarsi attraverso il Mediterraneo allargato e l’Indopacifico, spazi geografici centrali negli equilibri globali. In questa visione condivisa, la sicurezza economica assume importanza sempre maggiore e ovviamente quando si parla di sicurezza economica si parla di sicurezza delle catene di valore, della certezza che non verranno messe a rischio e della necessità di fare tutto quanto possibile perché queste catene di valore siano regolari e prevedibili. Direi che questa è una dimensione molto importante del viaggio.
La dimensione geopolitica globale, dunque, oltre a quella bilaterale?
Esatto, quella che ci offre l’icona di una Italia sempre più globale. Il rapporto tra Italia e Giappone è antico, non è un caso che la missione della presidente Meloni sia stata anche celebrativa del 160º anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra due Paesi, lontani geograficamente ma come rilevato da Meloni molto vicini sotto tanti profili a cominciare dall’essere ambedue eredi di una grande cultura.
Tale ragionamento di visione condivisa e globale porta anche all’Africa?
Lì la strategia italiana del Piano Mattei e l’esperienza giapponese condividono molti punti in comune ovviamente con riferimento all’Africa. Penso alla cooperazione paritaria e vantaggiosa per tutti, fondata su soluzioni condivise e investimenti capaci di generare prosperità sul lungo periodo. La terza dimensione della missione, quella legata alla volontà del nostro Presidente del Consiglio, punta sulla crescita del flusso di investimenti nelle due direzioni. Se noi pensiamo al numero impressionante di imprese giapponesi attive sul mercato italiano e di imprese italiane attive sul mercato giapponese, con 8000 dipendenti, un fatturato da almeno 3 miliardi di euro, ci rendiamo conto di quale sia la posta in gioco.
In comune tra Meloni e Takaichi c’è anche (o soprattutto) una impostazione valoriale di chiara matrice occidentale. Come potrà riflettersi sui dossier maggiormente delicati?
La visione geopolitica condivisa è quella al servizio di interessi nazionali, come è giusto che sia, ma anche di una visione comune dell’Occidente confrontato a sfide importanti come quella russa e quella cinese. Non è un caso che la difesa della libertà di navigazione nel Mar Cinese Meridionale, a fronte dei tentativi di Pechino di ostacolare traffici regolari con le sue ripetute manovre minacciose intorno a Taiwan, sia stata al centro dei colloqui. Quindi il viaggio è stato all’insegna della visione geopolitica, ma anche del pragmatismo, quello che ha posto in essere Giorgia Meloni come fattore di equilibrio nello scacchiere mediorientale, tra l’altro vicino a un nodo commerciale decisivo e delicatissimo come lo Stretto di Hormuz, oltre che vicino a importanti giacimenti energetici. In questo senso i colloqui molto buoni che ha avuto la presidente Meloni col sultano dell’Oman confortano la sua scelta di rivolgere questa attenzione speciale all’area del Golfo.
Si tende così a ridurre la vulnerabilità del sistema Italia a fronte degli scossoni diretti all’ economia mondiale sottoposta a varie crisi?
Diversificare le partnership e rafforzare il ruolo dell’Italia globale come principale collegamento tra l’Europa, il Golfo e l’Asia è il centro dell’azione del governo e di viaggi come questo, che mi pare il più rilevante in assoluto dall’inizio dell’esperienza di governo. Meloni ha compiuto tale missione stabilendo anche un rapporto personale con la sua omologa giapponese e per questo ha avuto un forte riscontro di apprezzamento a livello di opinione pubblica in Giappone. Aggiungerei l’aspetto delle alte tecnologie, su cui Corea del Sud e Giappone sono in prima fascia per quanto riguarda la produzione di semiconduttori di alto livello dopo Taiwan. Quindi anche sotto questo profilo sono sicuro che i colloqui avranno portato risultati importanti nella prospettiva di collaborazioni industriali. Si tratta quindi di tentativo, ben costruito e determinato, di ancorare l’Italia a reti geopolitiche e a reti economiche affidabili. Questo a tutto beneficio del nostro sistema Paese ma c’è stata anche, mi sembra, una dimensione valoriale perché nell’editoriale a firma congiunta si fa riferimento alla comune preoccupazione per un calo della natalità in Europa e in Giappone e alla volontà comune di aiutare le famiglie.
Altro elemento in evidenza, quello della diversificazione dei mercati in un momento in cui i dazi impattano sul libero commercio. Quali i vantaggi?
Credo che questa missione rifletta anche la volontà del governo italiano, proprio in questo particolare momento, di aprirsi nuovi mercati. Basti pensare a quello che abbiamo fatto dando l’approvazione al varo del Mercosur, ma anche il Piano Mattei per l’Africa rientra in questa volontà di aprirsi a nuovi mercati. Quindi direi una missione sfaccettata, con tanti tasselli operativi che sono degni di apprezzamento. E c’è un ruolo decisivo dell’Italian Japan Business Group, del gruppo di lavoro di Business Italia Giappone che già esiste da anni ma che certamente conoscerà un rilancio. Ma sul versante squisitamente giapponese c’è poi l’aspetto difesa. Italia e Giappone collaborano in questo aereo di ultima generazione, il Global Compact Air Program, insieme con il Regno Unito e sono tutti settori strategici. Questa bella combinazione di tradizione e innovazione mi sembra essere la cifra della missione che si sta ancora svolgendo, questa volta in un altro partner fondamentale per l’Italia che è la Corea del Sud.
Da sempre l’Italia ha fatto dell’export il principale strumento di politica estera. Che cosa sta cambiando adesso rispetto al recente passato?
Sta cambiando soprattutto questa instabilità nel mondo, che sta diventando sistemica. L’export prima era sempre fondamentale per la nostra economia, essendo la nostra economia di trasformazione, ma lo è ancor più adesso quando non ci sono più certezze sui mercati. Quindi una instabilità che da eccezione diventa regola impone la necessità di aprirsi a nuove formule di cooperazione economica e ad aree del mondo come quelle che ho citato, che magari in passato sono state date per acquisite o sono state anche abbastanza trascurate. Ecco perché ho citato il Mercosur, perché l’apertura al mercato latinoamericano per le nostre merci mi sembra un’ulteriore dimostrazione di questa necessità di essere più innovativi nel creare sbocchi.
Proprio ieri il governo ha presentato il piano per l’Artico: quali i possibili benefici e quali gli intrecci con i partner internazionali?
L’impegno italiano in Artico è basato su un mix strutturato di ricerca scientifica, sicurezza e alte tecnologie. Anche lì l’Italia è portatrice, per esempio in campo energetico, di avanguardia che la centralità crescente che sta acquisendo la regione artica potrebbe mettere nuovamente in evidenza, con reali possibilità di accrescere l’export verso Paesi i nostri partner, penso alla Danimarca, ma anche agli stessi Stati Uniti in aree di altissimo livello tecnologico fino ad ora trascurate proprio perché la situazione era stabile, diciamo congelata. In questo caso nell’Artico si stanno scongelando non solo i ghiacci, ma anche possibilità importanti per il nostro sistema imprenditoriale di prima fascia. In questo senso va valorizzato anche l’impegno del ministro degli esteri Antonio Tajani sui grandi temi della nostra politica estera.
Nella sede dell’ambasciata d’Italia a Tokyo la premier ha incontrato i vertici delle principali aziende giapponesi: 17 gruppi con un fatturato di oltre mille miliardi di euro. Che prospettive si aprono?
Quelle di una crescente credibilità dell’Italia sullo scenario internazionale, che sicuramente ci aiuterà sotto tanti profili, a cominciare da quello della sicurezza. Aggiungo il nostro ruolo apprezzato di stabilizzazione in regioni del mondo, ecco perché è stata registrata con attenzione da parte giapponese anche la disponibilità italiana ad inviare unità della nostra Marina per esercitazioni nell’area dell’Indopacifico. Tutto questo mi sembra positivo, soprattutto se legato alla volontà di tenere insieme i singoli teatri. Ormai non esiste più lo spazio come elemento discriminante tra i teatri e le aree di crisi, perché le catene si sono accorciate: penso all’Indo pacifico, al Mediterraneo dove l’Italia svolge un ruolo da sempre di primo piano, sono due aree che ormai potremmo definire contigue. Ecco perché si parla di Mediterraneo allargato che, a questo punto, arriva a lambire l’Indopacifico. Le sinergie tra esigenze delle nostre imprese, del nostro sistema Paese, esigenze securitarie ed esigenze di proiezione geopolitica ormai sono sempre crescenti in un momento in cui quello che conta è essere competitivi nelle alte tecnologie, avere accesso alle materie critiche necessarie per realizzare queste altre tecnologie e stabilizzare le aree dove i commerci possono essere disturbati per esempio nel Mar Rosso, dove abbiamo subito le azioni di disturbo degli Houthi, a partire dallo Yemen.
Dunque tutto questo come si tiene assieme?
Tramite un filo rosso che riflette una visione, a mio avviso, del nostro governo, della presidente Meloni, del ministro degli Esteri, e anche con la componente difesa egregiamente guidata dal ministro Crosetto e il ministero delle Imprese del ministro Urso per fare sistema. Ma con una visione non provinciale bensì aperta alle nuove sfide che la realtà internazionale, così frammentata, ci consegna. E a cui il governo sta rispondendo con pluralità.

La morte del 47enne Anton Panov, un impiegato dell’ambasciata russa a Nicosia, si sta trasformando in un thriller internazionale, sia perché l’uomo secondo la stampa locale e internazionale non era un semplice addetto diplomatico, sia perché Cipro assieme a Grecia e Israele ha da poco deciso di cambiare il proprio profilo militare e geopolitico, attirando varie attenzioni. Panov non è morto da solo, nelle stesse ore sull’isola è stato trovato senza vita l’oligarca del potassio Vladislav Baumgartner.
I fatti riportano che il corpo dell’uomo è stato rinvenuto lo scorso 12 gennaio, ufficialmente per suicidio. Su blog e siti però circolano varie ipotesi circa il destino dell’uomo che, sempre secondo alcune ricostruzioni, sarebbe un crittografo. Potrebbe essere stato vittima di una frode immobiliare oppure di un’azione di spionaggio? Le indagini proseguono in tutte le direzioni, anche perché il curriculum dell’uomo lo impone. Secondo quanto pubblicato da The Insider, Panov aveva prestato servizio nell’FSB e dell’SVR dopo aver studiato presso il dipartimento di Tecnologie dell’Informazione e Sistemi di Comunicazione Speciali presso la filiale dell’Accademia FSO nella città di Voronezh (al confine con l’Ucraina). Dopo la laurea e la specializzazione in crittografia, passò all’impiego presso il Centro di Controllo Nazionale dell’FSB “Atlas” e in seguito la promozione al ministero degli Esteri. Secondo fonti citate dal ministero russo, Panov sarebbe stato assunto al ministero degli Esteri in seguito alle azioni di Ilya Sosnovsky, assistente del leader del partito LDPR, Leonid Slutsky, noto per i suoi legami con i servizi segreti.
Si tratta della seconda morte sospetta in pochi giorni a Cipro: trovato senza vita anche l’oligarca russo di 56 anni Vladislav Baumgartner. Si tratta dell’ex Ceo di Uralkali, diventato famoso nel 2013, quando fu arrestato a Minsk per ordine del leader bielorusso Alexander Lukashenko durante la cosiddetta “guerra del potassio”. Era scomparso l’8 gennaio quando, in una zona marittima di Cipro, aveva praticato un’arrampicata su roccia nonostante forti venti. Ma il giorno della scomparsa di Baumgartner coincide anche con la morte Panov, che secondo gli investigatori, era collegato ai servizi di sicurezza.
C’è anche un terzo indizio: lo stesso giorno a Cipro è scoppiato uno scandalo di corruzione dopo la diffusione di un audio carpito in occasione di una riunione di alti funzionari che discutevano di piani di corruzione, tra cui l’aiuto ai russi per aggirare le sanzioni europee. Ciò ha causato le dimissioni del capo dell’amministrazione presidenziale di Cipro, Charalampos Charalambous.
La presenza russa Cipro non è una novità degli ultimi anni, ma una consuetudine sia alla luce della peculiare posizione geografica dell’isola (più vicina all’Anatolia che all’Europa), sia per via del volume di affari prodotto in loco tramite una serie di società, come emerso in occasione della crisi bancaria del 2013, causata dall’eccessiva esposizione delle banche cipriote ai titoli di stato greci e dall’afflusso di depositi esteri soprattutto russi. Ma dall’avvio della guerra in Ucraina, complice il rafforzamento delle relazioni tra Nicosia e Bruxelles, il sistema di alleanze cipriota ha mutato orizzonti, posizionandosi in linea con Israele e Grecia essenzialmente a causa del dossier energetico. Se i giacimenti presenti a Cipro fossero sfruttati si accelererebbe il processo di indipendenza energetica europea dall’energia russa. Un eventuale gasdotto verso l’Ue assieme al Tap già in funzione renderebbe l’Ue molto più stabile per l’approvvigionamento di gas.
Cosa c’entra l’energia con questa morte? In linea retta nulla, ma il tema della geopolitica è strettamente connesso alla presenza sull’isola di una intensa attività di intelligence da parte di potenze straniere. Nicosia infatti è player attivo su vari fronti: il gas, alla luce dei nuovi mega giacimenti scoperti; la difesa dal momento che stanno per iniziare i lavori della nuova base per sommergibili; la politica, per il 2026 è presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea, un ruolo chiave.
Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver accettato di ridurre al 15% i dazi doganali sui beni provenienti da Taiwan, in cambio di centinaia di miliardi di dollari di investimenti volti a incrementare la produzione nazionale di semiconduttori. Il dipartimento del Commercio ha fatto sapere giovedì che le aziende di semiconduttori e tecnologia dell’isola si sono impegnate in “nuovi investimenti diretti” per un valore monstre di almeno 250 miliardi di dollari, accompagnati da altri 250 miliardi in garanzie di credito. L’accordo prevede anche esenzioni dai dazi doganali per le aziende di semiconduttori taiwanesi che investono negli Stati Uniti.
L’incremento della produzione statunitense di chip semiconduttori, presenti in dispositivi che vanno dalle automobili agli smartphone, è una priorità per gli Stati Uniti, poiché le carenze durante la pandemia di Covid-19 hanno esposto i rischi della catena di approvvigionamento.
Il deal commerciale raggiunto questa settimana offre una fotografia nitida delle priorità strategiche di Washington nel 2026: l’economia prima della geopolitica, la sicurezza industriale come linguaggio indiretto della deterrenza. Il quadro include la creazione di poli industriali negli Stati Uniti, nuove regole tariffarie — con un tetto del 15% su componenti auto, legname e derivati del legno taiwanesi — e l’azzeramento dei dazi reciproci su una selezione di beni strategici, dai farmaci ai componenti aeronautici.
Il cuore dell’accordo riguarda i semiconduttori, con Taiwan Semiconductor Manufacturing Company — l’azienda leader globale dei chip — che diventa sempre uno dei nodi cruciali dell’economia globale, come dimostra il recente innalzamento del 5% del target price annunciato ds Morgan Stanley. Le future tariffe statunitensi premieranno le aziende taiwanesi che costruiranno capacità produttiva sul suolo americano, consentendo importazioni duty-free direttamente collegate a nuovi impianti negli Stati Uniti. Durante la fase di costruzione, le imprese potranno importare fino a 2,5 volte la capacità pianificata senza pagare dazi; una volta completati i progetti, resterà possibile importare fino a 1,5 volte la nuova produzione domestica senza tariffe. Una cornice che consolida e amplia investimenti già avviati, come quelli di Tsmc in Arizona, e che punta esplicitamente a invertire un trend storico: la quota americana della produzione globale di chip è scesa dal 37% nel 1990 a meno del 10% nel 2024.
Sul piano politico, l’intesa riflette fedelmente l’impostazione dell’amministrazione di Donald Trump nel 2026. Washington è concentrata sul riequilibrio commerciale e sulla sicurezza delle supply chain critiche, considerate ormai una componente della sicurezza nazionale. La visita di Stato di Trump a Pechino prevista per aprile e l’enfasi su accordi “America First” suggeriscono una strategia di de-escalation selettiva: evitare frizioni inutili su Taiwan che possano compromettere i negoziati economici con la Cina, senza però rinunciare a rafforzare — in modo meno visibile — i legami strutturali con Taipei.
In questo senso, il deal sui semiconduttori funziona come strumento di ambiguità strategica aggiornata. Non modifica formalmente la politica americana su Taiwan, ma consolida un’interdipendenza industriale che rafforza il valore strategico dell’isola per gli Stati Uniti e, allo stesso tempo, riduce la vulnerabilità americana a shock esterni.
Per Pechino, Taiwan resta un “core interest”. La pressione militare — incursioni nell’ADIZ, attività navali e grandi esercitazioni — è destinata a proseguire finché il costo internazionale resterà contenuto. Le manovre “Justice Mission 2025” di fine dicembre, con la simulazione di un blocco dei principali porti taiwanesi, hanno mostrato una capacità crescente di controllo dello spazio marittimo e aereo attorno all’isola. In parallelo, la leadership cinese continua a lavorare sul piano politico e narrativo, normalizzando l’idea di una riunificazione inevitabile e cercando impegni più espliciti — o quantomeno silenzi — da parte degli Stati Uniti e degli alleati regionali.
Da questa prospettiva, l’accordo commerciale non è visto come una provocazione diretta, ma parte di un approccio incrementale americano: rafforzare Taiwan senza trasformarla nel fulcro di uno scontro aperto che potrebbe ricompattare l’opposizione internazionale contro la Cina.
La cautela politica non equivale a disimpegno. Sul piano militare, Washington continua a rafforzare le capacità difensive taiwanesi. A dicembre, gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di vendite militari da 11 miliardi di dollari, portando il totale sotto l’amministrazione Trump a quasi 34 miliardi. Il Pentagono, nel suo ultimo rapporto sulla Cina, sottolinea che l’Esercito Popolare di Liberazione — il People’s Liberation Army — sta avanzando verso gli obiettivi fissati dal Partito per il 2027, inclusa la capacità di ottenere una “vittoria decisiva” su Taiwan e di controbilanciare gli Stati Uniti nei domini strategici. Attenzione: non significa che è partito il contro alla rovescia per il momento in cui Xi Jinping ordinerà un’invasione, ma il 2027 è la data in cui il leader cinese vuole aver raggiunto la prontezza operativa (implicito riconoscimento di non averla attualmente).
Qui emerge il paradosso: meno retorica politica, più sostanza strutturale. L’amministrazione Trump evita dichiarazioni che possano essere lette come un endorsement dell’indipendenza taiwanese, ma continua a investire nella deterrenza e nell’integrazione economica.
Per Taiwan, il messaggio è ambivalente. L’accordo commerciale rafforza indubbiamente l’indispensabile legame con Washington e amplia lo spazio di cooperazione in settori chiave — semiconduttori, AI, difesa, telecomunicazioni, biotecnologie — ma conferma anche che Taipei non può basarsi esclusivamente sulle priorità americane, soprattutto quando queste sono dominate dal commercio.
Da qui la pressione crescente perché l’isola rafforzi il consenso interno su spesa per la difesa, capacità asimmetriche, riserve e resilienza civile. Un’agenda che trova sostegno a Washington (e a Tokyo), ma che richiede leadership politica per superare divisioni interne ancora marcate.
L’intesa sui semiconduttori diventa quindi un segnale con un messaggio strategico calibrato: gli Stati Uniti scelgono di competere con la Cina sul terreno economico-industriale, riducendo la dipendenza critica e rafforzando Taiwan senza alzare il livello dello scontro politico. Per Pechino, è un promemoria che la pressione militare non ferma l’integrazione strutturale tra Washington e Taipei. Per Taiwan, è un’opportunità — e un avvertimento — su quanto conti, oggi più che mai, la capacità di reggersi anche sulle proprie forze.
Il primo appuntamento elettorale di questo 2026 è in Portogallo. Domenica 18 i cittadini sono convocati alle urne per scegliere il successore dell’attuale capo di Stato, Marcelo Rebelo de Sousa, in quelle che sono state definite le più contese elezioni del Portogallo dell’ultima decade. Il pareggio tecnico tra i candidati favoriti è quasi certo, per cui molto probabilmente si andrà al ballottaggio l’8 febbraio.
Sebbene in Portogallo il presidente non abbia funzioni esecutive, il suo ruolo di arbitro è molto importante. E, in questa occasione, il candidato di estrema destra, André Ventura, ha avvertito che in caso di vittoria sarà molto più attivo e interventista di quanto tradizionalmente lo è il presidente portoghese. Ha addirittura dichiarato che non si risparmierà nel prendere posizioni di opposizione al primo ministro, se così lo considera necessario.
Le probabilità che Ventura diventi capo dello Stato portoghese sono alte. Secondo gli ultimi sondaggi, di agenzie diverse, tra tutti gli undici candidati alla presidenza, Ventura è il favorito, anche se non è certo che vinca nel secondo turno.
Ma chi sono i candidati con più possibilità di trionfo? C’è, appunto, Ventura, leader del partito di estrema destra Chega. È giornalista, scrittore e opinionista sportivo. È stato persino in un seminario. La sua carriera politica è iniziata da poco, nel 2017, quando entrò nella lista locale del conservatore Partito Social Democrata a Loures, nella periferia di Lisbona. La sua campagna è stata segnata da un linguaggio xenofobo e provocatore contro gli zingari della zona.
In una biografia intitolata “Na cabeça de Ventura”, scritta da Vítor Matos, si legge che il neo-politico è riuscito a convincere gli astensionisti che erano stanchi del sistema e hanno visto in un uomo che ha il coraggio di dire quello che gli altri non dicono. Secondo l’autore, Ventura è un “opportunista”, con una carriera professionale indirizzata dal successo, la fama e il potere.
Come candidato c’è anche António José Seguro, ex segretario del Partito Socialista, considerato la speranza della sinistra. È professore di Teoria dello Stato e Pensiero Politico e Sociale all’Università Autonoma di Lisbona e quella sua vocazione da insegnante l’ha aiutato ad avvicinarsi molto agli elettori, specialmente quelli più giovani. Gli ultimi anni ha dedicato il suo tempo all’accademia e alla politica. È laureato in Relazioni Internazionali ed è entrato al Partito Socialista negli anni ‘90. È stato anche eurodeputato. Molti ricordano la sua opposizione alla legge di bilancio del 2012, durante gli anni della troika, per bloccare il taglio ad alcuni pagamenti extra di Natale e ferie per tutti i dipendenti.
Altri candidati sono l’ex ministro e opinionista politico conservatore Luís Marques Mendes, Henrique Gouveia e Melo e l’eurodeputato João Cotrim Figueiredo. L’unica donna candidata alla presidenza è l’eurodeputata Catarina Martins del Bloco de Esquerda. Ci sono anche il sindacalista André Pestana, il fondatore del partito dei ersi Livre Jorge Pinto; il leader comunista António Filipe; il pittore Humberto Correia e il musicista Manuel João Vieira, questi ultimi con molto meno consenso.
La campagna elettorale in Portogallo è stata segnata da due argomenti dell’agenda internazionale. Il primo, l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela e l’arresto del leader del regime, Nicolas Maduro. Nel Paese sudamericano, infatti, vive una grande comunità di portoghesi immigrati dopo la Seconda guerra mondiale e quello che accade in Venezuela tocca da vicino l’opinione pubblica. Molti considerano un eccesso l’azione americana, un attacco contro il diritto internazionale, ma è di un parere diverso il candidato Ventura.
L’altro argomento centrale del dibattito elettorale sono le condizioni del sistema sanitario pubblico. La morte di un uomo di 78 anni, nella zona metropolitana di Lisbona, che ha aspettato per più di tre ore l’arrivo di un’ambulanza, ha accesso la discussione sul deterioramento dell’assistenza medica.
Visualizza questo post su Instagram
Un post condiviso da André Claro Amaral Ventura (@andre_ventura_oficial)



La missione a Riad della viceministra dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava conferma la traiettoria seguita dall’Italia sui dossier aperti con il Golfo. A margine del Future Minerals Forum, Gava ha incontrato i parigrado sauditi dell’Energia, Mohammed Alibrahim e Nasser Al-Qahtani, rafforzando un dialogo centrato su sicurezza delle forniture, diversificazione e sviluppo di nuovi corridoi energetici.
Il confronto ha toccato dossier concreti: elettrodotti, idrogeno, ammoniaca e, soprattutto, il ruolo dei corridoi come architrave della cooperazione bilaterale. In questo quadro rientrano sia l’Imec sia il porto di Trieste, indicati da Gava alle controparti saudite come possibile punto di approdo europeo delle nuove direttrici energetiche e logistiche. Un’impostazione che riflette la lettura italiana della trasformazione geoeconomica in atto: una questione di resilienza strategica prima ancora che di sostenibilità.
La visita di Gava si inserisce in una relazione Italia–Arabia Saudita ormai strutturata. Il passaggio a Riad del ministro degli Esteri Antonio Tajani, due mesi fa, e l’intesa politica promossa sotto la guida della presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo scorso anno, hanno consolidato un partenariato che guarda a esattamente a quei temi: energia, infrastrutture e industria, insieme a sicurezza di un areale geostrategico condiviso, come elementi di una stessa strategia. Per Roma, Riad rappresenta un nodo centrale nei collegamenti tra Europa, Medio Oriente e Asia, in una fase di riorganizzazione delle catene globali del valore. E viceversa. Una relazione fondamentale in un momento in cui l’Ue cerca di strutturare il dialogo con la Regione del Golfo.
Il contesto del Future Minerals Forum (FMF) rafforza questa lettura. Inaugurata dal ministro saudita dell’Industria e delle Risorse minerarie, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, la quinta edizione del Forum ha segnato un ulteriore salto di qualità: da piattaforma di confronto a spazio orientato alla definizione di politiche, investimenti e strumenti operativi lungo l’intera catena del valore dei minerali. Il tema scelto, “Dawn of a Global Cause”, si lega direttamente alla volontà di fare del settore minerario uno dei pilastri della Vision 2030. La struttura del FMF 2026 — tavole rotonde ministeriali, workshop operativi, il lancio del Future Minerals Framework e del Future Minerals Barometer — rispecchia un approccio pragmatico, focalizzato sull’esecuzione. È lo stesso approccio che emerge dai colloqui condotti da Gava: corridoi, infrastrutture e tecnologie diventano strumenti per tradurre la transizione energetica in capacità industriale e sicurezza strategica.
Un ulteriore punto di convergenza italo-saudita emerso durante il forum riguarda l’Africa. Nel corso degli incontri, pubblici o riservati, è stato ribadito il ruolo centrale del continente nella transizione energetica globale, sia in termini di risorse minerarie sia di sviluppo delle filiere. La partecipazione di numerosi Paesi africani, dalla Nigeria alla Repubblica Democratica del Congo fino al Sudafrica, riflette questa priorità saudita. Per l’Italia, significa che la visione del regno può dialogare direttamente con il Piano Mattei, che punta a costruire anche partenariati energetici e industriali più equilibrati e di lungo periodo con l’Africa.
È in questo incrocio che la missione di Gava trova la sua coerenza strategica definitiva. I progetti energetici con l’Arabia Saudita, la centralità dei corridoi (su tutti Imec), l’attenzione ai minerali critici e il focus sull’Africa convergono in una stessa direzione: rafforzare il ruolo di Roma come piattaforma di connessione tra Europa, Medio Oriente e Sud del Mondo. Il passaggio a Riad conferma quindi una linea già tracciata, che mira a legare transizione energetica, politica industriale e proiezione geopolitica in un’unica architettura operativa.
(Foto: Future Minerals Forum 2026)

Le proteste scoppiate in Iran a partire dal 28 dicembre rappresentano, per dimensione e intensità, il più grave episodio di contestazione interna nei confronti della Repubblica Islamica dalla Rivoluzione del 1979. Una realtà che viene resa evidente da alcuni dei (pochi) dati disponibili, che delineano una crisi profonda nata da fattori prettamente economici ma rapidamente trasformatasi in una sfida politica diretta alla sopravvivenza del regime. Tali dati sono stati interpretati da Anthony Ruggiero, Sean Calabria e Rob Pierce, analisti e vicepresidenti della boutique di consulenza American Global Strategies, che sulla loro base hanno fornito una lettura della dinamica attualmente in corso nel Paese turanico.
L’innesco è stato il crollo del rial iraniano, accompagnato da una forte impennata dell’inflazione e dall’aumento dei prezzi di beni essenziali come cibo e carburante. In poche settimane, tuttavia, le rivendicazioni economiche hanno lasciato spazio a slogan e richieste esplicitamente politiche, tra cui la fine del sistema di governo clericale e la caduta della Guida Suprema Ali Khamenei. Sul piano territoriale, la mobilitazione ha raggiunto un’estensione senza precedenti. Le proteste hanno interessato tutte e 31 le province iraniane, coinvolgendo centinaia di città e centri minori. Le forme di protesta sono state molteplici: scioperi, manifestazioni di piazza, assalti a edifici governativi e atti simbolici come la distruzione e l’incendio di simboli del regime. Un livello di partecipazione che ha spinto le autorità a interpretare le manifestazioni come una minaccia esistenziale.
La risposta dello Stato si riflette in numeri altrettanto significativi. A partire dall’8 gennaio, il regime ha imposto un blackout quasi totale di internet e delle comunicazioni, con l’obiettivo di interrompere il coordinamento tra i manifestanti e limitare la diffusione di informazioni sulla repressione. Le forze di sicurezza, inclusi i Pasdaran, hanno fatto ricorso sistematico alla forza letale. Le stime più caute parlano di almeno 2.500 morti, mentre altre valutazioni indicano un numero di vittime che potrebbe superare le 12.000 persone. L’assenza di accesso indipendente al Paese e la censura rendono impossibile stabilire un bilancio definitivo.
Parallelamente, Teheran ha segnalato l’intenzione di avviare processi accelerati e di ricorrere alle esecuzioni nei confronti dei manifestanti arrestati, rafforzando il clima di deterrenza interna. Secondo le informazioni disponibili, la violenza della repressione ha avuto effetti tangibili sull’andamento delle proteste: per due notti consecutive non sono stati identificati nuovi focolai di manifestazione, un dato che appare strettamente legato al blackout informativo e alla difficoltà di organizzazione sul territorio.
Il quadro interno si intreccia con la pressione internazionale, in particolare quella degli Stati Uniti. L’amministrazione Trump ha minacciato conseguenze dirette in caso di ulteriori uccisioni di manifestanti e ha avviato misure di protezione delle proprie forze nella regione. Sul piano economico, il 12 gennaio il presidente ha annunciato l’intenzione di imporre una tariffa del 25% a qualsiasi Paese che continui a fare affari con l’Iran, mentre il 15 gennaio il Dipartimento del Tesoro statunitense ha colpito i responsabili della repressione e le reti finanziarie ombra dell’élite iraniana.
Dal punto di vista strategico, evidenziano gli analisti di Ags, le proteste arrivano in una fase di particolare vulnerabilità per Teheran, già indebolita dal collasso di Hezbollah, dalla caduta del regime di Assad in Siria, dalla rimozione di Maduro in Venezuela e dalla guerra di 12 giorni con Israele, che ha compromesso difese aeree, scorte missilistiche e infrastrutture chiave, oltre ai successivi attacchi statunitensi contro siti nucleari iraniani.
I dati suggeriscono che il destino del regime dipenda ora da una variabile centrale: la tenuta delle forze di sicurezza e la loro disponibilità a continuare a usare la forza letale contro una popolazione disarmata. Se le proteste resteranno soffocate e prive di coordinamento, il regime potrebbe guadagnare tempo. Al contrario, un intervento esterno o un improvviso venir meno della lealtà interna potrebbe riattivare la mobilitazione e rendere la sopravvivenza della Repubblica Islamica sempre più incerta. Difficile però prevedere se ci sarà, e di quale tipo, un intervento da parte delle potenze estere. Stati Uniti in primis.




Della guerra civile ibrida scatenata dal movimento Maga negli Stati Uniti possiamo ragionevolmente ipotizzare qualunque esito, tranne quello che porti a un onorevole compromesso, a mezza strada tra trumpismo e anti-trumpismo e da cui sortisca un’America pacificamente double face: un po’ meticcia e un po’ razzista, un po’ democratica e un po’ dispotica, un po’ libera e un po’ no, un po’ rule of law e un po’ rule of power.
Il mein kampf trumpiano ha obiettivi dichiarati e una strategia definita per vendicare il pervertimento dell’ideale e il tradimento del blut und boden americano. Anche quando sembra che deliri – e magari anche quando delira veramente – Donald Trump non esagera mai. Non dice mai niente di diverso da quello che farebbe, se potesse e niente di meno di ciò che comunque proverà a fare.
Non c’è nessuna differenza tra il suo programma e la sua propaganda, perché la sua propaganda è il suo programma, la sua violenza verbale è la violenza materiale dei suoi ordini e perfino la sua faccia si specchia in quella degli sgherri mandati a terrorizzare e a sparare in Minnesota e ovunque ci si ribelli alla voce del padrone.
Vuole la soluzione finale della questione occidentale, cioè dell’equivoco di quell’alleanza euro-atlantica, che assegnerebbe agli Usa più oneri che vantaggi, depredandola dei frutti della sua grandezza, a beneficio di alleati immeritevoli, meschini e parassitari.
Pretende la completa liberazione dalla schiavitù di quei feticci – lo stato di diritto, la società aperta, la divisione e limitazione dei poteri, la cooperazione internazionale – che debilitano o usurpano la potenza americana, imbrigliandola in una rete di doveri e divieti ingiustificati.
Esige di ripulire l’America di tutti gli immigrati, cittadini o non cittadini, che non siano discendenti o emuli degli immigrati originari o non ne accettino la primazia, secondo una logica di cui i trend demografici statunitensi (tra meno di vent’anni i bianchi non ispanici saranno meno del 50 per cento della popolazione) escludono nel medio periodo la stessa compatibilità con il principio democratico.
All’America Maga tutto ciò che è stato alla base dello straordinario successo americano – a partire dal controllo di tutti i driver tecnologici, economici e culturali dei mercati globali – appare come una minaccia mortale. E i satrapi digitali che surfano sulla cresta di quest’onda vandeana accarezzano il sogno di guadagnare dall’onnipotenza di un nuovo imperatore ciò che fino ad oggi hanno incassato dall’irresistibile soft power a stelle e strisce e da un ecosistema giuridico, economico e civile in via di completo smantellamento.
Certo in America ancora resiste, sempre più sgretolata o paralizzata, una resistenza istituzionale e sociale all’esercizio di un potere puramente autoritario, ma in un sistema di checks and balances concepito per prevenire gli abusi, non per neutralizzare un eversore alla Casa Bianca.
Gli Usa non sono solo il campo di battaglia della nuova guerra civile americana, ma anche della guerra civile dell’Occidente, di cui Trump vuole fare ciò che da più di dieci anni Putin prova a fare dell’Ucraina: una terra di manovra, di ventura e di conquista, una realtà politica da asservire e di cui distruggere l’identità morale, prima ancora di quella politica.
Anche nelle forme, la guerra ibrida trumpiana contro l’Occidente è a immagine e somiglianza di quella putiniana: non ha solo l’obiettivo di piegare le resistenze morali e materiali dell’aggredito, diffondendo terrore, confusione e sfiducia sulle reali possibilità di resistere alla soverchiante forza dell’aggressore, ma anche di giustificare l’aggressione come un atto di cui, secondo un vero criterio di giustizia, pure gli aggrediti dovrebbero riconoscere la legittimità o addirittura la necessità storica.
Oggi la Russia non ha solo l’obiettivo di ripristinare il Lebensraum post-sovietico e recuperare le posizioni perse dopo il crollo del Muro di Berlino, ma in primo luogo quello di persuadere l’opinione pubblica europea che questa pretesa ha un fondamento in una dottrina coerente con un sano principio di realtà e razionalità politica, da cui è lecito attendersi in termini di pace e prosperità molto più di quanto potrà mai assicurare agli Stati europei e ai suoi cittadini lo scontro con il Cremlino.
Allo stesso modo, Trump non vuole solo estendere la sovranità degli Usa ovunque arrivi il tiro dei suoi cannoni, ma vuole persuadere gli ex alleati occidentali che questa è per loro una migliore condizione di sicurezza, oltre che di più generosa benevolenza da parte dell’imperatore americano.
L'articolo Donald Trump vuole fare dell’Occidente quel che Putin vuole fare dell’Ucraina proviene da Linkiesta.it.

Negli Stati Uniti non passa giorno senza che si parli dell’Ice, l’agenzia federale per il controllo dell’immigrazione e delle frontiere (Immigration and Customs Enforcement). Se ne parla per i metodi violenti, per i rastrellamenti nelle città, per gli arresti e le espulsioni di migranti irregolari, per le campagne di reclutamento e per l’enorme budget a disposizione. Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca per un secondo mandato, un anno fa, l’Ice è diventata una presenza costante nel dibattito pubblico e nella cronaca quotidiana.
Il 2026 si è aperto con un caso che ha acceso proteste e polemiche in tutto il Paese: l’omicidio a Minneapolis, in Minnesota, di Renee Nicole Good, uccisa da un agente durante un’operazione in strada. Secondo la versione ufficiale dell’agenzia, Good avrebbe tentato di investire l’agente con la sua auto, costringendolo a sparare per legittima difesa. Ma questa ricostruzione è stata contestata dai testimoni e smentita anche da diversi video.
Prima ancora che emergessero elementi incriminanti, l’amministrazione Trump è corsa a difendere l’agente. Il presidente e la sua cerchia ristretta hanno descritto la vittima come una criminale e l’agente come un eroe, ribadendo che l’uso della forza era giustificato. La medaglia per la dichiarazione più inquietante l’ha vinta il vicepresidente J.D. Vance, il quale ha assicurato che l’agente gode di «immunità assoluta» per aver «semplicemente fatto il suo lavoro». Ma tutto il Dipartimento per la Homeland Security (la Sicurezza Interna) ha fatto quadrato promettendo agli agenti che nessuna autorità locale, statale o politica potrà impedirgli di svolgere i loro compiti.
È in questo contesto di totale legittimazione politica che bisogna leggere anche le recenti iniziative dell’Ice, non solo nelle operazioni di polizia, ma nella più ampia strategia di reclutamento e mobilitazione.
Lo scorso 3 gennaio, mentre il mondo guardava l’incursione degli Stati Uniti in Venezuela, l’Ice annunciava di aver reclutato più di dodicimila nuovi agenti in poco meno di un anno. «Con questi nuovi patrioti nel team, saremo in grado di realizzare ciò che molti considerano impossibile e di mantenere la promessa del presidente Trump di rendere l’America di nuovo sicura», ha scritto il Dipartimento della Homeland Security nel suo comunicato. È un aumento del centoventi per cento della forza lavoro totale dell’agenzia. Una crescita smisurata e senza precedenti. Peraltro condizionata da grossi incentivi: i nuovi contratti prevedono un bonus di cinquantamila dollari alla firma e fino a sessantamila dollari per ripagare i debiti studenteschi.
Per trovare nuovi agenti, l’Ice ha abbassato le barriere all’ingresso: ha aumentato l’età massima per fare richiesta, ha tagliato i tempi di addestramento da tredici a otto settimane, e le nuove reclute vengono subito portate in strada anche se non hanno ricevuto una formazione adeguata. Eppure si tratta di un’agenzia che fornisce ai propri dipendenti maschere, equipaggiamento antisommossa e pistole semiautomatiche SIG Sauer P320 (ma presto inizieranno a equipaggiare delle Glock 19). Non è materiale da affidare a chiunque.
Nei post diffusi sui social per il reclutamento l’enfasi va proprio sulla semplicità con cui un cittadino americano può entrare nell’Ice. «Servite il vostro Paese! Difendete la vostra cultura! Non è richiesta una laurea triennale!», scrive un utente nei commenti al post su X.
Non è escluso che una campagna di assunzione così massiccia e rapida abbia portato nell’agenzia rappresentanti di gruppi suprematisti e neonazisti che gravitano attorno al movimento Make America Great Again a sostegno di Trump. Da giorni i Democratici interrogano Kristi Noem, Segretaria per la Homeland Security, su quanti dei nuovi volti dell’Ice abbiano ricevuto la grazia da Trump un anno fa – quasi tutti condannati per l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Per ora non c’è mai stata una risposta chiara.

L’Ice ha moltiplicato le sue attività nell’ultimo anno grazie a uno stanziamento di fondi fuori scala rispetto alle altre agenzie federali. Il bilancio annuale dell’Ice è di una decina di miliardi di dollari, a cui però si sono aggiunti i settantacinque miliardi in quattro anni (su un totale di 165 destinati a tutto il Dipartimento della Homeland Security) del “One Big Beautiful Bill”. Così è diventata l’agenzia più ricca degli Stati Uniti, più dell’Fbi o della Dea, con un budget annuale totale di circa 27,7 miliardi di dollari.
Di quei settantacinque miliardi stanziati, quarantacinque sono destinati a creare centri di detenzione per aggiungere ottantamila nuovi posti. I restanti trenta miliardi servono per le assunzioni, le operazioni di espulsione e all’ammodernamento delle strutture e delle tecnologie informatiche.
L’Immigration and Customs Enforcement è un’agenzia giovane. È nata nel 2003 per svolgere indagini legate al terrorismo e alla criminalità transnazionale. Solo col tempo il suo baricentro si è spostata verso l’immigrazione irregolare, fino a diventare progressivamente lo strumento operativo privilegiato delle politiche di espulsione. Ma non era mai stata al centro della scena politica.
Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, l’Ice ha assunto un protagonismo inedito. Nel 2025, secondo i dati diffusi dall’amministrazione, cinquecentomila persone sono state espulse dal Paese – e i numeri reali potrebbero essere anche più alti.
A colpire l’opinione pubblica è la brutalità di certe operazioni. Rastrellamenti urbani, arresti sul luogo di lavoro, retate in scuole e chiese, persone ammanettate in strada. In alcuni casi sono stati fermati per errore anche cittadini statunitensi. Guardando foto e video dell’Ice in servizio sembra di assistere a scene di guerriglia urbana. Con gruppi di uomini armati in giro per le strade, apparentemente senza regole da rispettare. Solo un’eccessiva libertà di azione su mandato diretto del presidente.

Formalmente l’Ice resta vincolata a linee guida che prescrivono l’uso minimo della forza e la de-escalation. Ma nella pratica, come dimostrano episodi come quello di Minneapolis, il messaggio politico che arriva dall’alto va in direzione opposta. Le inchieste giudiziarie faticano a tenere il passo delle operazioni, i ricorsi legali sono limitati, e diversi Stati federali hanno iniziato a contestare in tribunale la presenza massiccia di agenti sui loro territori, denunciandone l’incostituzionalità. È il segno di una frattura ormai aperta tra il potere centrale e le autorità locali.
Donald Trump sta costruendo una forza che risponde prima di tutto a lui e ai suoi collaboratori più fedeli. Nell’ultimo anno, l’Ice è sembrata sempre meno a un’agenzia federale tradizionale e sempre più una formazione paramilitare politicizzata. Non è una definizione folkloristica: l’Ice si comporta un apparato armato e finanziato ben più del dovuto, legittimato a operare in modo preventivo contro i nemici politici del presidente, protetto dall’alto da una promessa di immunità.
Sono i metodi dei peggiori regimi del pianeta. L’uso della forza come routine amministrativa, abusi di potere difesi pubblicamente dalla politica, perfino le vittime innocenti come Renee Nicole Good vengono delegittimate e screditate. È una strategia del terrore, rivolta non solo agli immigrati ma all’intera società americana sull’orlo di una guerra civile.
A questo punto non è escluso che Trump stia preparando il terreno anche in vista delle prossime scadenze elettorali. Ha già evocato l’uso massiccio delle forze federali in contesti di protesta e disordine, e pochi giorni fa ha lasciato intendere che se fosse per lui non ci sarebbero le elezioni di midterm. Forse l’Ice ha non è più soltanto la polizia dell’immigrazione, è il volto di un’America più dura, più militarizzata, e sempre meno democratica.
L'articolo La brutale polizia anti immigrazione è il vero volto dell’America di Trump proviene da Linkiesta.it.

Con la conclusione della breve tappa in Oman, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prosegue il proprio viaggio verso l’Asia, dove ha già incontrato il primo ministro giapponese Sanae Takaichi e incontrerà nei prossimi giorni il Presidente della Repubblica di Corea Lee Jae-myung. Il viaggio, seppur rilevante per l’Italia, si inserisce in un quadro complesso, segnato dai negoziati tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, nonché dalle tensioni generate da Washington sulla Groenlandia. Anche per questo motivo, la missione asiatica si è concentrata su Giappone e Corea del Sud, Paesi con cui Roma intrattiene rilevanti interessi in materia di sicurezza economica e di sviluppo delle relazioni diplomatiche e strategiche.
Protagonista di questo viaggio appare il Giappone. I festeggiamenti per il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra il Kantei e Palazzo Chigi rappresentano un’occasione per Meloni per consolidare i rapporti con Takaichi, alla luce delle loro affinità politiche e del fatto di essere entrambe le prime donne a capo dei rispettivi governi. Ma non solo. In tale ottica, si punta al rafforzamento dei settori coinvolti all’interno del Programma d’Azione Italia-Giappone 2024-2027, firmato insieme al precedente governo Kishida, che vede i due Paesi collaborare in diversi ambiti, tra cui quelli diplomatico, securitario ed economico, sui quali è probabile Meloni concentri il suo impegno.
Riguardo la diplomazia, Roma e Tokyo intendono rafforzare i rapporti bilaterali a livello di “partenariato strategico speciale”, adottando meccanismi di consultazione attraverso la creazione di strumenti dedicati e interni ai propri ministeri degli Esteri.
Di particolare interesse risulta inoltre una possibile sinergia tra il Ticad (Tokyo International Conference on African Development) e il Piano Mattei nello sviluppo del settore dei metalli critici nei Paesi africani coinvolti, al fine di diversificare le forniture e le catene di approvvigionamento. Non a caso, la sicurezza economica — illustrata da programmi quali l’MSP (Minerals Security Partnership) e il RISE (Resilient and Inclusive Supply-chain Enhancement), sostenuti dai due Paesi — e il consolidamento dell’interscambio tra Roma e Tokyo sono divenuti sempre più centrali, tanto che nel 2025 quest’ultimo ha raggiunto i 10,4 miliardi di euro, soprattutto nell’ambito del lusso, della moda e dei beni di alta gamma. Il viaggio ha infatti l’obiettivo di rafforzare la presenza italiana in Giappone, in particolare attraverso la promozione dell’IJBG (Italy-Japan Business Group) e di joint venture nei campi dell’alta tecnologia e dell’industria ad elevato valore aggiunto, nonché di attrarre investimenti nipponici in Italia mediante la collaborazione tra Jetro (Japan External Trade Organization) e ITA (Italian Trade Agency). Meloni, a tale riguardo, ha in programma un incontro presso l’ambasciata italiana a Tokyo con alcune importanti aziende e banche giapponesi, al fine di incentivare un incremento degli investimenti verso il nostro Paese.
A ciò si aggiungono, infine, gli accordi nella sfera della difesa. Oltre al Global Combat Air Programme (Gcap) per lo sviluppo di velivoli stealth di sesta generazione, il Piano d’Azione 2024-2027 prevede altresì esercitazioni militari congiunte tra le Forze di Autodifesa giapponesi e l’Esercito italiano, nonché corsi di addestramento tra le forze aeree tramite l’International Flight Training School di Leonardo. Contatti che, con l’inaugurazione del EU-Japan Defence Industry Dialogue nel giugno 2025, potrebbero posizionare Roma in un contesto di primo piano nella partnership tra Bruxelles Tokyo in materia di sicurezza e difesa.
Incoraggiare nuovi accordi e intese sarà verosimilmente l’obiettivo di Meloni anche in Corea del Sud, dove è previsto il suo arrivo il 18 gennaio. L’Italia è il terzo esportatore verso la Corea del Sud, dopo Germania e Francia, mentre Seul rappresenta il terzo mercato di sbocco per i prodotti italiani dopo Cina e Giappone, con oltre 120 imprese attive nella moda, nella manifattura, nei trasporti e nella logistica. Con il presidente Lee, Meloni ha in programma, oltre a vari colloqui, la firma di atti di cooperazione nel mercato dei semiconduttori e di partenariati nell’economia tecnologica, nonché alcuni memorandum relativi a interscambi culturali e a iniziative per la difesa ambientale.
Il viaggio di Giorgia Meloni in Giappone e Corea del Sud si configura dunque come un tassello significativo della strategia italiana nel Pacifico. Attraverso il rafforzamento di alleanze strategiche, la diversificazione delle catene di approvvigionamento, la cooperazione tecnologica e gli accordi in ambito difensivo, Palazzo Chigi mira a consolidare il proprio ruolo di attore affidabile nello scacchiere indo-pacifico al fianco di Washington, riducendo progressivamente i rapporti con Pechino nei settori più sensibili. La missione asiatica non rappresenta quindi solo un’opportunità economica, ma anche una scelta che segnala la volontà di Roma di assumere un profilo attivo nelle dinamiche di sicurezza, sviluppo e collaborazione regionale.

Militarmente sbilanciato sull’America latina, Donald Trump continua ad assistere, senza potere intervenire efficacemente, alla macelleria iraniana di decine di migliaia di studenti e di cittadini che protestano contro il regime degli ayatollah. Una tragedia infinita che ha trasformato l’Iran in un immenso campo di sterminio a cielo aperto. Ed è l’immagine riflessa del colossale ingorgo di iniziative planetarie del tycoon: i dazi, Gaza, Ucraina, Venezuela, Groenlandia, Iran, Nigeria, attacchi fratricidi ad Europa, Nato e Canada, licenziamento su due piedi di procuratori e alti funzionari statali, Guardia Nazionale nelle metropoli americane, caccia ai clandestini, contro attacco ai democratici e posizione equivoca nel caso del pedofilo Epstein e da penultima la delirante messa in stato d’accusa del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, sono soltanto alcune delle quotidiane mattane scatenate da Trump.
Un risiko di sfide e di interventi contraddittori, interni ed internazionali, che sta destabilizzando il ruolo cardine degli Stati Uniti fra i paesi occidentali e spingendo al limite del collasso l’economia americana. In particolare una convulsa nebulosa di crisi militari impossibili da risolvere contemporaneamente, perché, come si sta constatando sulla pelle del popolo iraniano, neanche la superpotenza militare Usa può fronteggiare simultaneamente tante emergenze critiche. A meno di non rischiare un disastro come quello del fallito tentativo nel 1980 da parte del presidente Jimmy Carter di liberare i diplomatici americani tenuti in ostaggio a Teheran. Un fallimento, con 8 soldati americani morti nel deserto iraniano, che costò a Carter la rielezione.
Sul delicato scacchiere dell’economia mondiale l’imprevedibile tsunami del secondo mandato del 47° Presidente degli Stati Uniti sta provocando quello che il Financial Times sintetizza con il titolo: “Trump sta facendo innamorare il mondo della Cina”. Dazi, frizzi e lazzi del tycoon, evidenzia il quotidiano economico britannico, spingono i leader e le economie occidentali alla corte di Xi Jinping, di gran lunga il più saggio e astuto per biografia e esperienza politica, fra i vertici della cosiddetta trinità delle superpotenze.
Dopo il presidente francese Macron, la presidente della Commissione Europea von der Leyen, il Premier inglese Starmer, il Cancelliere tedesco Merz e perfino l’ex arcinemico cinese, il presidente della Corea del Sud Lee Jae Myung, si è recato a Pechino anche il Premier canadese Mark Carney.
“I rapporti con la Cina sono più prevedibili di quelli con gli Usa” ha affermato il Primo ministro canadese, reduce dagli scontri verbali con Trump, annunciando l’import fino a 49.000 veicoli elettrici cinesi a tariffe doganali agevolate del 6,1%. Un’exploit che abolisce il bando imposto dagli Usa sull’import dell’automotive cinese.
E non é tutto: nei quattro giorni di visita in Cina, Carney ha sottolineato che nell’ambito di un accordo che promette molto di più per il Canada, l’obiettivo é quello di far tornare le relazioni bilaterali ai livelli pre-frizioni commerciali avute negli ultimi anni. “I Paesi che un tempo consideravano il successo americano come proprio”, commenta il Financial Times, “ora vedono gli Stati Uniti come un avversario e Pechino come un modello”. Economicamente, per la Casa Bianca l’accordo, definito storico, fra Canada e Cina per eliminare le barriere commerciali e ridurre i dazi, rappresenta un duro colpo, ma non l’unico. “Il mondo”, conclude il Financial Times, “non é rimasto per niente impressionato dalla furia tariffaria di Trump. Ciò che ha colpito la gente é stato il successo della Cina nel reagire. L’America ha dimostrato una potenza militare sbalorditiva in Venezuela, ma era anche prevedibile. Ciò che la gente ha notato é il fallimento militare della Russia in Ucraina.”
Tutto il contrario della politica di Trump, che continua inspiegabilmente a corteggiare Putin e a maramaldeggiare con i dittatori di paesi corrotti del livello di Maduro, ma tergiversa di fronte all’irriducibile fanatismo dei pasdaran, fidandosi, quel che é peggio, dell’assicurazione di Khamanei di non impiccare più i manifestanti in rivolta. “Tanto non sopravviveranno alle torture”, é il retropensiero che si legge nel ghigno del sanguinario ayatollah.
Il raid culminato con la cattura del (ormai ex) presidente venezuelano Nicolas Maduro non ha posto fine alle tensioni legate al Paese del Sud America. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno sequestrato una sesta petroliera collegata al Venezuela nel Mar dei Caraibi, nel quadro di una più ampia operazione volta a controllare e limitare le esportazioni di greggio venezuelano. Secondo quanto dichiarato dal Comando Sud delle forze armate statunitensi, la petroliera stava violando la “quarantena delle navi sanzionate” imposta dal presidente Donald Trump. “L’unico petrolio che lascerà il Venezuela sarà quello coordinato in modo corretto e legale”, ha affermato lo Us Southern Command, che ha diffuso anche un video dell’operazione, mostrando marines e marinai salire a bordo della nave.
Il sequestro arriva in un momento di profonda riorganizzazione del settore energetico venezuelano, dopo le recenti operazioni militari statunitensi nel Paese e la cattura di Maduro. Trump ha dichiarato l’intenzione di sfruttare le vaste riserve petrolifere del Venezuela e, secondo quanto riferito da un funzionario americano, gli Stati Uniti hanno completato la loro prima vendita di petrolio venezuelano, per un valore stimato di 500 milioni di dollari. Parallelamente, il blocco navale ha avuto un impatto significativo sulle esportazioni venezuelane. Secondo Matt Smith, responsabile dell’analisi statunitense presso la società Kpler, i carichi di greggio sono diminuiti più o meno della metà nel corso del mese, scendendo a circa 400.000 barili al giorno. Al momento, solo le navi legate a Chevron e dirette verso gli Stati Uniti continuano a operare regolarmente.
La Veronica è una petroliera di piccole dimensioni battente bandiera guyanese che, secondo i registri dell’Organizzazione Marittima Internazionale, in passato era stata registrata in Russia con altri nomi. La nave farebbe parte di un gruppo di circa 17 petroliere che avrebbero tentato di violare il blocco navale all’inizio del mese. Resta poco chiaro perché le unità della “flotta ombra” continuino a esporsi al rischio di sequestro, ma un fattore determinante sarebbe rappresentato dai costi economici dei ritardi: ogni giorno di inattività comporta perdite finanziarie significative. Il blocco imposto dagli Stati Uniti ha inoltre creato un collo di bottiglia nelle forniture, impedendo al petrolio venezuelano di raggiungere i mercati di destinazione, in particolare quello cinese. Allo stesso tempo, emergono segnali di adattamento, con alcune petroliere ora dirette verso le Bahamas per operazioni di stoccaggio.
Il sequestro della Veronica è avvenuto poche ore prima di un incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado. Trump l’ha in passato definita una “combattente per la libertà”, ma ha escluso la possibilità di affidarle la guida del Paese dopo la rimozione di Maduro, sostenendo che non goda di un sostegno interno sufficiente. Il presidente statunitense ha invece appoggiato Delcy Rodríguez, ex-vicepresidente di Maduro, come presidente ad interim, definendola un’“alleata” e lodandone la cooperazione con Washington. Secondo la Casa Bianca, Rodríguez avrebbe svolto un ruolo chiave nell’accordo energetico da 500 milioni di dollari e avrebbe confermato l’impegno del governo ad interim a rilasciare prigionieri politici. La portavoce Karoline Leavitt ha inoltre ricordato che cinque cittadini statunitensi sono stati liberati recentemente. “Il presidente apprezza ciò che sta vedendo e si aspetta che questa cooperazione continui”, ha dichiarato la portavoce.
Non solo nuove rotte commerciali nate dal progressivo scioglimento dei ghiacci. L’Artico è tanto altro e il governo Meloni da tempo lo ha messo nel mirino come obiettivo programmatico per una serie di ragioni. In primis la collaborazione in loco con le agenzie internazionali e l’Ue, in secondo luogo per tracciare una nuova linea che da quel quadrante giunga nel Mare Nostrum e infine per ribadire che nei tavoli internazionali che contano Roma è presente. Materie prime, scambi, relazioni fra nuovi e vecchi alleati sono gli elementi prismatici che in quel fazzoletto di ghiaccio si confronteranno.
Rafforzare lo status dell’Italia nell’Artico, consolidare il diritto internazionale, preservare l’ambiente unico dell’area e le attività umane presenti, garantire il coinvolgimento dell’Unione Europea in loco nella consapevolezza che l’Artico è anche un territorio europeo e che il cosiddetto asse Nord-Sud che va dall’Artico al Mediterraneo è una sorta di polizza assicurativa per l’unità del vecchio continente. Il piano la “Politica Artica Italiana. L’Italia e l’Artico: i valori della cooperazione in una regione in rapida trasformazione”, documento programmatico presentato oggi dal governo, è una vera e propria cartina di tornasole per analizzare lo status quo dell’Artico, immaginare proiezioni lungimiranti e definire un percorso progettuale che possa portare ad una serie di risultati grazie al rafforzamento dell’impegno italiano nella regione. Durante la cerimonia di presentazione a Palazzo Madama è stato dato ampio risalto alla fase progettuale comune fra tre ministeri, Esteri, Difesa e Università con il comun denominatore rappresentato dal ruolo dell’Italia, ovvero “un attore influente e dinamico nella ricerca scientifica artica internazionale”.
Nell’Artico la parola d’ordine sarà gioco di squadra, dal momento che il lavoro degli scienziati italiani sarà intrecciato al canovaccio internazionale collaborando con le istituzioni di altri Paesi operanti nella regione. Per cui sul piano scientifico i soggetti attivi e operativi sono l’International Arctic Science Committee (IASC), l’European Polar Board (EPB), il Sustaining Arctic Observation Network (SAON) e l’Arctic Science Funders Forum (ASFF). Accanto all’azione pratica ci sarà la traccia di natura economica, sui cui il piano dell’Italia riconosce fattivamente “l’importanza dell’inclusione delle popolazioni indigene, promuovendo uno sviluppo rispettoso di un ambiente delicato”. Roma ritiene l’Artico “una delle aree di maggiore interesse per una concreta applicazione tecnologica dei principi dello sviluppo sostenibile”. Per questa ragione nel documento si ribadisce che “l’integrazione del continente europeo riguarderà anche il rafforzamento dell’asse nord-sud dall’Artico al Mediterraneo” e che “i valori della cooperazione internazionale in Artico rimangono centrali per affrontare sfide complesse attraverso il dialogo tra gli Stati ed un multilateralismo attivo”.
“Siamo disponibili, come abbiamo fatto finora, a impegnarci come difesa perché l’asse della difesa è fondamentale per il supporto su cui fare ricerca, diplomazia ed è il basamento su cui il Paese si presenta e ci consente di far parte di consessi internazionali – ha spiegato il ministro della Difesa Guido Crosetto – In quella zona che è la terra di nessuno occorre che ci sia qualcuno che costruisca delle regole”. E ha aggiunto un elemento di prospettiva: “La difesa avrà nei prossimi anni, per gli impegni internazionali che ci siamo assunti, la necessità di avere un aumento del suo budget, un incremento. Considero l’incremento del Budget della difesa un incremento del budget a disposizione del Paese: quindi della ricerca, della diplomazia, della capacità nostra di proiezione all’estero del Paese, non soltanto della parte militare. E l’Artico sarà uno dei luoghi insieme allo spazio, insieme ai fondali marini, insieme all’Africa dove noi dovremmo fare sinergia e concentrarci, perché da questi settori da questi nuovi orizzonti dipenderà gran parte del futuro non più nostro ma dei nostri figli”.
Secondo il ministro degli esteri Antonio Tajani l’Artico è una regione sempre più strategica per gli interessi politici, economici e scientifici italiani. “Con questa Strategia, l’Italia si dota di una visione di sistema e di lungo periodo. Vogliamo approfondire le relazioni con i Paesi artici, contribuire alla sicurezza euro-atlantica, rafforzare i programmi di ricerca e promuovere nuove opportunità economiche per le nostre imprese. Ho quindi deciso – ha proseguito – di istituire un tavolo imprenditoriale dedicato all’Artico con le aziende italiane in settori chiave come difesa, energia, ambiente, spazio, anche in vista di una prossima missione di sistema nella regione”.
Rispetto all’Artico non siamo all’anno zero, ha precisato la ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, “ma continuiamo un lavoro iniziato 50 anni fa da protagonisti nel mondo Artico, Antartico e Terzo polo stimolando connessioni e sinergie capaci di esplorare la nascita del nostro futuro. Per cui ecco che la ricerca anche nell’Artico avrà un ruolo primario: “Si fa con navi di ricerca oceanografiche civili e militari ma anche dall’alto tramite satelliti e droni, anche militari” che guardano anche a “sicurezza, difesa e commercio. Ciò che succede nell’Artico non riguarda solo l’Artico ma il mondo”.

New Delhi – Il Vinitaly India Roadshow 2026 prende il via da New Delhi dentro una cornice ampia: il vino e la sua filiera come fattore strutturale di soft power per un Paese storicamente vitivinicolo come l’Italia, primo produttore mondiale, che trova nel settore agrifood uno degli elementi di proiezione e riconoscibilità internazionale. È in questo quadro che si inserisce l’attenzione crescente verso l’India, mercato ancora giovane ma sempre più rilevante, sia per il numero dei consumatori coinvolti, sia nel contesto più specifico del rafforzamento dei rapporti tra Roma e New Delhi osservato negli ultimi tre anni.
I numeri aiutano a inquadrare la dimensione del fenomeno: nel 2023 il valore dell’import di vino in India è stato pari a 30,5 milioni di dollari, secondo l’Osservatorio Uiv–Vinitaly, una quota limitata nel commercio mondiale, ma accompagnata da un tasso di crescita medio annuo del 12% (al netto della parentesi Covid). In questo scenario l’Italia cresce al 14%, sopra la media del mercato.
È su questo scarto – tra dimensione ridotta e potenziale – che si innesta il Roadshow organizzato da Veronafiere con l’Italian Trade Agency e la collaborazione dell’ambasciata italiana in India, guidata da Antonio Bartoli. Alla tappa indiana – parte di un percorso di internazionalizzazione intrapreso da Vinitaly – partecipano oltre 30 aziende: 8 nella collettiva ITA, 9 del Consorzio Tutela Vini Valpolicella e 13 in forma diretta. L’obiettivo operativo è incontrare più di 200 importatori, distributori e operatori Horeca, ma anche selezionare buyer da invitare alla prossima edizione di Vinitaly (a Verona, dal 12 al 15 aprile 2026).
La cornice, però, è più ampia del business immediato. “Il vino non è soltanto un elemento commerciale, ma certamente un vettore di relazioni culturali, dunque internazionali, e possiamo tranquillamente parlare di diplomazia del vino”, spiega Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere. “Negli ultimi anni Vinitaly si è evoluto da marketplace di domanda e offerta in una piattaforma che unisce produttori, territori, filiere commerciali e istituzioni nazionali: da qui lo spirito di spingerci oltre, verso una dimensione sempre più internazionale”.
È una trasformazione che riflette un cambiamento di contesto. “Abbiamo sempre più caratterizzato Vinitaly come uno spazio in cui il mondo del vino dialoga con le istituzioni”, osserva Rebughini, richiamando l’esperienza dell’ultimo Vinitaly a Verona, con la partecipazione di due commissari europei impegnati su temi che vanno oltre l’acquisto del prodotto: salute, agricoltura, economia circolare, indotto. “Il vino diventa una chiave per leggere relazioni economiche più complesse”. E in un momento in cui economia e geopolitica sono sempre più interconnesse, anche il vino finisce all’interno di questo schema.
L’India rientra in questa logica come mercato giovane, ma geopoliticamente centrale. “Questa è la nostra quarta missione nel Paese”, racconta Rebughini: “Abbiamo preceduto le tappe di Delhi e Goa con una serie di preview per preparare il mercato e accompagnare un avvicinamento più strutturato”. Un processo che, secondo il direttore generale, si inserisce nel quadro dei negoziati per l’accordo di libero scambio Ue–India. “L’FTA è un fattore di fluidificazione”, afferma Rebughini: “Ridurre barriere tariffarie e fiscali è decisivo, e la firma del 27 gennaio sull’accordo sarà fondamentale per i nostri e molti altri prodotti”.
Ma c’è di più della dimensione economica-commerciale. “Noi siamo qui anche e soprattutto per fare cultura del vino. Rappresentare l’eccellenza del Made in Italy significa raccontare i territori, la diversità produttiva, la più ampia al mondo, e creare un collegamento stabile tra produzione e territorio”. Da qui l’investimento su formazione e masterclass calibrate su un mercato “ad alto potenziale, ma non ancora sofisticato”, e sullo sviluppo dell’enoturismo attraverso Vinitaly Tourism.
I numeri globali spiegano il razionale di lungo periodo. Secondo IWSR, il valore del vino al consumo in India supera oggi i 415 milioni di dollari e dovrebbe oltrepassare i 520 milioni entro il 2028. L’Italia è oggi il quarto fornitore, dietro Australia, Francia e Singapore, ma con dinamiche di crescita tra le più elevate.
Il Roadshow di New Delhi è entrato nel vivo oggi, 16 gennaio al Taj Palace, con incontri B2B, degustazioni e due masterclass: una dedicata allo spettro produttivo italiano – dal Prosecco alle varietà autoctone – e una ai grandi territori del rosso. A guidarle è Sonal C. Holland, prima e unica Master of Wine indiana. La tappa si chiude con una cena all’Ambasciata d’Italia. Il 18 gennaio il format si sposta a Goa, prima di proseguire il calendario estero 2026 in Norvegia, Polonia e Cina.
Sul fondo resta una considerazione chiave: in India il vino non è ancora un mercato di volumi, ma è già uno strumento di posizionamento. Una leva leggera, ma coerente, che accompagna la più ampia strategia italiana di presenza economica, culturale e diplomatica nel subcontinente. Una presenza che proiettata sul versante indiano segna l’asse dell’Indo-Mediterraneo, marcato da progetti futuristici come Imec così come da iniziative di ricostruzione storica come il viaggio della INSV Kaundinya, riproduzione delle antiche navi indiane del V Secolo, arrivata in Oman, appena visitato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni come prima tappa del tour asiatico che la sta portando in Giappone e Corea del Sud.
L’Europa appare più distante dagli Stati Uniti, meno fiduciosa nel futuro e sempre più consapevole di trovarsi in un mondo che non è più a guida occidentale. La leadership americana è percepita come meno affidabile, l’ascesa della Cina come inevitabile e l’Unione europea come strategicamente fragile, chiamata a farsi carico in prima persona della propria sicurezza. È questo il quadro che emerge dall’ultimo grande sondaggio di opinione pubblica globale dell’European Council on Foreign Relations (Ecfr), che fotografa un’Europa più pessimista ma anche più orientata al riarmo e all’autonomia strategica.
I risultati sono contenuti nel report “How Trump is making China great again—and what it means for Europe”, basato su un’indagine condotta nel novembre 2025, a un anno dalla rielezione di Donald Trump. Il sondaggio ha coinvolto 25.949 intervistati in 21 Paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Russia, India, Turchia, Brasile, Sudafrica, Corea del Sud e 13 Stati membri dell’Unione europea, ed è stato realizzato in collaborazione con l’iniziativa Europe in a Changing World dell’Università di Oxford.
In Italia, l’indagine è stata condotta su 1.501 intervistati tra il 5 e il 19 novembre 2025, nell’ambito del campione europeo.
In tutta l’Unione europea — inclusi Paesi come l’Italia — l’opinione pubblica si sta adattando a una realtà in cui la leadership americana è percepita come meno affidabile, l’ascesa della Cina appare inevitabile e l’Europa è costretta a confrontarsi con la propria fragilità strategica. Queste percezioni influenzano direttamente i dibattiti interni su spesa per la difesa, autonomia strategica e ruolo globale dell’Europa.
Nelle principali potenze medie, gli intervistati prevedono che l’influenza globale della Cina, già significativa, continuerà a crescere nel prossimo decennio. Questa convinzione è particolarmente diffusa in Sudafrica (83%), Brasile (72%) e Turchia (63%).
All’interno dell’Ue, la maggioranza ritiene che nei prossimi dieci anni la Cina diventerà leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici e nelle tecnologie per le energie rinnovabili, una percezione che si è rafforzata rispetto a due anni fa.
In diversi Paesi, Pechino è ampiamente vista come un partner necessario o un alleato: Sudafrica (85%), Russia (86%) e Brasile (73%). Pur riconoscendo il crescente peso geopolitico della Cina e la sua leadership nei settori più innovativi, pochi sembrano temere questa traiettoria.
Solo in Ucraina (55%) e in Corea del Sud (51%) la maggioranza degli intervistati considera la Cina un rivale o un avversario. Altrove, le aspettative indicano un rafforzamento delle relazioni con Pechino, in particolare in Sudafrica (71%), Brasile (52%), Russia (46%) e Turchia (46%).
La maggior parte degli intervistati non si aspetta che gli Stati Uniti scompaiano come potenza globale. Washington è ancora ampiamente considerata influente e destinata a mantenere un ruolo rilevante.
Tuttavia, in Cina (34%), nell’Ue (37%), in Ucraina (32%) e persino negli Stati Uniti stessi (43%), non esiste una maggioranza che preveda un’ulteriore crescita dell’influenza americana nel prossimo decennio.
Circa un intervistato su quattro in Cina, Russia, Ucraina e Stati Uniti prevede un declino dell’influenza globale americana. Nell’Ue, il cambiamento è particolarmente netto: solo il 16% dei cittadini europei considera oggi gli Stati Uniti un alleato, mentre il 20% li vede come un rivale o un nemico.
Altrove, la percezione dell’America non crolla improvvisamente, ma si deteriora in modo costante. Con il miglioramento delle opinioni sulla Cina, gli Stati Uniti hanno perso terreno come alleato preferito in quasi tutti i Paesi analizzati. L’India rappresenta un’eccezione parziale, con quote simili di intervistati che considerano alleati sia gli Stati Uniti (54%) sia la Russia (46%).
Nella maggior parte dei Paesi, le aspettative nei confronti di Trump si sono ridimensionate. Rispetto a un anno fa, sono meno numerose le persone che ritengono la sua rielezione positiva per i cittadini americani, per i propri Paesi o per la pace globale.
In India, ad esempio, la percentuale di intervistati che considerava la vittoria di Trump positiva per il proprio Paese è scesa bruscamente dall’84% alla fine del 2024 al 53%. In diversi contesti nazionali, il sentimento è passato da un consenso ampio a una critica marcata.
Allo stesso tempo, minoranze significative in India (63%), Turchia (50%), Cina (46%) e Ucraina (43%) concordano sul fatto che Trump abbia comunque difeso con successo gli interessi americani sulla scena internazionale.
Con il mutare degli equilibri di potere globali, anche la percezione dell’Europa sta cambiando, talvolta in modo netto. Il cambiamento più radicale si registra in Russia, dove la maggioranza degli intervistati considera ora l’Europa un avversario (51%), in aumento rispetto al 42% dell’anno precedente.
Parallelamente, la percezione russa degli Stati Uniti si è ammorbidita, mentre l’amministrazione Trump ha cercato di ristabilire relazioni più distese con Vladimir Putin. Solo il 37% dei russi considera oggi gli Stati Uniti un avversario, in calo rispetto al 48% dello scorso anno e al 64% di due anni fa.
La dinamica opposta è visibile in Ucraina. Gli ucraini che un tempo vedevano Washington come principale alleato guardano ora soprattutto all’Europa. Quasi due terzi (62%) si aspettano un rafforzamento delle relazioni con l’Ue, contro il 37% che dice lo stesso degli Stati Uniti. Mentre il 39% considera l’Ue un alleato, solo il 18% attribuisce questa qualifica agli Usa.
La percezione di Washington come alleato è diminuita sensibilmente nell’ultimo anno, mentre quella dell’Ue è rimasta relativamente stabile.
Anche in Cina la percezione dell’Europa è in evoluzione. Alla domanda se le politiche dell’Ue verso Pechino siano simili a quelle degli Stati Uniti, la maggioranza degli intervistati cinesi (55%) risponde oggi che sono diverse, mentre negli anni precedenti prevaleva l’opinione opposta.
Questa distinzione è rilevante: mentre il 61% dei cinesi considera gli Stati Uniti una minaccia, solo il 19% dice lo stesso dell’Ue. Ciò non indica disinteresse verso l’Europa. Al contrario, la Cina è uno dei pochi Paesi in cui la maggioranza (59%) considera l’Ue una grande potenza.
L’Europa è sempre più vista come un partner (46%), mentre gli Stati Uniti sono percepiti principalmente come un rivale (45%). Nella percezione pubblica cinese, l’Europa emerge come un polo autonomo in un mondo realmente multipolare, non più dominato dall’America.
Nonostante la retorica di Trump, l’opinione pubblica americana sull’Europa non ha subito cambiamenti radicali. La visione prevalente negli Stati Uniti (40%) continua a considerare l’UE un alleato.
Quasi la metà degli americani (49%) concorda con l’affermazione secondo cui “la sicurezza europea è anche sicurezza americana”, mentre solo il 29% è in disaccordo. Più della metà (54%) considera la guerra della Russia contro l’Ucraina una minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti.
Gli europei si distinguono a livello globale per il loro pessimismo sul futuro. Quasi la metà dubita che gli anni a venire porteranno benefici ai propri Paesi (49%) o al mondo nel suo complesso (51%).
Una pluralità di cittadini dell’Ue (46%) non ritiene che l’Unione sia sufficientemente forte da negoziare alla pari con Stati Uniti o Cina, una quota in aumento rispetto al 42% del 2024. La retorica ostile verso l’Europa da parte di Trump e Putin può aver contribuito a questa percezione, soprattutto quando viene ripresa da partiti populisti e nazionalisti nel continente.
Allo stesso tempo, gli europei esprimono forti preoccupazioni sul piano della sicurezza: il timore di un’aggressione russa (40%), di una grande guerra europea (55%) e dell’uso di armi nucleari (57%). Queste ansie si riflettono nelle preferenze politiche, con un ampio sostegno all’aumento della spesa per la difesa (52%), alla reintroduzione della coscrizione obbligatoria (45%) e persino allo sviluppo di una deterrenza nucleare europea (47%).
Per Ivan Krastev, presidente del Centre for Liberal Strategies, “la divisione dell’Occidente si avverte in modo più acuto in Europa e in ciò che gli altri pensano dell’Europa. Per i decisori politici europei, la sfida ora è come vivere in un mondo veramente multipolare, che molti europei hanno a lungo immaginato, ma che ora cominciano a temere”.
Secondo Mark Leonard, direttore di Ecfr, “questo sondaggio mostra come il mondo pensi che l’Occidente sia morto. Gli europei non vedono più l’America come un alleato”. “Gli ucraini – continua – ora guardano a Bruxelles piuttosto che a Washington per ottenere sostegno e i russi vedono l’Europa, e non l’America, come il loro più grande nemico”. E in definitiva: “La campagna di Trump per mettere l’America al primo posto l’ha resa meno popolare tra gli alleati e ha contribuito a mettere la Cina in pole position”.
Timothy Garton Ash, storico, spiega che “gli europei stanno finalmente aprendo gli occhi sulla dura realtà di un mondo post-occidentale. Rendendosi conto di non poter più contare sugli Stati Uniti per la loro sicurezza, sulla Cina per la loro prosperità o sulla Russia per le loro forniture energetiche, si chiedono — e dubitano — se possano contare su se stessi”.





Fare oltre il proprio meglio, in giapponese, si ritrova nella parola “ganbaru”. Così come con “meraki”, concetto greco relativo allo sforzo e all’impegno, anche in Giappone Giorgia Meloni pesca nella tradizione locale per raccontare come due nazioni e due leader trovano un terreno comune fatto essenzialmente di voglia di mettere in pratica politiche utili.
Da un lato Meloni punta verso il rafforzamento del concetto di “Italia globale” che investe evidentemente su un quadrante altamente strategico come l’Idopacifico. Dall’altro l’empatia di sorrisi, intese e strette di mano fra Giorgia Meloni e Sanae Takaichi, che molto hanno in comune. Il vertice di Tokyio dice essenzialmente due cose: che la presenza di Roma a quelle latitudini è vista non più come elemento sporadico, ma strutturata e dalle costanti interlocuzioni (politica + imprese); e che lo speciale partenariato in piedi tra i due Paesi può registrare una ulteriore accelerazione grazie alle affinità delle due leader. Lo si evince sia dalla dichiarazione congiunta che da alcuni concetti manifestati in occasione del vertice.
GANBARU TRA MELONI E TAKAICHI
“Siamo le prime due donne a guidare i loro popoli, un grande onore e soprattutto una grande responsabilità. Responsabilità che penso possiamo onorare facendo leva su quell’approccio che nella cultura giapponese si riassume con una parola che io considero molto affascinante che è ganbaru. Non vuol dire solamente fare del proprio meglio, significa fare più del proprio meglio, cioè ambire a superare sempre i propri limiti, non accontentarsi mai di dove si è arrivati”. Questo il concetto cerchiato in rosso da Meloni incontrando la premier giapponese. Lo scenario resta instabile, per questa ragione la cooperazione va rafforzata. Parte da questo assunto Meloni quando mette l’accento sul perché un così denso fil rouge tra Roma e Tokyo non può che essere destinato al potenziamento. Quando tocca temi come la rivoluzione digitale, la transizione energetica, la frammentazione geo-economica, l’instabilità che da eccezione sta diventando sistema, intende distendere una cornice valoriale che racconta le potenzialità tra i due Paesi, e il 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche rappresenta un’occasione per “celebrare quello che abbiamo fatto in questi 160 anni, ma interrogarci su cosa ancora di meglio possiamo fare nei prossimi 160″.
I PUNTI IN COMUNE
I punti in comune sono numerosi: intanto sono le prime donne a guidare i governi delle rispettive nazioni, hanno una base valoriale conservatrice con un punto di riferimento come Margareth Thatcher (la cui fondazione lo scorso dicembre ha premiato Meloni nel corso di un gala a Roma), vantano una ampia gamma di cooperazione già impostata tramite il Piano d’azione bilaterale 2024-2027 tramite cui le relazioni tra Giappone e Italia sono definite un “Partenariato Strategico Speciale”. Il primo banco di prova è, fisiologicamente l’area dell’Indo-Pacifico incastonata all’interno del concetto di FOIP, ovvero Indo-Pacifico Libero e Aperto basato sullo stato di diritto. Per questa ragione hanno espresso il loro obiettivo di promuovere un’ulteriore collaborazione tra FOIP e Mediterraneo Globale.
LA COOPERAZIONE
La cooperazione in materia di difesa vede già un dialogo costante tra i vertici militari, con un addestramento congiunto ed esercitazioni militari all’interno dell’Accordo di Acquisizione e Interservizio (ACSA), entrato in vigore nel settembre scorso. Sul Gcap (il Programma Global Combat Air per sviluppare congiuntamente con il Regno Unito i velivoli da combattimento di nuova generazione) è stato rammentato l’obiettivo di consegnare il primo velivolo nel 2035, ma non finisce qui perché Meloni e Takaichi hanno spiegato di voler andare anche oltre, tramite nuovi equipaggiamenti e tecnologie per la difesa. Ciò è intimamente connesso ad altri due temi: il cosiddetto ordine economico libero ed equo, dove le garanzie di sicurezza sono architrave imprescindibile e riguardano le singole catene di approvvigionamento; e le politiche che danneggiano l’economia, come pratiche non di mercato, restrizioni all’esportazione, rischi per le componenti essenziali, distorsioni del mercato, sovraccapacità, concorrenza sleale.
Questa la ragione per cui Italia e Giappone sono già assieme per la cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale in settori avanzati come la robotica AI, i semiconduttori e la biofabbricazione, partenariati industriali, investimenti diretti e flussi commerciali in entrambe le direzioni, soprattutto nei settori ad alta tecnologia. Le aziende e start-up giapponesi e italiane dialogheranno intensamente. Sugli scudi l’ItalyJapan Business Group che provvederà all’ulteriore approfondimento delle relazioni economiche tra Giappone e Italia. Anche lo spazio al centro delle intese, come le collaborazioni già consolidate come quella tra l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e la Japan Aerospace Exploration che sono la base programmatica per future intese come nuove partnership commerciali, industriali, di sicurezza e scientifiche, nonché per coordinare nei pertinenti forum multilaterali la promozione dell’uso pacifico, responsabile e sostenibile dello spazio extra-atmosferico.
Non poteva mancare il tema del Mar Cinese dove spicca il no al tentativo unilaterale di modificare lo status quo con la forza. Prima Meloni e poi Takaichi hanno rinnovato la loro determinazione a continuare a lavorare insieme per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, poi hanno ribadito il carattere universale e unitario della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare definito nella dichiarazione congiunta “il quadro giuridico che regola tutte le attività negli oceani e nei mari”.
(Foto: Governo.it)



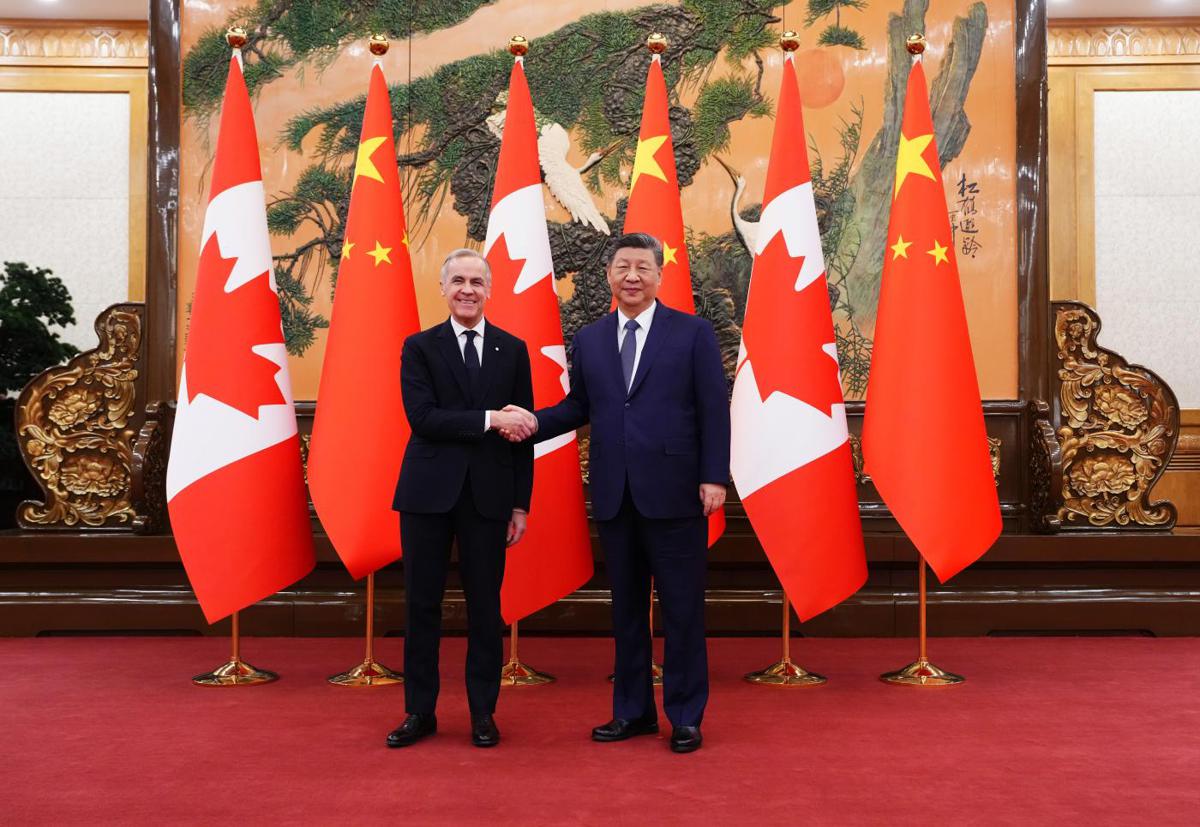







In un momento di difficoltà e di crisi internal al blocco occidentale, Russia e Cina rimangono una minaccia costante nell’Artico. Tanto da spingere la Nato a rafforzare in modo sempre più visibile la propria presenza nella regione. È in questo contesto infatti che si inserisce la decisione di diversi Paesi europei di inviare personale militare sull’isola, segnando una risposta diretta alle dinamiche di competizione geopolitica che attraversano il Grande Nord.
Secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, Mosca e Pechino stanno “utilizzando sempre più l’Artico per scopi militari”, mettendo in discussione la libertà delle rotte di trasporto, di comunicazione e di commercio. Un’evoluzione che, nelle parole del ministro, non può essere accettata dall’Alleanza Atlantica, determinata a difendere un ordine internazionale basato su regole condivise. La Germania guiderà una missione di ricognizione in Groenlandia sotto leadership danese, affiancata da contingenti di Francia, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi ed Estonia. L’iniziativa precede l’esercitazione “Arctic Endurance”, destinata a diventare un appuntamento permanente nel calendario Nato. Si tratta di una mossa che rafforza il segnale politico e militare di coesione europea in un’area sempre più percepita come vulnerabile alla competizione tra grandi potenze, in cui la presenza russa e cinese viene letta dagli alleati come una sfida diretta alla sicurezza collettiva, soprattutto per quanto riguarda il controllo delle linee di comunicazione e dei flussi commerciali. L’importanza del tema è stata sottolineate anche dalle parole del presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui l’Europa si trova in un mondo in cui “poteri destabilizzanti si sono risvegliati” e in cui certezze consolidate per decenni vengono rimesse in discussione. Una riflessione che va oltre la sola minaccia russa o cinese e che tocca anche la solidità delle alleanze tradizionali.
Il dossier groenlandese, infatti, si colloca all’incrocio tra competizione con Mosca e Pechino e tensioni interne al campo occidentale. Le rivendicazioni statunitensi sull’isola, motivate dal presidente Donald Trump con esigenze di sicurezza nazionale, hanno aperto una frattura diplomatica con la Danimarca e alimentato il timore che la questione possa minare la coesione della Nato. La crisi si è progressivamente intensificata nelle ultime settimane, culminando in un incontro ad alto livello alla Casa Bianca tra rappresentanti statunitensi, danesi e groenlandesi che non è riuscito a colmare le profonde divergenze politiche sul futuro dell’isola, e con le dichiarazioni del presidente Donald Trump sull’acquisizione della Groenlandia come priorità di sicurezza nazionale per gli Stati Uniti. Secondo Mike Sfraga, già ambasciatore statunitense per gli affari artici, un’eventuale annessione o acquisizione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti rischierebbe di “fare a pezzi l’alleanza”, proprio mentre l’unità sarebbe più necessaria per affrontare le pressioni di Russia e Cina.
In questo contesto, l’iniziativa europea assume un duplice significato. Da un lato, rafforza la deterrenza nei confronti di attori esterni che stanno ampliando il loro raggio d’azione nell’Artico. Dall’altro, rappresenta un tentativo di riaffermare il ruolo della Nato come architrave della sicurezza regionale, nonostante le tensioni politiche interne e le divergenze strategiche tra alleati. La scelta di condurre la missione sotto guida danese e all’interno di un quadro multilaterale è indicativa della volontà europea di evitare escalation unilaterali, mantenendo l’Artico all’interno di una logica di cooperazione difensiva. Ma dietro all’iniziativa c’è anche la chiara intenzione di inviare a Mosca e Pechino un messaggio sul fatto che l’Alleanza Atlantica consideri la regione artica un fronte strategico, e che non intenda cedere spazio a iniziative che possano alterarne l’equilibrio.


L’Ucraina ha un nuovo ministro della Difesa. La Verkhovna Rada ha infatti nominato come detentore della carica il trentaquattrenne Mykhailo Fedorov, figura di primo piano dell’innovazione tecnologica ucraina e fino a oggi vice primo ministro e ministro della Trasformazione digitale. Fedorov prende il posto di Denys Shmyhal, spostato al dicastero dell’Energia dopo che uno scandalo di corruzione aveva portato alla rimozione del precedente ministro nel novembre scorso.
Un cambio ai vertici che segnala come l’innovazione in ambito militare assumerà un’importanza ancora maggiore di quella già avuta fino ad ora nell’apparato della difesa di Kyiv. “È impossibile combattere con nuove tecnologie affidandosi a una vecchia struttura organizzativa”, ha affermato lo stesso Fedorov nel giorno della nomina, annunciando un programma di riforme profonde dell’apparato militare. L’obiettivo dichiarato è una trasformazione sistemica che includa la riforma militare, il miglioramento delle infrastrutture al fronte, l’eradicamento della corruzione, la lotta alla disinformazione e la promozione di una nuova cultura della leadership fondata su fiducia e risultati.
Fedorov non è completamente estraneo al mondo della difesa. Già prima della nomina, il neo-ministro della Difesa era fortemente coinvolto nel settore, contribuendo al lancio del progetto “Army of Drones” e del cluster tecnologico Brave-1, pensato per sostenere l’industria ucraina della difesa attraverso finanziamenti statali alle aziende produttrici di armamenti. Il suo lavoro è stato determinante anche nello sviluppo delle capacità unmanned e counter-unmanned.
Secondo quanto riferito da Fedorov, tra i compiti assegnatigli dal presidente Zelensky figurano il rafforzamento della difesa aerea (definita come la priorità dal leader ucraino), il blocco delle avanzate terrestri russe, la gestione delle problematiche logistiche, l’intensificazione degli attacchi asimmetrici e cibernetici contro il nemico e la sua economia, nonché l’aumento del costo complessivo della guerra per Mosca “per fermare il nemico con la forza”.
La nomina di Fedorov si inserisce in un più ampio rimpasto di governo e delle forze dell’ordine annunciato all’inizio del mese da Zelensky, con l’obiettivo di rafforzare il Paese mentre il conflitto si protrae. “Il nostro Paese ha due strade”, ha dichiarato il presidente. “La prima è pacifica e diplomatica, ed è oggi la nostra priorità. Vogliamo porre fine alla guerra. Ma se la Russia la bloccherà e i partner non la costringeranno a fermarsi, ci sarà un’altra strada: difenderci. E allora serviranno forze nuove”.






Un intervento militare americano contro l'Iran è probabile. Lo dicono due fonti europee citate da Ynet, con una che lo ritiene possibile entro le prossime 24 ore. Secondo una fonte israeliana, il presidente Donald Trump avrebbe preso la decisione di intervenire, anche se l'obiettivo e i tempi dell'attacco non sarebbero ancora chiari.











